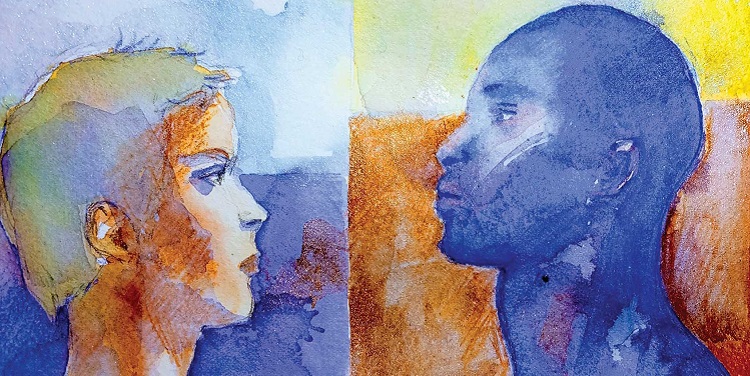Paolo Parrottino*
L’Io e l’identità. Uno, nessuno e centomila: la natura multiforme e strutturalmente relazionale dell’identità personale si intreccia con la libertà e l’imprevedibilità umane
“Chi, scendendo in se stesso, non si ferma
alla quiete dei primi ripari,
ma decide di condurre l’avventura
fino in fondo, viene ben presto
precipitato lontano da ogni rifugio.”
E. Mounier, Il Personalismo
“Così volevo io esser solo. Senza me. Voglio dire senza quel me che io già conoscevo, o che credevo di conoscere. Solo con un certo estraneo, che già sentivo oscuramente di non poter più levarmi di torno e ch’ero io stesso: l’estraneo inseparabile da me!” (1).
L’esperienza dell’estraneità a se stessi è il tema centrale del celebre racconto di Luigi Pirandello Uno, nessuno e centomila. Attraverso il materiale, filosoficamente spurio, di un grande letterato come Pirandello, si può esemplificare in maniera efficace la dinamicità dell’identità personale, costellata da una miriade di personaggi, uno per ogni relazione intrattenuta.
La molteplicità di tali personaggi, però, non è da intendersi come il segno di una finzione, di rapporti inautentici, quanto piuttosto come la manifestazione più naturale della multiformità identitaria, considerata nell’esistenza concreta di un singolo, il quale, intrattenendo numerose relazioni, costruisce con l’altro i vari personaggi che compongono la propria personalità, ossia la sua identità personale in un dato periodo storico (2).
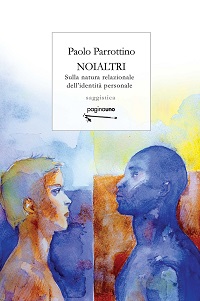
Nel celebre romanzo di Pirandello, il protagonista misconosce tale struttura dell’universo identitario, ribellandosi a personaggi che non sente propri, in quanto accreditatigli forzatamente da altri. Il suo tentativo di fuga, però, ignorante delle dinamiche identitarie, non avrà altro esito che quello di riportarlo alla situazione di partenza.
Vitangelo Moscarda, che è il protagonista del capolavoro pirandelliano, conduce una vita disinteressata, scevro da qualsiasi impegno mantiene se stesso, Dida – sua moglie – e la cagnolina Bibì, nell’agiatezza di chi, ricco erede di un’importante banca di Richieri (3), può permettersi di delegare i propri affari agli amici Stefano Firbo e Sebastiano Quantorzo.
Per i compaesani, però, egli non era affatto Vitangelo Moscarda, piuttosto era l’usurajo (4): così lo vedevano e così lo chiamavano. Nulla a che vedere con il sempliciotto Gengè – questo il nome datogli da sua moglie – “sciocchino ma carino” (5) un buon marito tutto sommato, con i propri gusti e i propri modi di pensare. Un peccato, però, che di quel Gengè, Vitangelo non sapesse nulla, e nulla avessero a che fare i suoi gusti e i suoi pensieri con i gusti e i pensieri di Gengè, di quell’estraneo. È ovvio che, allo stesso modo, Vitangelo Moscarda era uno per l’amico Firbo, e un altro per il Quantorzo.
Tutti Vitangeli estranei al protagonista del racconto: un’identità multiforme, una per ciascun interlocutore, la cui presa di coscienza porterà Moscarda alla pazzia.
Tutto ebbe inizio da uno specchio e da un dolorino al naso…
Continua a leggere acquistando il numero 92
copia digitale PDF: 3,00 euro
copia cartacea: 12,00 euro
* Pubblichiamo l’introduzione, a firma dell’autore, al testo Noialtri. Sulla natura relazionale dell’identità personale, Paolo Parrottino, Edizioni Paginauno, 2025