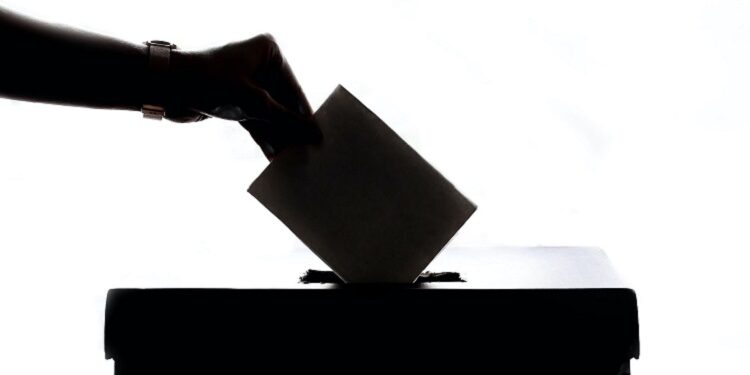La riforma della legge elettorale: sistema nuovo, trucchi vecchi
Il 4 dicembre scorso la Corte Costituzionale ha bocciato la legge elettorale italiana, il cosiddetto Porcellum. “La Corte costituzionale – si legge nella nota diffusa al termine della Camera di consiglio – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della legge n. 270/2005 che prevedono l’assegnazione di un premio di maggioranza – sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica – alla lista o alla coalizione di liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti e che non abbiano conseguito, almeno, alla Camera, 340 seggi e, al Senato, il 55% dei seggi assegnati a ciascuna regione. La Corte ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che stabiliscono la presentazione di liste elettorali ‘bloccate’, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza”.
La logica della Corte è facilmente comprensibile sulla base non soltanto dello spirito, ma addirittura della lettera della nostra carta costituzionale. Il che pone non pochi interrogativi, fra i quali come sia stato possibile nel 2005 approvare una legge di questo tipo senza che a nessuno (nemmeno al presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi) giungessero sentori di incostituzionalità, e come sia possibile ancora oggi proporre modelli che vanno nella identica direzione delle norme cassate dalla Corte (1).
I premi di maggioranza
Battezzata come “una porcata” dal suo stesso ideatore, il leghista Roberto Calderoli, in una celebre intervista a Giovanni Sartori (da cui l’appellativo Porcellum), la legge 270/2005 sostituisce i collegi uninominali del Mattarellum (la precedente legge elettorale, basata su un sistema sostanzialmente maggioritario), con circoscrizioni plurinominali di ampie dimensioni (27 alla Camera e 18 al Senato), in cui i seggi disponibili vengono ripartiti proporzionalmente fra le liste concorrenti. Per chiarire la terminologia, un sistema elettorale si dice ‘maggioritario’ quando il voto si esprime in collegi uninominali (che eleggono cioè un solo rappresentante), nei quali sale in carica il candidato che ottiene la maggioranza (assoluta o relativa a seconda delle varianti) dei suffragi, ragion per cui si attribuisce in genere a questo metodo, in virtù della sua netta separazione fra ‘vincitori’ e ‘perdenti’, il pregio di garantire la governabilità; viceversa si dice ‘proporzionale’ il sistema che si esprime in collegi plurinominali (che eleggono cioè più rappresentanti, anche di liste diverse), in cui i seggi disponibili vengono aggiudicati – proporzionalmente, appunto – sulla base dei voti raccolti: il partito (o la coalizione) che ottiene, per esempio, il 60% dei consensi ottiene il 60% dei seggi, quello che ha ottenuto il 20% dei consensi il 20% dei seggi e così via; evidentemente il sistema proporzionale garantisce che tutti (o quasi) gli orientamenti politici degli elettori vengano rappresentati.
Per cercare, almeno in apparenza, di ottenere i pregi di entrambi i sistemi (governabilità e rappresentanza), gli ideatori del Porcellum hanno pensato di affiancare alla base proporzionale un potente correttivo, il premio di maggioranza, calcolato in modo diverso per i due rami del Parlamento. Alla Camera dei deputati il premio scatta qualora la coalizione, o il partito, che ha ottenuto il maggior numero di voti non raggiunga la soglia dei 340 rappresentanti (su un totale di 630), e allora glieli aggiudica ‘a tavolino’: il vincitore a livello nazionale, a prescindere dal risultato elettorale, può dunque contare almeno sul 55% dei deputati; al Senato invece il premio, pur garantendo la stessa percentuale di seggi (il 55%), viene calcolato su base regionale, non nazionale, cioè viene assegnato regione per regione allo schieramento che ha ottenuto più consensi: da qui la possibile schizofrenia parlamentare (puntualmente verificatasi), con maggioranze di segno diverso alla Camera e al Senato.
La domanda sorge spontanea: se quel che si voleva erano maggioranze di governo blindate, perché scegliere il metodo proporzionale? E se invece si intendeva privilegiare la rappresentatività, perché introdurre premi di maggioranza (ancorché incongrui)? Le conseguenze del peggiore degli esiti possibili, cioè ingovernabilità senza rappresentanza, è sotto gli occhi di tutti, eppure in questi otto anni la legge elettorale, disprezzata dai politici di ogni schieramento soltanto a parole, non è mai stata cambiata, né ci sono stati seri tentativi in questo senso. Certo molto ha pesato la posizione ‘conservativa’ della presidenza della Repubblica che ha preferito di volta in volta ricorrere in tutta fretta a governi tecnici o di interesse nazionale (e forse per questo la sua permanenza al Colle è stata prolungata fino a data da destinarsi), invece di prendere atto del fallimento della politica sia nel rappresentare che nel governare il Paese e stimolare la ricerca di percorsi alternativi. Strano però che un amante della nostra Carta come Napolitano non abbia mai avuto modo di rimarcare il fatto che, sebbene gli italiani abbiano in teoria tutti gli stessi diritti a prescindere dalle posizioni politiche (2), il premio di maggioranza del Porcellum (come, del resto, tutti i sistemi maggioritari) determina una sovra-rappresentanza parlamentare dei cittadini che hanno votato per il partito o lo schieramento che si è rivelato vincente, e specularmente una sotto-rappresentanza parlamentare (quando non una totale esclusione, come vedremo più avanti), di chi ha posizioni politiche minoritarie.
Da qui, a nostro avviso, il difetto di costituzionalità: i seggi in più attribuiti al vincitore con il premio di maggioranza vengono infatti presi da quelli che, in virtù del voto popolare, spetterebbero alle minoranze e ai loro elettori. Inoltre, dal momento che la Costituzione stabilisce che la funzione di governo del Paese spetti al presidente del Consiglio (nominato dal presidente della Repubblica) e ai suoi ministri, con la fiducia delle due Camere (3), non si capisce come mai l’onere di trovare un governo stabile debba essere trasferito in capo ai cittadini elettori, comportando per di più la lesione dei loro diritti fondamentali.
Le soglie di sbarramento
Se si analizza la legge 270/2005 nei dettagli (e, secondo un vecchio proverbio, il diavolo ama nascondervi la coda), si scopre un altro colpo basso alla sovranità popolare: la definizione dei criteri di esclusione, ossia le cosiddette ‘soglie di sbarramento’. Le soglie di sbarramento sono uno dei correttivi normalmente apportati ai sistemi proporzionali puri per evitare un’eccessiva frammentazione parlamentare, e stabiliscono il peso minimo che un partito deve raggiungere per ottenere la rappresentanza alle Camere. Il Porcellum impone un metodo di calcolo degli esclusi piuttosto complesso, ma sostanzialmente per ottenere seggi alla Camera ogni partito o lista deve raccogliere almeno il 4% dei voti nazionali, mentre ogni coalizione deve ottenere almeno il 10%, e in questo caso le liste collegate a una coalizione che abbia superato la soglia prescritta partecipano alla ripartizione dei seggi quando superano appena il 2% dei voti (cioè la metà di quelle che corrono da sole). Similarmente, per ottenere seggi al Senato ogni partito o lista deve ottenere almeno l’8% dei voti e le coalizioni il 20% (in questo caso su base regionale), mentre le liste collegate a una coalizione che abbia superato la soglia prescritta partecipano alla ripartizione dei seggi quando superano il 3% dei suffragi (qui il livello-soglia è addirittura più che dimezzato).
Una norma così concepita può avere un solo risultato: dal momento che i partiti minoritari si trovano nella condizione – per superare lo sbarramento – di ‘diluire’ la radicalità delle proprie posizioni, vuoi per aumentare il bacino potenziale di consenso (se corrono da soli), vuoi per confluire nelle grandi compagini centriste (di destra o di sinistra), pena la scomparsa dall’arco parlamentare, la varietà delle posizioni politiche rappresentate nelle istituzioni diminuisce drasticamente. Coincidenza strana (ma forse no), questo metodo ricorda molto da vicino quello della legge elettorale in vigore nella regione Toscana, che prevede meccanismi di sbarramento analoghi.
Le liste bloccate
Il secondo assetto normativo ritenuto incostituzionale dalla Corte, come abbiamo ricordato, è quello relativo alle liste bloccate, cioè all’impossibilità per l’elettore di indicare al momento del voto la sua preferenza per uno o più candidati: l’elezione dei parlamentari dipende quindi completamente dalle scelte e dalle graduatorie stabilite dalle segreterie dei partiti. In questo caso il vizio di incostituzionalità si può rintracciare nella violazione degli articoli 56 e 58 della Costituzione, nella parte in cui si indica, rispettivamente, che “la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto”, e che “i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto”.
Il suffragio diretto consiste nel diritto di tutti i cittadini di eleggere i propri rappresentanti senza deleghe o passaggi intermedi (viceversa il suffragio indiretto è il diritto dei cittadini di eleggere un gruppo ristretto di rappresentanti o delegati aventi diritto, a loro volta, a eleggere i componenti di un determinato organo, come avviene per esempio nelle elezioni presidenziali statunitensi). Con il Porcellum gli elettori non solo non possono scegliere direttamente i propri candidati alle Camere, come imporrebbe la Carta, ma paradossalmente non possono neppure decidere quali saranno le persone deputate a sceglierli: al momento del voto infatti i giochi sono ormai chiusi da tempo, il che è costituzionalmente inammissibile.
Danni collaterali?
Premi di maggioranza che comportano una fotografia della distribuzione del potere in Parlamento ben distante dalle intenzioni espresse dal Paese reale, soglie di esclusione costruite per tacitare il dissenso esterno alle grandi coalizioni, liste bloccate dalle segreterie per assicurarsi che gli eletti non siano fra quelli in grado di sparigliare i giochi, non stupisce che l’unico significativo risultato ottenuto dal Porcellum sia l’aumento dell’astensione.
I dati parlano chiaro: nel 2006 l’affluenza è stata pari all’83,6%, è passata nel 2008 all’80,46% ed è crollata al 75,1% nel 2013.
Un quarto degli italiani dunque non ha visto rappresentate le proprie opinioni politiche nelle liste presenti alle elezioni e ha deciso – parafrasando Indro Montanelli – di non turarsi il naso, ma qualora si sommino (correttamente) le percentuali degli esclusi a causa delle soglie di sbarramento (pari al 4,8% al Senato e 5,3% alla Camera), la quota del Paese che non trova rappresentanza parlamentare sfiora il 30%. Anche nel voto estero il ‘partito dell’astensione’ ha un peso importante: alla Camera, su 3.494.687 aventi diritto, gli elettori votanti sono stati solo 1.039.725, mentre per il Senato, su 3.149.501 aventi diritto, gli astenuti sono addirittura 2.202.478. Se si considera poi che nessuno dei governi espressi dai risultati elettorali del Porcellum è mai arrivato alla scadenza naturale del mandato (neanche quello del centrodestra stravincitore nel 2008), tanto che gli italiani sono stati chiamati alle urne tre volte in meno di sette anni, è lecito chiedersi se non fossero i ‘danni collaterali’ della legge 270/2005 a essere voluti, più ancora che la sua pasticciata governabilità. Infatti, nemmeno dopo la pronuncia della Corte costituzionale, i partiti sembrano intenzionati a fare marcia indietro.
Silvio che vai, Matteo che trovi
Se l’ispiratore del Porcellum è stato Silvio Berlusconi, è ormai chiaro che il ruolo di mattatore nel riformare la legge elettorale spetterà al nuovo segretario del Pd, il sindaco di Firenze Matteo Renzi. Il quale non ha intenzione di giocare coperto e ha subito messo in chiaro, con una lettera indirizzata ai leader dei principali partiti datata 2 gennaio 2014, quelle che lui considera le alternative percorribili. Per Renzi, la cui strategia politica sembra essere quella di trasformare il Pd in un brand (di quelli very cool), esisterebbero solo tre strade, frutto della sintesi (come si vedrà ben ragionata) delle ipotesi avanzate dai diversi schieramenti, per superare l’impasse che si è creato dopo la pronuncia della Corte: ancora una volta, l’obiettivo dichiarato a parole è il bene del Paese, che si sostanzia nell’allontanare il più possibile lo spettro dell’ingovernabilità.
La prima strada, quella che Renzi manifestamente preferisce, sarebbe l’estensione al voto parlamentare della legge vigente per l’elezione dei sindaci dei grandi comuni: un modello che prevede un doppio turno di coalizione, con l’eventuale ballottaggio tra i due candidati migliori nel caso nessuno raggiunga la maggioranza assoluta dei consensi al primo turno; alla coalizione vincitrice della tornata elettorale spetterebbe il 60% dei seggi (il 5% in più rispetto al Porcellum), e quelli restanti verrebbero divisi proporzionalmente fra i perdenti, ma con una soglia di sbarramento innalzata al 5%. Il problema di questo modello è che non ci pare elimini i vizi di incostituzionalità: attribuire a chi vince una percentuale di seggi fissa, e per di più così elevata, a prescindere dall’esito elettorale presenta lo stesso identico problema del premio di maggioranza, cioè ‘scolla’ la composizione del Parlamento dal risultato reale del voto, senza dimenticare che una soglia di sbarramento del 5% in un Paese con posizioni frammentate come l’Italia sarebbe davvero deleteria per la rappresentatività delle istituzioni.
La seconda ipotesi renziana è quella di un Mattarellum ‘corretto’. In molti infatti hanno sostenuto come in presenza di una legge elettorale illegittima (il Porcellum), la soluzione più logica sarebbe ritornare al sistema di voto precedentemente vigente. Il Mattarellum (dal nome del suo ideatore Sergio Mattarella) era una legge mista (per 3/4 maggioritaria e per 1/4 proporzionale), elaborata dopo il crollo della prima Repubblica per archiviare una stagione segnata dal proporzionale puro e dall’estrema frammentazione del quadro partitico. Quello proposto da Renzi è invece un Mattarellum ‘modificato’: rimarrebbero i 473 collegi uninominali alla Camera (237 al Senato), equivalenti al 75% dei seggi totali, nei quali vincerebbe il candidato che ottiene la maggioranza relativa; verrebbe invece tolta l’assegnazione proporzionale del 25% dei collegi restanti, per ripartire i seggi residui tra un premio di maggioranza del 15% per il partito (o la coalizione di partiti) vincente (94 seggi alla Camera e 47 al Senato), e un “diritto di tribuna” per le minoranze pari al 10% del totale dei collegi (63 seggi alla Camera e 31 al Senato): il che significa che, a prescindere dal risultato, ai perdenti verrebbe riconosciuto almeno il 10% dei seggi.
Ed è qui che l’articolo di Erika Gramaglia (4) si è rivelato più profetico che mai: in aggiunta all’invenzione del premio di maggioranza, infatti, dobbiamo alla legge Acerbo del 1923 anche l’adozione, per la prima e unica volta, di un diritto di tribuna. Voluta da Benito Mussolini per assicurare al partito fascista una solida maggioranza parlamentare (anche a lui stava a cuore la governabilità), essa disponeva infatti che il partito che avesse ottenuto la maggioranza relativa (e comunque non meno del 25%) dei voti validi a livello nazionale si sarebbe aggiudicato i 2/3 dei seggi totali (cioè il 66% del Parlamento), mentre alle opposizioni era destinato 1/3 dei seggi. Fu proprio grazie alla presenza del diritto di tribuna che i fascisti riuscirono a spacciare questo sistema elettorale come ‘democratico’, in quanto, si diceva, alle minoranze veniva garantita comunque una rappresentanza parlamentare del 33%, anche qualora i suffragi raccolti non arrivassero a 1/3 del totale. Come si vede, Mussolini era forse più garantista di Renzi. Peccato dover rimarcare che nel Mattarellum in salsa fiorentina viene riproposto quel premio di maggioranza che la Corte ha già decretato incostituzionale.
La terza strada praticabile, a giudizio del segretario del Pd, è quella che lui chiama “il sistema spagnolo”: un modello d’impianto proporzionale ma studiato per premiare i grandi partiti con una rappresentanza elevata e omogenea su tutto il territorio. Il sistema elettorale spagnolo è un proporzionale con circoscrizioni molto piccole, e per questo motivo ha dei forti effetti maggioritari, ossia premia i partiti maggiori. Nella versione proposta da Renzi, il territorio italiano verrebbe diviso in 118 piccole circoscrizioni, le quali dovranno esprimere un minimo di quattro deputati (inseriti in liste bloccate) e un massimo di cinque. Per ottenere l’accesso ai seggi bisognerà superare una soglia di sbarramento del 5% su scala nazionale, ed è inoltre previsto un premio di maggioranza pari al 15%, da assegnare alla lista più votata.
In verità questo sistema ha ben poco del modello spagnolo, dove la dimensione media delle circoscrizioni è di circa 7 seggi, ma con le notevoli eccezioni di Madrid (36 seggi), Barcellona (31) e altre province popolose, il che nelle circoscrizioni più grandi aumenta la proporzionalità del sistema, perché anche i partiti più piccoli possono ottenere l’elezione dei propri rappresentanti. Inoltre in Spagna la soglia di sbarramento è al 3% e si applica su base circoscrizionale, quindi incide in sostanza solo nelle due città maggiori (e questo ha permesso a numerosi partiti regionalisti di entrare in Parlamento).
Ma, a prescindere dagli elementi di differenza della terza strada renziana con il sistema spagnolo, non si può non notare che esso incorpora, ancora una volta, sia il premio di maggioranza sia le liste bloccate, già rifiutati dalla Corte Costituzionale. Per ricadere negli stessi errori di sempre, verrebbe da dire, tanto vale mantenere il Porcellum. Con un grosso dubbio a latere: Renzi ci è o ci fa?
(1) Della legge 270/2005 Paginauno si è già occupata nel numero 9/2008 con l’articolo Il circolo vizioso a firma di Erika Gramaglia, che attraverso il confronto fra le leggi elettorali che si sono succedute in Italia dal 1923 fino al Porcellum mette bene in luce non solo quali fossero le mire reali di chi aveva imposto correzioni sempre più spinte di ordine maggioritario ai criteri di selezione degli organi parlamentari, ma anche come il risultato finale ottenuto rappresentasse una sorta di ‘ossimoro giuridico’. Se ne consiglia la rilettura
(2) Costituzione della Repubblica italiana, art.3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
(3) Costituzione della Repubblica italiana, articoli 92-96
(4) Cfr. Erika Gramaglia, art. cit.