Non lo avrei mai creduto possibile, ma mi tocca fare anche questo: scrivere un epitaffio musicale. Per fortuna non si tratta del decesso di un artista, soprattutto un artista a me legato da motivi amicali e da una affetto di lunga durata. Non si tratta nemmeno della vita effimera di un gruppo nato per esprimere concetti musicali effimeri, come un qualunque gruppo pop. Diversi mesi or sono il mio carissimo amico e sodale Roberto mi ha comunicato che aveva intenzione di chiudere l’esperienza con il suo gruppo di musica antica, il Daedalus Ensemble, esperienza che rimontava al 1986. A me, per le solite distorsioni di una memoria presbite che cominciano a farsi sentire con gli anni, quella data sembrava dietro l’angolo. Quando ho realizzato che quasi nello stesso anno era nata mia nipote le cose hanno cominciato ad assumere un aspetto diverso. Ho dovuto rendermi conto che 33 anni non sono uno scherzo, ma si possono comunque prendere in modo scherzoso, oppure allegramente infischiandosene del trascorrere del tempo.
E meno male che il mio amico Roberto mi ha sempre ricordato queste parole: “Il passato non è altro che un luogo dell’immaginario collettivo. Che a lui si rivolga in virtù di un ancestrale bisogno di radici e d’identità o trasportato dalle ali del sogno di una paradisiaca età dell’oro, l’uomo dialoga costantemente con il suo passato. Storici e filosofi ne percorrono il tempo e le idee; musicologi e storici dell’arte ne rivelano le emozioni; i filologi ne studiano il linguaggio, i medici le malattie e la psicologia. Noi musicisti ne rinventiamo il suono. Vivisezionato in una selva infinita di ‘specializzazioni’, il passato è un costante oggetto di studio del presente che noi trasformiamo e interpretiamo a nostra immagine. ‘Il passato è morto’ (F. Petrarca) e non è altro che una dimensione del presente. In virtù di questo paradosso, il passato è e sarà sempre, attuale”. Aggiungo che è proprio grazie a questo paradosso che è possibile godersi musica scritta cinque secoli fa come se fosse musica di ieri. A patto, naturalmente, che chi la esegue abbia saputo reinventarla. E qui casca il proverbiale asino.
Dovrei considerare una re-invenzione del passato l’operazione fatta a suo tempo da Keith Emerson coi suoi Nice prima e col gruppo Emerson, Lake e Palmer poi quando editarono brani di Bach e Sibelius, o i “Qudri di una esposizione” di Mussorgsky? A prima vista si potrebbe rispondere positivamente, visto che le linee melodiche sono quelle che sono e cambiano semplicemente gli strumenti, sempre che si faccia salva l’attitudine che sta dietro a un’esecuzione. Di segno completamente opposto sono le risposte di coloro che praticano l’arte della filologia a oltranza, del tipo: Bach va suonato con gli strumenti del suo tempo (quindi vecchi di almeno trecento anni) o al massimo con le riproduzioni fedeli di quegli strumenti. Questa polemica si esaurisce in breve tempo. Di regola, ciò che interessa maggiormente è la capacità di ricostruire – a partire dalle informazioni disponibili anche in discipline diversissime – l’intero mondo dell’autore di questo o quel componimento. E visto che la musica a stampa è un’invenzione relativamente recente (si deve al marchigiano Ottiaviano Petrucci, autore nel 1501 del Harmonice Musices Odhecaton) si capisce bene come tutto ciò che sia stato scritto prima e anche una parte di ciò che è stato scritto dopo sia materia viva per la ricerca.
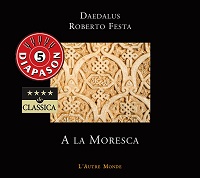
Il paziente artista che trascrive su pergamena la sua composizione originale lascia sulla pergamena stessa (spesso) annotazioni, cifre, simboli, persino macchie organiche che vanno tutte rilevate e interpretate dal musicista contemporaneo. Questi, prima di essere musicista esecutore, deve provvedersi di una serie di conoscenze multidisciplinari, manco fosse Sherlock Holmes. Ammesso che riesca a raccogliere abbastanza indizi, potrà utilizzare gli stessi nel momento dell’interpretazione e quindi differenziare quest’ultima da quella di altri sulla base di nuovi ‘indizi’ A questi ultimi bisognerà aggiungere una conoscenza quanto più vasta e articolata possibile delle arti di cui il compositore originario era a conoscenza (dalla poesia alla danza alla letteratura dei contemporanei ma anche e soprattutto quella greca e latina, ecc.). Il fatto di usare strumenti originali o dell’epoca come si vede conta ben poco, non qualifica cioè il modo in cui si interpreta e si esegue quella musica.
Sotto la guida di Roberto, che a suo tempo mi ha spiegato intrighi e labirinti del lavoro del musicista antico, che mi ha aiutato a distinguere tra un’esecuzione e l’altra, ho potuto sorridere dei vari ‘revival’ della musica cosiddetta popolare a metà anni ‘70 (tante villanelle napoletane eseguite in pubblico hanno come riferimento le versioni settecentesche degli originali cinquecenteschi) e soprattutto della presunzione di quanti hanno voluto proporre musiche la cui antichità si coniuga al tra-tra-tra-trapassato remoto. Ho sentito uno di questi ‘riesecutori’ affermare in ambito di concerto pubblico, con un forte accento da bauscia meneghino: «Uè, praticamènte facciamo musica del quaternàrio inferiore». Ed era vero. Cioè era vero che gli strumenti e l’ispirazione venivano da quella remota era. Ma io non avevo pagato il biglietto per assistere alla messa in musica di un’illazione. Polemico come ero allora, visto che il musicista era aperto a domande pre-concerto, gli dissi papale papale quello che pensavo e che era opportuno mi restituisse i soldi del biglietto, a me e agli altri. Vi risparmio gli esiti da rissa. A distanza di anni, però, sono convinto che quelle mie idee fossero e siano giuste e che, soprattutto, a voler fare un lavoro di ricerca serio e ben fatto, ci vogliano tempo e risorse. E qui casca il secondo proverbiale asino.
Quante etichette o produttori musicali sono disponibili a pagarmi la ricerca presso conservatori e/o biblioteche specializzate perché possa studiarmi i manoscritti originali? Quanti mettono in conto i mesi di ricerca che devo spendere per mettere a fuoco quanto meno i dettagli dell’ambiente culturale in cui si muove un autore antico? Non parliamo poi delle prove con i musicisti del mio gruppo a cui devo spiegare e trasmettere tutto quello che ho studiato, oltre al lavoro di trascrizione e stampa (fortunatamente oggi facilitato da appositi software) delle parti di ognuno. Se il disco che alla fine viene stampato viene pagato a corpo (cosa più comune) cioè una volta per tutte, amen. Ma se per caso devo aspettarmi un ritorno dalle percentuali delle vendite, faccio prima a cambiar lavoro. Devo allora confidare nelle esibizioni dal vivo, e quindi magari assoldare qualcuno che mi faccia da agente e mi procuri ingaggi presso i festival specializzati in giro per l’Europa.
Evidentemente, dato che si tratta di eventi ‘specialistici’ e non di concerti pop di massa, quel festival dovrà aspettarsi un sostanzioso contributo pubblico, o un mix di contributo pubblico e sponsorizzazioni private, e che insomma non si aspetti ritorni dalla vendita dei biglietti, specie se deve spartirli con me. Se considerate quanto denaro pubblico viene investito in eventi non di massa, a partire dalla crisi finanziaria di una decina d’anni fa, vedrete che si tratta di somme che vanno via via decrescendo, sino quasi a scomparire. Sopravvivono solo gli eventi di massa organizzati da imprenditori privati. Ovviamente, la mia attività di musicista antico va a catafascio. Si salvano solo quelli della fascia super-alta, che magari hanno provveduto a mettere grano in soffitta nel periodo buono e che adesso possono resistere alla crisi anche con poco lavoro. Etichette come la Sony Classic hanno potuto lavorare e lavorano tuttora quasi a fondo perduto con la musica antica perché gli interessa mantenere una posizione di predominio nel mercato. E conseguentemente possono permettersi di commissionare opere inedite a musicisti di altissimo prestigio proprio per mantenere queste posizioni. Gli altri, dalle etichette agli artisti, devono arrangiarsi.
Dico tutto questo con l’amaro nel cuore perché la mia meravigliosa avventura con Roberto e i suoi Dedalus Ensemble ha occupato in maniera entusiasmante decenni della mia vita. Il canto del cigno di questo gruppo, che lo riconnette paro paro ai suoi esordi (Canzoni villanesche alla napoletana, Accent, 1995), è un altro dei prodotti meravigliosi dell’ingegno e della cura, dell’amore e della creatività di chi ci sta dietro. Il mio amico Roberto in quest’ultima opera, A la Moresca. Moresche e mascherate del Rinascimento, ha avuto la sfrontatezza e l’intelligenza di confrontarsi con un ambiente culturale che oggi viene vissuto come un antagonista, quello del mondo islamico, domandandosi: “Cosa cede il mondo islamico alla cultura e alla polifonia del Rinascimento? Quali immagini, quali icone, quali suoni? Al confine tra musica, danza e teatro la Moresca porta in scena i profumi esotici e il fascino di un lontano onirico e magico. Non più cappelli, ma turbanti; non più spade, ma scimitarre. Il sole di Napoli si confonde con le mezze lune d’oriente, l’oud col calascione. La moresca ama la festa e il Carnevale, lo scherzo, il lazzo, e Daedalus, al suo ritmo, canta i suoi trent’anni di successi e di avventure unendo la sua gioia alla vostra”.
Meglio di così non poteva finire. Questo CD celebra la pienezza della vita che comunica su ogni piano con mille altre vite, sparse in giro per il Mediterraneo, e comunica danzando e musicando. Citata per la prima volta in un documento trovato a Lerida, Spagna, nel 1156, la danza Moresca viene letta da alcuni studiosi come sopravvivenza di antichi riti consacrati al rinnovamento e alla primavera. Ma tale interpretazione cede presto il passo a quella che vede rappresentata spettacolarmente, in una danza armata, la lotta fra cristiani e musulmani. E anche tale interpretazione cede ben presto il passo alla realtà dei fatti. Se per gli studiosi del folklore la Moresca rievoca ancor oggi il contrasto tra cristiani e infedeli, per gli studiosi delle scienze sociali in senso allargato essa è invece vista come una raffinata forma spettacolare estremamente diffusa in tutte le corti, specie in quelle italiane, che comprende la mascherata, il ballo acrobatico, una maniera di danzare, saltare, camminare, parlare e gesticolare. Soprattutto, risulta abbastanza naturale che la Moresca venga interdetta in tempo di Quaresima e che sia invece diventata la danza tipica del Carnevale.
È allo spirito gioioso in questo periodo che corrisponde la fioritura sorprendente di molteplici attività spettacolari. Il suo spirito letterario è quello del comico, del leggero, del divertente. Il suo ritmo sempre uguale rende comprensibili a tutti i testi, infarciti naturalmente di giochi di parole, doppi sensi, allusioni salaci. La Moresca è associata a balli in costume e danze guerriere, rievoca esotismo come mistero, epiche gesta come campestri fatiche di contadini. La Moresca dà vita a danze di villani e di hebrei, di medici e chirurghi indiani, di ninfe e ruffiane, di scultori e calzolari; anima balli alla spagnola, alla francese, alla todescha, alla lombarda, alla fiorentina, all’uso di Etiopia. Diventa insomma, dalla metà del ‘400 e per due secoli in avanti, l’elemento fondamentale di ogni sorta di rappresentazione.
In tutte le corti italiane la Moresca diventa un elemento fondamentale di ogni celebrazione solenne del XV e XVI secolo. Si danza alla moresca per il matrimonio di Tristano Sforza e Beatrice d’Este (1455), per quello veneziano (1459) e quello senese (1465) di Galeazzo e Ippolita Sforza, per quello romano (1473) e quello urbinate (1474) di Eleonora e Federico d’Aragona. Lo si farà ancora cento anni più tardi, per le nozze di Guglielmo V, figlio di Alberto V, duca di Baviera, cerimonie dirette da Roland de Lassus. Ma è a Napoli che avviene la mutazione/adattamento più significativo. La danza guerriera dell’origine scompare e al suo posto troviamo la villanella, eseguita a tre voci, articolata su quinte parallele, con una ricca strumentazione, un universo poetico in cui vengono inseriti due nuovi personaggi come il saracino/turcho e la mora/turcha/pagana. Se il primo corrisponde all’icona del guerriero infedele, la seconda incarna una seduzione ancora più insidiosa di quella della villanella. Per gli abitanti delle corti e anche per i cittadini una semplice campagnola è già un quid di esotico, come il vagheggiamento di un mondo semplice, puro e intatto come quello contadino. A esso si va ad aggiungere il fascino esotico di una musica staccata dalla danza che suggerisce un ‘altrove’ indeterminato geograficamente, tanto che ‘la mora’ diviene un aggettivo adattabile al mondo arabo come a quello spagnolo.
In mezzo a questa mutazione troviamo di tutto: dalle onomatopee alle imitazioni di lingue e accenti stranieri, grida di mercanti e venditori, versi di animali come cani, asini, cuculi che dialogano in modo esilarante con gli strumenti. Troviamo soprattutto la Gatta. Da un lato è un personaggio della commedia dell’arte (a Venezia si chiama Gnaga) dall’altro è un travestimento che permette di indicare gesti e intonazioni vocali femminili, atteggiamenti seducenti e licenziosi senza incorrere in problemi con la legge; ed è per questo che specie a Venezia la Gatta/Gnaga era il travestimento prediletto degli omosessuali.
Siete tutti invitati ad assistere all’addio del Daedalus Ensemble di Roberto Festa mercoledì 28 agosto in Utrecht (un buon modo per terminare le ferie) presso la sala Tivoli Vredenburg. Il meraviglioso programma comprende: Moresca IV deta la Bergamasca, Giulio Cesare Barbetta; Gli amanti morescano, Adriano Banchieri; Festino nella sera del giovedì grasso, R. Amadino, 1608; Yo me soy la morenica, Anonimo; In Toledo una donzella, Anonimo; Villotte alla Napoletana a tre voci, G. Scotto, 1566; E vorria sapere, Anonimo, 1566; ‘St’ amaro core mio è diventato, Giovanni Domenico del Giovane da Nola, 1563; Vorria ca fosse ciaola, Anonimo, 1567; Moresca III deta il mattaccino, Giulio Cesare Barbetta, 1585; Li saracin’adorano lo sole, Anonimo, 1545; Si te credisse, Anonimo; O Lucia miau, miau, Roland de Lassus; Deh! La morte de mariteto, Perissone Cambio; Tu sai che la cornacchia, Anonimo 1537; Si li femmene, Anonimo, 1566; Moresca IV deta la Bergamasca, Giulio Cesare Barbetta, 1585.


