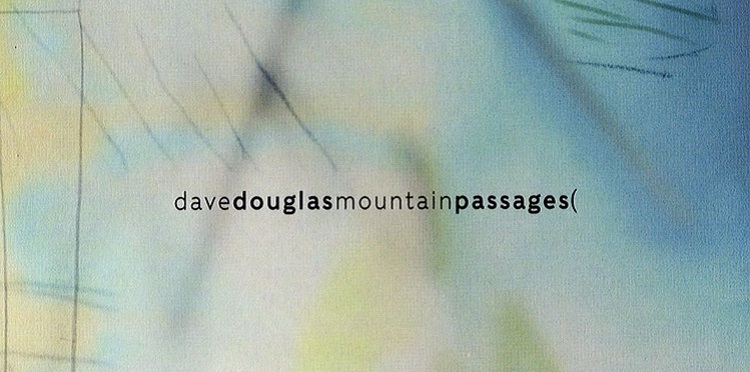Lo ammetto. Col passar del tempo credo di avere assunto atteggiamenti piuttosto snob. Complice la straordinaria performance di Toni Servillo ne La grande bellezza ho cominciato a disfarmi di cose e persone capaci solo di farmi perdere tempo e che non mi piacevano veramente. Alla fine dei conti, se questo è snobismo, ben venga: viaggerò più leggero. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata, usando il bisticcio, quella cadutami in testa stamattina dal Velux incautamente lasciato aperto sopra di me, e che ha dato origine a un frullamento di zebedei per il ritorno del maltempo dopo una domenica a dir poco splendida. Sì, quest’anno l’elemento acqua è stato decisamente fuori equilibrio qui dove vivo sul lago Maggiore (già piuttosto piovoso di suo). Potete immaginare quindi con quale umore abbia affrontato l’ennesima sciocchezza propagata dal web: la sfida a chi si fa la secchiata di acqua gelata più simpatica col pretesto di donazioni a favore della ricerca contro la Sla. Da bravo snob ho pubblicato immediatamente su Facebook una nota con video allegato dove un simpatico e malinconico palestinese diceva che avrebbe voluto volentieri sostenere una così nobile causa, non fosse stato per il fatto che da un lato non aveva un centesimo in tasca e che soprattutto gli israeliani avevano tagliato l’acqua a Gaza dall’inizio dell’invasione.
Non sono stato io a dirlo per primo, ne sarò l’ultimo a sostenerlo, complice – ripeto – l’abbondanza d’acqua attorno a me. Altro che oro nero: le prossime guerre saranno principalmente guerre per il controllo delle risorse idriche. Già Israele ha fatto sentire la voce grossa per le acque del biblico Giordano (già scarsine per conto loro), necessarie a un’intera regione. Voce e comportamenti ancora più intimidatori sono intercorsi e intercorrono tuttora tra Cina e India per il controllo delle acque provenienti dall’altopiano tibetano. Secondo le inquietanti informazioni presenti nel lavoro di Brahma Chellaney Water: Asia’s New Battleground (Georgetown Univ. Press, 2011), è l’Asia, con l’Africa a breve distanza, a essere il continente più secco della terra. Solo in Cina, negli ultimi anni, sono letteralmente scomparsi 28.000 corsi d’acqua, complici da un lato l’esplosione industriale e l’aumento di popolazione, dall’altro i cambiamenti climatici.
Non c’è più alcun dubbio che l’espansione demografica, unita alla crescita industriale e al riscaldamento globale, sia un cocktail micidiale per la produzione/riproduzione dei bacini acquiferi. Dall’altopiano tibetano nascono Indo, Brahmaputra, Irrawaddy, Salween e Mekong. Ho visto coi miei occhi nel 2011 la secca del lago Tonle Sap in Cambogia, dovuta al fatto che le acque del Mekong non risalivano più il suo emissario – il tutto impediva a centinaia di migliaia di contadini cambogiani di piantare il riso necessario al loro sostentamento. A febbraio di quest’anno i disordini scoppiati in Thailandia durante le elezioni presidenziali hanno fatto venire a galla la spaventosa corruzione della sorella dell’ex premier Shinawatra, accusata tra le altre cose di avere fatto sparire i rimborsi destinati ai contadini del nord per la secca dei fiumi destinati a irrigare i loro campi di riso. Un paradosso, visto che qualche mese prima una parte della capitale Bangkok era finita sotto l’acqua a causa di un’inondazione del fiume Chao Phraya.
A spanna, si calcola che le vite di circa 1,5 miliardi di persone dipendano dalle acque himalayane. Tra tutti i maggiori fiumi dell’Asia, il Gange è l’unico che non nasca in Tibet, ma all’India evidentemente il Gange da solo non basta. Favorita dal fatto d’avere invaso (mica fessi) il Tibet stesso nel 1949, la Cina si ritrova invece in casa le maggiore sorgenti d’acqua del globo e può vantare il minor tasso di dipendenza dall’acqua proveniente da Paesi esterni. Dato che il surriscaldamento atmosferico ha cominciato a incidere significativamente sui grandi ghiacciai himalayani, immediatamente la Cina ha cominciato a costruire enormi dighe per immagazzinare e poi convogliare verso il nord le acque tibetane a fini di irrigazione – piani da 80 miliardi di dollari, mica bruscolini.
Brahma Chellaney descrive l’Asia come il maggiore hub di irrigazione del mondo; l’80% dell’acqua è incanalata verso circa 220 milioni di ettari di terreni irrigati, due volte tanto quanto il resto del mondo messo insieme. Cosa che ha consentito a tutta l’Asia di diventare esportatore anziché importatore di cibo. E la prossima sfida è quella di produrre la stessa quantità di cibo con meno energia, terra e acqua. Da qui l’interesse di super-compagnie come la Toro (Usa) che produce sistemi di irrigazione a goccia super efficienti, nell’acquisizione di società cinesi come la Xiamen Xianfeng Water Saving Equipment (Xiamen, Cina), mettendo assieme tecnologia e software per coltivare più terra con meno acqua. Altro colosso è la Suez Environnement, scorporata da Gdf Suez (che rimane proprietaria al 35%) nel 2008. Nel corso dei decenni, Suez s’è fatta strada acquisendo quote di proprietà della Sichuan Dayi Water (Sichuan) in Aqua Macao (Macao), e Chongqing Water Group (Chongqing). Questo significa che si è completamente radicata nel trattamento delle acque e negli approvvigionamenti della Cina industriale: dal punto di vista degli utilizzatori, disponibilità, costi e qualità dell’acqua sono della massima importanza. Da ultima la Veolia Environnement, attraverso la sussidiaria Otv-Kruger, attiva nelle industrie dell’acqua da bere e del trattamento dei reflui sin dagli anni Ottanta.
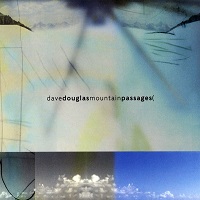
Attiva in 20 sul 34 province, la Veolia fornisce acqua a 43 milioni di cinesi: Hainan, Shanghai, Shenzhen e Tianjin hanno contratti di fornitura per periodi tra venti e cinquant’anni. Sono tutte compagnie che hanno beneficiato dell’apertura alle privatizzazioni, soprattutto per le infrastrutture di distribuzione idrica. Brahma Chellaney si augura che lo Stato cinese e le compagnie private non contraggano matrimoni d’affari sull’oggetto acqua: matrimoni che finirebbero male per l’approvvigionamento d’acqua fresca. E già spirano venti di guerra tra India e Cina a proposito dei progetti di costruzione di dighe sul Brahmaputra/Yarlung Tsampo che attraversa lo Stato indiano dell’Assam, entrando poi nel Bangladesh, dove confluisce nel Gange: per la Cina è fonte di energia idroelettrica per le industrie, per l’India è fonte di acqua da bere per la propria popolazione.
Circondato da tanta acqua, ho avuto bisogno di ritirarmi in montagna, almeno spiritualmente, per trovare del secco. Ho tirato fuori dal cassetto della memoria il magnifico festival Suoni delle Dolomiti del 2003 quando, dopo una lunga arrampicata al rifugio Boè in Valle di Fassa e poi al rifugio Brentei sopra Madonna di Campiglio, ho avuto la felicità di ascoltare il gruppo di Dave Douglas in una serie di performance per ottoni e batteria foriere di sogni fatti di roccia e fiori, con echi di vento sibilante, barriti di frane improvvise, risonanze turbinanti tra altissime pareti di dolomia. Per chi non lo conoscesse Dave Douglas (classe 1963, New Jersey) discende stilisticamente dalla scuola boppistica (da Clifford Brown a Miles Davis) e unisce alla profonda conoscenza della tradizione una costante ricerca verso il nuovo, che ha preso oggi le strade più diverse, dal klezmer al folk balcanico, dall’avanguardia più radicale alla sperimentazione elettronica passando attraverso il leggendario quartetto Masada di John Zorn, assieme a Greg Cohen e Joey Baron.
Narra il buon Douglas nelle note interne di Mountain Passages che per ispirarlo maggiormente a comporre musica da eseguire tra i 3 e i 4000 metri, gli organizzatori gli avevano inviato delle registrazioni di musica tradizionale ladina: “Come tutte le grandi musiche, essa faceva sorgere più domande che risposte, e soprattutto dondolava tra una solenne calma devozionale e un’indisciplinata celebrazione ad alto grado alcolico”.
Per nostra fortuna, a quanto pare, nessuno dei partecipanti a quella scampagnata d’alta quota e nessuno dei musicisti soffrì di mal di montagna. Forse qualcuno non era sufficientemente sensibile così da trasformare l’ilare e urbana performance di Douglas e dei suoi in calma devozionale. Molto più probabilmente parecchi tra gli astanti erano inclini a vedere di buon occhio tutto quel ben di Dio di suoni come l’ideale colonna sonora di una altrettanto sonora bevuta di schnapps e grappe ad alta quota. Ricordo abbastanza confusamente che oscillai in modo equanime tra i due atteggiamenti: sufficiente in ogni caso a contemplare la maestosità delle cime con Summit music, North point memorial e soprattutto Purple mountains majesty (la dolomia che si colora di rosa all’alba e al tramonto è impagabile), la tenerezza del ritratto della famiglia di un arrampicatore in Family of the climber, uno schnapps piuttosto contorto con innumerevoli rimandi ellingtoniani Gnarly schnapps che fa il paio con una prova (d’equilibrio) a 12 gradi (alcolici, suppongo) Twelve degrees proof, una vecchia suola abbandonata Gumshoe, la vertigine dei precipizi alpini Palisades. Ero invece piuttosto elettrizzato ascoltando Cannonball run, forse un omaggio al padre di Douglas che amava correre in montagna, scandalizzando i puristi, e soprattutto Off major e A nasty spill, una sorta di slalom fatto da un cameriere alticcio tra tavoli di avventori altrettanto alticci.
Tornai serio ascoltando la elegiaca Bury me standing (cioè “Seppelliscimi in piedi”) forse ancora ispirata dalla memoria paterna, e la deliziosa chiusa finale dove si perdona tutto: Encore: all is forgiven. C’era il sole, l’aria era frizzante, e l’acqua che avevo mi sembrava sufficiente ma non così necessaria. Adesso ho i funghi in cantina e lancio imprecazioni contro quei deficienti che si esibiscono in secchiate sprecando malamente l’acqua che hanno. Gli auguro di finire come il Jack Torrance di Shining.
Dave Douglas, Mountain Passages, Greenleaf, 2005