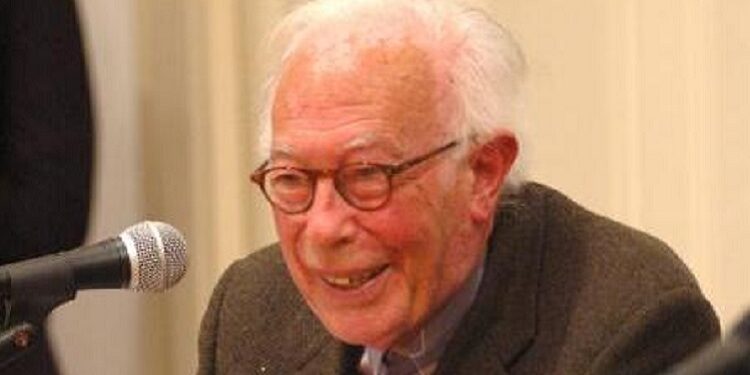Giorgio Galli, Emilio Del Giudice, Felice Accame
Incontro dibattito sul saggio Il pensiero politico occidentale. Storie e prospettive di Giorgio Galli (Baldini Castoldi Dalai, 2010) alla libreria Odradek di Milano, 24 settembre 2010
Felice Accame. Accompagnando Giorgio Galli nella rivisitazione delle teorie politiche formulate al mondo – di quelle della cui formulazione ci è rimasta nitida traccia – l’umore non è destinato a migliorare. Non tanto per eventuali carenze esplicative dell’autore – ce ne saranno anche, perché no, ma resta il fatto che Galli è puntuale nel cogliere l’articolazione essenziale dell’argomento altrui – quanto, piuttosto per la certa, ineludibile, assenza di ogni speranza. Nonostante il volonterosissimo ottimismo di chi ci ha guidato. Dall’alternarsi dei tanti governi dell’uno, dei pochi e dei molti – dimenticandoci pure della quarta variante, un governo di ‘tutti’ – infatti, le sole novità che emergono sono quelle che, impoverendo sempre di più il potere decisionale dei cittadini, si traducono di fatto in strumenti di controllo e di repressione nei casi di manifesto dissenso.
Galli pone la propria fiducia nella formula della democrazia rappresentativa adattata alla complessità tecnologica degli Stati nazionali e “ampliata con il controllo del potere economico” alla condizione che avvenga “un salto culturale che integri la rivoluzione scientifica e contrattualistica del XVII secolo col riemergere, in atto, di quanto si ripropone come valido di antichi saperi”. L’insieme di questa rivoluzione e del buono da salvarsi degli antichi saperi costituisce una ‘sfida culturale’, l’elemento di rottura capace di coesistere con gli elementi di continuità nell’ottica metodologica dell’opera. Dionisismo o movimento gnostico, stregoneria o rivoluzione rappresentativa, da questo punto di vista costituiscono fonti di cultura alternativa ai poteri di turno, siano essi annoverabili come razionalismo greco, monarchie più e meno assolute o Chiesa cattolica, tutte istituzioni che, per un verso o per l’altro – fatto non irrilevante per Galli – hanno emarginato il femminile riducendolo alla subalternità.
Fermo restando che per ‘controllo del potere economico’ non si sa ancora bene cosa si intenda – una cosa, per esempio, è il porre limiti e tutt’altra cosa è il vanificarlo questo potere – io temo che, quand’anche la condizione posta da Galli venga soddisfatta, ai cittadini del mondo non ne verrebbe alcunché di buono, né, tantomeno, di meglio. Gli ‘antichi saperi’ di cui so qualcosa non mi fanno meno orrore di quelli moderni. Nei guai siamo e nei guai rimarremmo. Nei guai sono le donne e nei guai rimarranno.
Spiegare da dove provenga tutto il mio pessimismo non mi sarà facile. Devo mettere in discussione parecchio, a cominciare dai criteri stessi della discussione. Galli dice che si può fare storia mettendo in luce gli elementi di continuità oppure mettendo in luce gli elementi di rottura, oppure – ancora – come fa lui, tentando di vederne la coesistenza. Vorrei fosse chiaro, tuttavia, che continuità e discontinuità non possono essere considerate caratteristiche di una storia in sé, bensì il risultato di un nostro modo di vedere, categorie tra altre – e che, dunque, possono essere applicate l’una successiva all’altra, ma non contemporaneamente – come non contemporaneamente si potrà mai vedere il vaso o i due profili che si guardano nella nota illusione ottica. Potrebbe sembrare una precisazione di poco conto, ma basterà un esempio – fondamentale nell’argomentazione di Galli – per farne comprendere tutta la rilevanza metodologica. Galli parla di ‘rivoluzioni scientifiche’ – non solo lui ne parla; ne parlan tutti, potremmo dire che il sapere più consolidato è informato di questa nozione – ma non si inerpica nella definizione di ‘scienza’ – e sappiamo quanto il sapere più consolidato si inerpichi sì –se non può proprio farne a meno – nella definizione di ‘scienza’, ma senza concluderne con qualcosa di condiviso.
Fatto è che, come i termini di qualsiasi definizione, i termini della definizione di ‘scienza’ sono il prodotto di una teoria della conoscenza in concorrenza con altre teorie. Mutandoli, questi termini, muta anche la storia di ciò cui si riferiscono. Nel caso della scienza, se in quanto attività venisse ricondotta alla sanatura delle differenze riscontrate rispetto ai paradigmi costituiti, ecco che, sarebbe da ridiscutere il criterio in base al quale individuarne le eventuali rivoluzioni. L’acqua che spegne il fuoco e la Terra che gira intorno al Sole sarebbero risultato di procedure analoghe – categorizzabili facilmente nel segno della continuità.
Potevo cavarmela dicendo che l’idea di rivoluzione scientifica è un’idea filosofica come un’altra e che, ai fini dell’invenzione di un sistema politico che faccia star bene la popolazione, una rivoluzione scientifica – qualsiasi cosa s’intenda con l’espressione – non sembra granché utile. Nel passato, se mai, abbiamo assistito al pronto uso di scoperte scientifiche per dare origine a nuove e maggiori sofferenze. Ma, facendo notare l’esigenza di un accordo su cosa s’intenda per ‘scienza’, vengo a coinvolgere anche il secondo aspetto del ‘salto culturale’ invocato da Galli – quello degli ‘antichi saperi’ e di quanto di ‘valido’ dovremmo salvare in essi. Dal mio punto di vista, allora, questi ‘antichi saperi’ in altro non possono consistere che in paradigmi via via costituiti e via via modificati in virtù dell’emergere di differenze cui toccava essere sanate. Il loro ‘valido’ non è diverso dal valido di qualsiasi altra impresa scientifica anche non dovesse essere generalmente chiamata tale.
Qui giungiamo al medesimo punto di poc’anzi: i termini con i quali viene definito il ‘valido’ distinguendolo da un ‘non-valido’ sono il prodotto di una teoria della conoscenza in concorrenza con altre teorie della conoscenza – non sono un dato di fatto. A mio avviso tutte le opzioni offerte dalle teorie della conoscenza conducono a un punto morto (realismo, idealismo, scetticismo; è valido il vero sul piano asseritivo ed è valido il ‘reale’ sul piano dell’asserito; è valido il razionale; tutto è valido; niente è valido) e, pertanto, preferisco dirmi cose di questo genere:
- a) paradigmi, differenze e sanature sono sempre e comunque risultato di operazioni mentali di qualcuno;
- b) dalla ripetibilità di queste operazioni consegue la loro socializzazione: il successo del singolo può essere ottenuto anche da altri; si diffondono i paradigmi, si diffonde il modo di individuare le differenze e si diffonde il modo di sanarle. È quello che Fleck definirebbe uno “stile collettivo di pensiero”;
- c) se un paradigma è costituito da un insieme di sanature precedentemente poste, va da sé che il paradigma stesso sia resistente e che, prima di adottare un modo nuovo di sanare una nuova differenza, ci si pensi due volte. Perlopiù si cerca sanature coerenti con le precedenti – o sanature che, quantomeno, non contraddicano le precedenti;
- d) da questo punto di vista, il criterio di validità – del paradigma, della differenza e della sanatura – non può che consistere nella coerenza e nella non contraddittorietà dell’operare;
- e) ciò non toglie che, a determinate circostanze di crisi – una differenza riottosa a essere sanata nei modi consueti, un numero divenuto insopportabile di differenze non sanate, la possibilità di rendere reciprocamente compatibili più paradigmi – alcuni paradigmi siano buttati via e sostituiti;
- f) ciò non toglie neppure che alcuni paradigmi possano rimanere tali anche nella piena consapevolezza di chi li adotta relativamente a una o più differenze già individuate e non sanate. È il caso del perielio di Mercurio – sopportato per più di quattrocento anni e sanato dalla teoria della relatività generale di Einstein.
Chiarito ciò, posso prenderla da tutt’altra parte. Nella parte conclusiva del suo libro, Galli mi onora di una citazione. Non propriamente per il contributo originale che i miei scritti avrebbero potuto portare al dibattito da lui analizzato, quanto, piuttosto, per il fatto che, rapportandomi al pensiero di Percy W. Bridgman, ne ho evidenziato un aspetto che Galli ha ritenuto rilevante se venisse introdotto nell’ambito della riflessione politica. Sono d’accordo con lui – anche se temo che, approfondendo l’argomentazione dal mio punto di vista, possano emergere nodi che, forse, saremmo tentati di sciogliere in modi diversi. Dunque, Galli rileva come, contrapponendolo “a chi, storia alla mano, ha acquisito il potere, riuscendo anche a mantenerlo, senza preoccuparsi affatto di riuscire convincente”, io promuova il pensiero di Bridgman, secondo il quale “ogni analisi operazionale delle operazioni sociali ci riconduce inevitabilmente ai comportamenti individuali: l’individuo è l’unità in termine del quale i nostri concetti sociali trovano, in ultima analisi, i loro significati”.
Ora, nonostante tutto il mio rispetto affettuoso per Bridgman, debbo anche dire che non tutto fila liscio in questa sua formulazione. È vero che ogni asserzione relativa ai comportamenti sociali è, innanzitutto, un’asserzione relativa al singolo individuo che di questi comportamenti sociali, di principio, rappresenta l’unità; ma è anche vero che, stante la natura categoriale del sociale e dell’individuale, siamo sempre liberi di analizzare il popolazionale come la sua riduzione alle unità che lo compongono – nel senso stesso in cui siamo liberi di assumere come unità di analisi un’unghia o le singole cellule che la costituiscono. Ma è anche vero, soprattutto, che Bridgman – in tutta la sua opera – non riesce a esplicitare un criterio per distinguere tra i diversi tipi di operazioni e, pertanto, un’analisi operazionale delle ‘operazioni sociali’ rimane tutta da inventare. Ciò non toglie che, comunque, questa analisi dovrà basarsi su un modello analitico pregiudiziale, che, a mio avviso, è quello relativo ai significati delle parole. Bridgman è un acuto analista delle parole, ma il fatto che non possa affrontare questa analisi dotato di un modello analitico sufficientemente esteso, fa sì che questa sua analisi finisca con il limitarsi al repertorio dei concetti fondamentali della fisica. Da questo punto di vista, la prospettiva offerta dalla Scuola Operativa Italiana – e mi riferisco ai risultati ottenuti da Ceccato, da Vaccarino, da Somenzi e anche da Von Glasersfeld – è più ampia e potrebbe far intravvedere la possibilità di un’analisi dei significati delle parole – e dell’operare mentale loro correlato –senza limitazioni di sorta.
Una citazione di Galli mi offre l’opportunità di un esempio basilare: laddove il filosofo americano Richard Rorty, nel suo saggio Trockij e le orchidee selvatiche, afferma che “non c’è nessun terreno comune e neutro” su cui lui e un filosofo nazista possano porsi per discutere le loro ‘differenze’, io allora direi che questo ‘terreno comune’ invece c’è ed è costituito dal significato delle parole che usano e dal problema – analitico e negoziale – del loro significato.
A differenza dei tanti che l’hanno preceduto in imprese analoghe, in questa sua ricostruzione del Pensiero politico occidentale, Galli sfiora più volte il nodo del rapporto tra scelte epistemologiche (teorie della conoscenza concorrenti) e dottrina politica, ma, come fosse restìo a scioglierlo del tutto, apparentemente noncurante, passa oltre. Non vorrei che ciò abbia a che fare né con il recupero degli ‘antichi saperi’ – di cui la filosofia dovrà pur far parte – né con l’accettazione dell’operativismo a responsabilità limitata di Bridgman. In alternativa, prenderei le mosse da qui. Se guardo alla storia della filosofia, come dicevo, mi imbatto nelle sue due correnti fondamentali: realismo e idealismo.
Molto sinteticamente, potrei dire che la tesi realista implica un uomo passivo rispetto a un realtà data, che questa realtà sia conoscibile – si tratta di aver pazienza prima o poi ci si arriva, si va sempre più verso la realtà vera – anche se manca il criterio che ci dica quando ci siamo o quando non ci siamo; che in linea di principio questa conoscenza è per tutti. In linea di principio – ripeto ancora questa condizione – dunque, dal realismo potrebbero scaturire teorie democratiche (perché in linea di principio tutti potrebbero avere la stessa conoscenza) o oligarchiche (perché qualcuno ha gli strumenti della conoscenza e altri no: i primi comandano sui secondi, perché sanno come stanno le cose. Lenin, per esempio, accusa Bogdanov e Mach in nome del realismo).
La tesi idealista implica, invece, che l’uomo sia attivo, attivissimo, libero creatore della propria conoscenza. Tuttavia il criterio per stabilire quale sia la creazione giusta manca. Vince dunque il più forte, quello più abile nell’imporre la propria a quella degli altri. Ne dovrebbero scaturire dottrine politiche favorevoli al dispotismo e all’autoritarismo in genere (da Rousseau, Fichte e Hegel scaturiscono il fascismo e il nazismo).
Se nella storia della filosofia ci guardo con più attenzione mi imbatto anche nello scetticismo o nel relativismo, che io considero come conseguenze dirette dell’idealismo e della contraddizione del realismo. Nulla è fondato, ogni conoscenza è dubbia per insufficienza intrinseca del conoscente, tutto va bene, tanto è uguale. Oppure, nell’estrema sinteticità con cui Diogene Laerzio ricorda il pensiero di Pirrone: le cose sono irrapresentabili e incomprensibili, niente è bello e niente è brutto, niente è giusto e niente è ingiusto, nulla esiste in verità, una cosa vale l’altra. Ne dovrebbero scaturire dottrine politiche dove non tanto vince il più forte quanto il più furbo, il più pragmatico, la retorica più efficace – fascismi e autoritarismi più e meno mascherati (Mussolini relativista, Mussolini pragmatista, Papini e Prezzolini fascisti, Berlusconi populista). Dal mio punto di vista, allora, lo scetticismo è la punta estrema del dogmatismo perché ipostatizza inconoscibilità e incapacità di conoscere, non accorgendosi della sua irriducibile metaforicità.
A dimostrare che queste tesi non reggono, comunque, è già sufficiente la storia della filosofia stessa. Ogni buon filosofo ha provveduto in tal senso. Mai con la necessaria radicalità, tuttavia, perché, poi, per un verso o per l’altro, è finito con il ricascarci. La mia alternativa, allora, non può prescindere dalla liquidazione della filosofia in quanto teoria della conoscenza e dalla riconduzione del pensiero e del linguaggio alle operazioni mentali relative – due compiti da far tremare le vene dei polsi (si può comprendere, allora, la radice del mio pessimismo). In definitiva, come premessa della progettazione politica, si tratta di produrre criteri per negoziare e condividere significati, mentre, liberata dall’eredità filosofica, la scienza in quanto procedura in linea di principio ripetibile da chiunque (a differenza della magia) di conseguenza diventerebbe, intrinsecamente, un modello di democrazia.
Emilio Del Giudice. Innanzitutto, io credo che non sia necessaria una teoria della conoscenza per conoscere: posso conoscere qualcosa e non sapere perché lo conosco. E magari, quando so anche perché, ho fatto un progresso e so un po’ di più. Tutti noi conosciamo delle cose, ma se ci si chiede qual è la nostra teoria della conoscenza non sappiamo dirlo. Le cose che conosciamo possono avere origini diversissime: alcune le conosciamo perché le abbiamo viste con i nostri occhi, altre perché ce le hanno raccontate persone di cui abbiamo fiducia e altre, che sono magari le più profonde, le conosciamo senza sapere bene perché le conosciamo. E questo è molto importante. La parola ideologia è usata in molte accezioni diverse. All’inizio, una di queste era: l’insieme di cose che uno conosce senza sapere perché. Se si chiede a una persona perché sa che bisogna rispettare la legge, la risposta più comune è: l’ho sempre saputo. Molto spesso, dunque, i progressi della conoscenza corrispondono anche al venire a capo delle ragioni del perché si conosce quel che si conosce.
Io sono un fisico teorico, e sulla base di ciò che conosco rispondo a uno dei pallini più sentiti da Giorgio Galli, ossia quello di legare le conoscenze scientifiche al problema della politica. La parola ‘fisica quantistica’ è molto nota, però pochi sanno in realtà che cosa vuol dire. La fisica quantistica definita nel ventesimo secolo è una falsificazione truffaldina da parte di chi ne ha parlato, analoga alla falsificazione truffaldina che ha subito la parola ‘comunismo’, che ha finito per significare, nella accezione corrente, il contrario di quello che voleva dire. Infatti ciò che si intende oggi per comunismo è la proprietà statale dell’economia, che è esattamente il contrario di ciò che pensava, a torto o a ragione, Marx, il quale sarebbe inorridito a vedere l’Unione Sovietica di Stalin. Basta leggere la Critica del Programma di Gotha, per esempio, da cui ogni programma di partito moderno della sinistra ne sarebbe uscito triturato.
La fisica quantistica comunemente viene rappresentata come una forma di soggettivismo: un oggetto non può essere definito indipendentemente da chi lo osserva e ha un suo grado intrinseco e irriducibile di erraticità. Questa è l’interpretazione dominante che va sotto il nome di ‘interpretazione di Copenaghen’, ed è stata introdotta per salvare il concetto di oggetto isolato quindi, se volete, di individuo come oggetto isolabile. In definitiva, infatti, il concetto fondamentale che sta alla base della fisica classica, del pensiero politico classico, della moderna civiltà liberale, è il concetto di individuo, ossia il concetto che la natura è fatta di parti separabili; le quali si possono anche associare tra di loro, ma se lo vogliono si possono anche disassociare. Ogni oggetto che esiste in natura è, dunque, in principio, isolabile. Una volta isolato, lo si considera nel suo isolamento, senza che esso interagisca con niente e con nessuno e di conseguenza potendo così definire tutte le quantità fisiche che gli appartengono, che non possono modificarsi perché non ci sono flussi in entrata e in uscita. Perché il punto è che se l’oggetto non è isolato ci sono flussi di energia, per esempio, e allora come si fa a definire l’energia di quell’oggetto? E se non ci si riesce, non si può inserire questa conoscenza in una teoria della conoscenza basata sulla misura, perché per misurare un oggetto lo si deve fermare.
Ora, il problema è: questo è vero? Perché se noi guardiamo a fondo la fisica quantistica, al di fuori dell’interpretazione di Copenanghen, essa ha invece un’altra interpretazione: nessun oggetto esistente in natura è isolabile e tutti gli oggetti sono intrinsecamente in relazione tra di loro attraverso un’entità olistica che si chiama ‘vuoto quantistico’. Quest’ultimo è un oggetto estremamente astratto da definire, non è possibile darne una definizione operativa, quindi esso sfuggirebbe alla definizione di Bridgman. Ciononostante, il vuoto quantistico esiste, e solo a patto di introdurlo è possibile ridare un aspetto di obiettività alla fisica nella descrizione del reale, e concludo citando il famoso teorema di Bell che riassume il significato della fisica quantistica e che dice: il seguente insieme di tre affermazioni è logicamente contraddittorio, quindi una delle tre deve necessariamente essere fatta cadere. Le tre affermazioni sono: la realtà fisica è descritta dalla fisica quantistica; la realtà fisica è passibile di definizione oggettiva; la realtà fisica è analizzabile come un insieme di oggetti isolabili nello spazio e nel tempo. Sulla base di questo teorema possono formarsi tre diversi ‘partiti’: Einstein faceva cadere la prima affermazione, perché era fortemente legato all’obiettività e all’individuo, e dunque se non era possibile mettere insieme le due cose, vuol dire che la fisica quantistica non è vera. L’interpretazione di Copenaghen fa cadere l’obiettività, perché vuole tenere la fisica quantistica, vuole anche salvare l’individuo, e dunque l’unico modo è ammettere una erraticità: non è possibile una interpretazione realistica della realtà e c’è sempre un grado di soggettivismo.
Ma c’è la terza possibilità, di cui io sono partigiano, è cioè che sia la terza affermazione a dover cadere: la località. Quindi abbiamo: la fisica quantistica è vera, in più abbiamo una descrizione obiettiva della natura, dunque il realismo, però il prezzo che dobbiamo pagare è quello di rinunciare all’individuo. Cioè non possono esistere oggetti isolabili in natura. Questo significa che tra tutti gli oggetti esistenti in natura si può stabilire una correlazione, che può essere debole o forte a seconda dei casi ma che non è mai zero. Questa correlazione è definita entanglement, ossia: ogni oggetto è entangled, ha a che fare con altri, non lo si può isolare.
Ciò comporta l’esistenza di due tipi possibili di relazioni tra le cose: una prima fondata sullo scambio di energia, cioè una forza, e questo genere di relazione è governata dal principio di causalità – perché in accordo alla teoria della relatività che afferma che l’energia non può viaggiare più veloce della luce, io posso sempre dire da chi essa è partita e chi l’ha ricevuta, quindi chi è la causa e chi l’effetto. E questa è una caratteristica comune alla fisica classica, ma la fisica quantistica ne introduce una seconda: dato che gli oggetti, stando sempre in interazione con il vuoto, si scambiano continuamente azioni, non possono non fluttuare. Quindi la fluttuazione quantistica, che nell’interpretazione di Copenaghen è soltanto la prova dell’erraticità dell’oggetto, qui diventa la conseguenza oggettiva dell’esistenza del vuoto o del connettivo, come si dice in medicina, che media le interazioni. Questo tipo di interazione richiede un’attitudine diversa da quella del primo tipo: per percepirla l’oggetto si deve lasciare fluttuare. Cioè io posso sentire che ci sono oggetti che fluttuano insieme a me a condizione di non isolarmi, di non irrigidirmi nel mio isolamento, perché se mi irrigidisco non sentirò nulla.
La grande rivoluzione concettuale della fisica quantistica è l’introduzione del principio di non separazione. In questo modo la fisica opera una grande rivoluzione, cioè getta le basi per una fusione con l’arte. L’esperienza artistica venne definita da Schelling come la risonanza di un soggetto con un oggetto. E Walter Benjamin aggiunse qualcosa di più. Disse che la domanda: “Che cosa è un capolavoro?” è mal posta. La domanda ben posta è: “Dato un oggetto qualsiasi, quell’oggetto, quando è un capolavoro e per chi?” Lo diventa quando fa risuonare qualcuno. Per cui scopriamo quando e come io posso risuonare con qualcos’altro, ma allora, qual è il punto che ci colpisce? Che ciò che viene meno è che il genere umano possa essere separato in individui isolati. Gli individui sono necessariamente comunicanti tra di loro, e questo fu il principio dell’opera di Marx.
Marx scrisse una tesi di laurea sulla differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di Epicuro, sottolineando che in Democrito gli atomi ubbidivano al principio di inerzia, cioè erano fondamentalmente oggetti passivi, mentre in Epicuro gli atomi fluttuavano come nella fisica quantistica e grazie a queste fluttuazioni essi potevano risuonare tra di loro e formare gli aggregati; mentre nella visione di Democrito ci vuole per forza la presenza del padreterno perché questi atomi, che vanno per la loro strada senza girarsi né a destra né a sinistra, s’incontrino – da qui anche il disegno intelligente – nella natura che fluttua non c’è alcun disegno intelligente. Non abbiamo più bisogno del padreterno. Abbiamo che la materia è attiva e non passiva.
Veniamo alla politica. Anche qui abbiamo la stessa situazione: gli esseri umani sono attivi o passivi? Nel loro isolamento sono necessariamente passivi. E infatti nel pensiero moderno, che si fonda sulla passività, perché è l’espressione di una società sfruttatrice, gli esseri umani sono soltanto oggetto di forze. Devono essere mossi. Invece, in una concezione rivoluzionaria, gli esseri umani muovono. E quando possono muovere? Soltanto quando risuonano tra di loro. Infatti le grandi emozioni corrispondono a grandi fatti emotivi, in cui la gente scende in piazza senza che nessuno l’abbia convocata. Le persone sentono allo stesso modo e parlano lo stesso linguaggio. Come diceva Lenin nell’Estremismo, le rivoluzioni accadono quando i sogni, i progetti, le aspirazioni delle avanguardie formate da decine di migliaia di persone risuonano con le aspirazioni e i sogni di centinaia di milioni di persone.
Allora, in questo senso, quando è stato il periodo in cui la democrazia è stata possibile? Soltanto quando ha comandato la piazza, quando la folla in piazza ha fatto sentire la propria voce e ha preso anche la forza. Nelle rivoluzioni democratiche – mi fermo a queste, lasciando da parte la rivoluzione d’Ottobre – la prima rivendicazione è sempre stata la richiesta della guardia nazionale, ossia la guardia armata del popolo, ossia una forza armata che non dipenda dal governo. La norma del diritto a portare le armi presente nella Costituzione americana è semplicemente il pallido ricordo di questo periodo; l’origine di quell’articolo è rivoluzionario, rivendica il diritto del popolo a essere armato, perché solo quando il popolo è armato l’autorità non abusa. Quando non c’è più il popolo in armi, la democrazia diventa impossibile. Diventa – perdonatemi la battuta – la formazione di un comitato misto di cacciatori e beccacce che si riunisce tutti i giorni per decidere quante beccacce quel giorno i cacciatori devono far fuori. Pensiamo alla democrazia moderna. Quanti vincoli ci sono! Nella democrazia rappresentativa abbiamo i nostri rappresentanti.
Io personalmente sono contrario a una visione liberale, voglio un rappresentante che mi rappresenti, posso averlo? No. Perché? Innanzitutto la mia richiesta deve rientrare nel filtro del bipartitismo, non si possono fare tanti partiti, ce ne vogliono solo due. Va bene. Allora uno dei due può non avere una visione liberale? No. Perché ci sono i valori condivisi. Capite che questa cosa è molto simile al fascismo. Immaginate che Mussolini, in un barlume di intelligenza, spezzasse in due il partito fascista e facesse il partito fascista A, capeggiato da Farinacci, e il partito fascista B, capitanato da Bottai. Avrei avuto scelta? No, non avrei avuto scelta.
Veniamo al potere economico. Supponiamo che ci sia un governo che voglia mantenere la tradizione industriale presente in Italia, e dunque che esistano anche i diritti dei lavoratori e che voti lo Statuto dei lavoratori. La legge è fatta e quindi tutte le fabbriche la rispettano. Arriva Marchionne e dice: non mi fate comandare come voglio io? E io me ne vado in Corea. Glielo si può impedire? No, perché il capitale va dove vuole, è come lo spirito, soffia dove vuole. Il lavoro no, nel lavoro ci sono i vincoli dell’immigrazione… Che comando ha la politica? Nessuno. Che democrazia c’è? Nessuna. È finzione. Senza il popolo in armi la democrazia è una truffa, è un imbroglio.
Dunque in queste circostanze, in cui i capitali vanno in tutto il mondo, qual è la prospettiva che si apre? Esattamente quella delineata da Marx. Visto che la ricchezza diventa un fatto globale, questo getta le basi per un’umanità globale non più divisa in nazioni, e dunque spariscono anche gli Stati e sparendo gli Stati sparisce anche il problema della politica. Ma allora gli esseri umani come organizzeranno la loro vita? A questo punto torna la fisica quantistica. Quella forma di interazione che si fonda sull’uso della forza diventa secondaria e quella forma di interazione che corrisponde alla risonanza – mi concedo termini idealistici, romantici – che corrisponde all’amore, prende il sopravvento. Il diritto è importante in una comunità di esseri umani che non si amano ma che cercano di imbrogliarsi a vicenda, come nella società capitalistica. Io guadagno e tu ci perdi. Io cerco di fregarti più che posso e questo è ammesso dal codice civile. Il fine di un’azienda è il guadagno, non è realizzare il bene comune. In questa società l’amore è possibile soltanto nella forma dello stupro, che è l’applicazione della forza.
Quando gli uomini possono risuonare tra di loro? Quando non avranno più il problema di guardarsi gli uni dagli altri, e questo può accadere solo quando non ci sarà più la competizione economica. Allora potranno litigare per tanti altri motivi ma non per questo, e finché c’è la competizione economica non è possibile realizzare forme umane di società. Alla fine la politica è la caratteristica di una società in cui gli esseri umani sono reciprocamente separati e in cui bisogna trovare un modo di farli convivere. Quindi è un’attività che ha un senso, ma è un’attività che perde sempre più di significato con il mondo moderno, con la globalizzazione, con il primato dell’interesse economico su qualunque altro interesse. La soluzione non è la proprietà statale ma l’abolizione della proprietà, l’abolizione della divisione dell’economia in aziende, cioè una situazione – che non può essere imposta a comando ma ci si sta arrivando – di una relazione tra gli esseri umani di ‘tipo quantistico’, cioè in cui le persone risuonano e non si stuprano.

Giorgio Galli. Per prima cosa, ho citato nel libro Felice Accame ed Emilio Del Giudice perché negli anni ho imparato molto da loro. È vero che nomino il primo in riferimento a Bridgman, ma lo cito anche per la sua elaborazione di tutte le teorie della conoscenza come costruzione di un sistema di potere, ed è una riflessione che è fondamentale tenere sempre a mente. Per quanto riguarda Del Giudice e la sua convinzione che le grandi trasformazioni avvengano, in similitudine con la fisica quantistica, attraverso fluttuazioni rese possibili dalla diffusione di massa di uno stato emotivo, e che la globalizzazione economica crei le condizioni di una correlazione planetaria, penso che occorra tenere presente l’aspetto culturale: perché il fattore emotivo è importante, ma le emozioni variano a seconda del patrimonio culturale. L’umanità è unica ma è evoluta, almeno nel corso degli ultimi tre o quattromila anni, su costruzioni culturali e teorie della conoscenza molto diverse tra Occidente e Oriente.
È riduttivo pensare che la globalizzazione creata sul modello del capitalismo occidentale crei le condizioni per le quali si fluttui convenientemente e si sostituisca alla competizione individuale una sorta di danza collettiva. Emilio Del Giudice insiste molto sul fatto che la democrazia è il popolo in armi – Marat aveva risolto il problema dicendo che quando ci si chiede che cos’è la volontà generale la risposta è semplice: la volontà generale è il popolo in armi. Quindi i periodi nei quali la democrazia funziona sono i periodi di una intensa e convergente volontà collettiva al cambiamento che si traduce nella piazza. Questo è il grande modello delle rivoluzioni che noi conosciamo e probabilmente, se vogliamo trascurare la storia anteriore alla cosiddetta rivoluzione scientifica, abbiamo effettivamente momenti nei quali le rivoluzioni borghesi, in Inghilterra poi negli Stati Uniti e poi in Francia, sono anche il popolo in armi; il popolo che talvolta è genericamente la piazza – come nella presa della Bastiglia – e talvolta è l’esercito. È abbastanza significativo infatti che le democrazie anglosassoni, nel loro momento iniziale di partecipazione, costruiscano il New Model Army in cui l’esercito parlamentare sono i contadini in armi, e così accade anche nella rivoluzione americana.
Ma ora le possibilità di cambiamento politico sono legate a un convergere di quel tipo di conoscenza che noi consideriamo scientifica della quale la stessa democrazia è un prodotto: essa è infatti un’invenzione molto recente, di appena tre secoli, e relativa a un angolo di mondo che riguarda appena il 10% della popolazione del pianeta. È dunque un’esperienza molto limitata nel tempo e nello spazio ma molto importante, tanto è vero che da qui parte la globalizzazione e ha prodotto il capitalismo mondiale globalizzato, ossia proprio quello stato di conflittualità permanente che dovremmo superare attraverso una amorevole fluttuazione. Il possibile passaggio è uno stato emotivo che tenga insieme tutto questo e anche la scienza.
Un aspetto interessante della situazione attuale è dato dal modello di piazze informatiche: viene da chiedersi se è possibile che proprio in queste piazze si condensi quello stato emotivo diffuso che fa incontrare il pensiero di una minoranza – il partito di modello leninista che a sua volta aveva il modello giacobino e che forse possiede una teoria della conoscenza – con i sentimenti e le emozioni di milioni di persone convinte di conoscere anche se non sanno bene come e perché conoscono. Io non so dire se questo possa creare o meno una differenza nell’evoluzione della situazione, di certo una differenza già esiste tra le piazze classiche della storia del pensiero politico, dalle quali sono nate le rivoluzioni del modello occidentale, e la piazza elettronica della società attuale.
A mio avviso, siamo in una fase nella quale occorre mantenere tutto quanto di valido la scienza moderna ci ha dato – e ci ha dato certamente alcune cose importanti per migliorare il livello di vita: i diritti civili sono stati in qualche misura garantiti più che altrove, le disuguaglianze sono diminuite, anche se rimangono. Io credo che questi risultati siano oggi in pericolo. Non soltanto perché l’idea dell’ultimo decennio di esportare il modello democratico nel mondo intero chiaramente non è riuscita e ha provocato ovunque un corto circuito drammatico, ma anche perché vediamo continuamente messe in discussione queste conquiste nelle stesse società democratiche, come nell’esempio di Marchionne citato da Del Giudice. Queste conquiste cominciano a essere indebolite là dove si erano realizzate attraverso comportamenti collettivi, istituzioni e iniziative legislative andate avanti per tre secoli. Io credo che questa fase di difficoltà possa essere superata da un lato mantenendo tutte le conquiste che io attribuisco alla scienza, e chiamo questo il portato a livello collettivo della rivoluzione scientifica del Seicento, e dall’altro riscoprendo tutti quei comportamenti collettivi diffusi, basati su un patrimonio di emozioni collettive, soprattutto di genere, che la rivoluzione scientifica ha sacrificato.
È un patrimonio che, in Occidente, si è tradotto in una serie di contestazioni diffuse del potere costituito dell’autorità. Io vedo, infatti, una certa continuità tra le ribellioni che hanno accompagnato la nascita del pensiero della polis greca, il crollo dell’impero romano, la nascita dello Stato moderno. L’avvento della categoria delle democrazia greca è infatti anche il frutto di una ribellione collettiva della quale c’è rimasta traccia nelle leggende delle amazzoni dionisiache; il crollo dell’Impero romano è avvenuto a seguito di un’ondata di indebolimento del potere costituito e di comportamenti emotivi diffusi basati sulla trasformazione dei princìpi originari dei vari gruppi che costituivano le cosiddette sette cristiane; la nascita dello Stato moderno è caratterizzato da comportamenti diffusi per i quali è esempio collettivo la stregoneria, un movimento a tal punto pericoloso che per fronteggiarlo l’Occidente ha realizzato, in due secoli, centomila processi. In tutto questo vedo una continuità imperniata sulla storia di generi – delle amazzoni, dei gnostici, delle streghe – un patrimonio culturale che la storia occidentale ufficiale ha sempre trascurato.
La conclusione è quindi che occorre conservare il patrimonio culturale che ci ha dato la scienza, ma contemporaneamente tener presente quel patrimonio culturale che ci deriva dall’esperienza della storia dei generi, e vedere se ci sono alcune condizioni – nel libro cerco di individuare quali potrebbero essere – per una nuova ondata emotiva diffusa, che ci possa portare in direzione di quello che Emilio Del Giudice chiama una sorta di risonanza collettiva basata non sulla competizione ma sulla convergenza.