| di Sabrina Campolongo |
Recensione de I cariolanti, Sacha Naspini
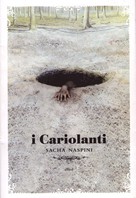
“Se non mangio tutto arrivano i Cariolanti”. Così comincia la favola nera raccontata da Sacha Naspini, quasi interamente in prima persona, dalla voce viva, anti-letteraria del suo protagonista, Bastiano. La storia è suddivisa in tredici capitoli, tredici frame della vita di Bastiano, dai 9 ai 52 anni, di cui il primo e l’ultimo condividono la stessa ambientazione: una buca scavata nel terreno, nel folto del bosco. Sottoterra Bastiano c’è andato a 5 anni, assieme alla madre e al padre disertore che li ha nascosti per sfuggire al plotone d’esecuzione.
I cariolanti, sorta di babau che rapisce bambini caricandoli sulla sua carriola, da inquietanti protagonisti di racconti che spaventano il protagonista diventeranno il cognome scelto dalla famiglia stessa, quando si tratterà di uscire dalla clandestinità.
L’autore – che titola il romanzo proprio I Cariolanti – sceglie di non esplicitare le ragioni alla base della decisione. Forse, scegliere Cariolanti come cognome è una specie di esorcismo, come per eleggere questi spaventosi esseri a numi tutelari; forse invece rappresenta l’accettazione, più o meno consapevole, di essere definitivamente passati sull’altra sponda della barricata, tra le persone per male, tra quelli di cui aver paura, tra i cattivi.
A 9 anni, Bastiano sa già benissimo che cos’è la fame. Il padre è il solo che provveda a procurare il cibo, quando può allontanarsi dalla buca, quando ne trova. E se non ne trova, si mangiano vermi o radici, e se un soldato viene abbattuto proprio sopra la botola, si mangia anche lui, e se non si trova davvero nulla, si può arrivare addirittura a cibarsi di una fetta di se stessi.
“Vedi dunque” osservò Geppetto, “che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici, né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo” (1).
Come al burattino Pinocchio, a Bastiano, in questo mondo, capiterà davvero di tutto. Rischierà di venire ucciso e ucciderà, per amore o per ignoranza, sarà accusato di un delitto che non ha commesso, finirà in galera e poi in guerra, e poi in un campo di concentramento, ucciderà ancora, per odio o per paura e alla fine tornerà, per propria scelta, all’unica casa che sente davvero sua: la buca nel bosco. Il tutto accompagnato sempre dalla fedele, feroce compagna: la Fame, quella primitiva che non lascia spazio ad altro, che non perdona. Mangiare per non essere mangiato, la prima legge della giungla, l’unica che Bastiano riconosca. Nessuna morale lo determina, solo il bisogno.
Come un animale, o come un bambino. Come Pinocchio che è pronto a mentire, a tradire, a rubare per ottenere ciò che vuole, senza riconoscere altro che l’oggetto della propria fame, o il pericolo, o la curiosità, l’unico bisogno non elementare capace di determinare le scelte del burattino, prima della ‘redenzione’ finale. La curiosità che commoveva Giorgio Manganelli, che, come racconta la figlia Lietta, “seduto a terra, in calzoncini corti, sfogliava con avidità la pagine di quel libro fantastico per poi sciogliersi in lacrime disperate alla morte del burattino ‘maraviglioso’, che veniva sacrificato per dar vita all’inutile e banale ‘bravo ragazzo’, senza storia e senza nulla da raccontare” (2).
Nel caso di Bastiano non vi è redenzione, anche l’amore abita lo spazio del bisogno istintivo dell’altro, di vicinanza e calore, ma sfocia invariabilmente nella delusione, e di conseguenza, nella rabbia distruttrice, nella volontà di profanare l’amore, di darlo – letteralmente – in pasto ai cani, di bruciare ciò che era sacro e gettare le cenere ai porci – anche questo letteralmente.
Il tratto meno lineare di questo esemplare di uomo è probabilmente il suo bisogno di raccontare, di raccontarsi. Narrando a voce, o addirittura scrivendo, nel caso di un solo, breve, sgrammaticato messaggio al mondo, Bastiano trasmette la propria storia a un interlocutore ogni volta diverso (umano o animale, vivo o cadavere, non sembra fare differenza), mescolando candida ingenuità e ferocia, stupore e rabbia, antichi saperi che vengono dalla terra e dall’osservazione del mondo animale e furbizia tutta umana, solo in parte appresa. Sebbene non spiegabile attraverso leggi biologiche, anche il bisogno di narrare sembra essere, per Bastiano, una necessità primaria, come quella di nutrirsi. Bisogno di confermare la propria esistenza nel racconto di sé, o bisogno di trasmettere un messaggio?
Probabilmente entrambe le cose. E, se la prima esigenza interesserà forse maggiormente lo scrittore, colui che vive il bisogno di narrare come un istinto che non può spiegare, la seconda apre questioni universali. Chiedendoci quale messaggio ci comunica Bastiano, con la sua disgraziata esistenza, nata di traverso, si inciampa immediatamente nella grande questione che ha precorso e percorso l’Illuminismo, quella della natura dell’essere umano. Fondamentalmente buona e quindi corrotta dalla civiltà, come ipotizzava Rousseau, o invece crudele, lupigna, ‘addomesticata’ dalla civiltà, come riteneva Hobbes?
Questione tutt’altro che risolta, se ancora oggi accade che un esponente politico come il sindaco Letizia Moratti, per esempio, dichiari (esternando un pensiero piuttosto diffuso) che alcune categorie di persone – i clandestini, nel caso specifico – sarebbero “naturalmente” portate al crimine.
La vita di Bastiano sembrerebbe, a uno sguardo superficiale, dare ragione al sindaco Moratti. La propensione verso comportamenti antisociali appare in lui assolutamente ‘naturale’. Trovandoci di fronte la sua riflessione allorché, rinchiuso in un campo di concentramento, rifiuta di cedere la propria misera razione di cibo a un compagno in fin di vita, difficilmente potremo condividere la sua scelta dal punto di vista etico, ma, allo stesso tempo, non potremmo affermare che essa sia perversa o contronatura: “Perché se un lupo crepa di fame e si ritrova tra le mani un bell’agnello bianco se lo pappa in un momento, hai voglia che gli altri lupi gli vadano a dire che quel bocconcino serve di più a un altro. Il lupo se lo mangia e zitti tutti, sennò poi vedete che succede. Magari si rivolta e sbrana tutta la compagnia”.
E, se questa affermazione così ferina può ferire o turbare, una lettura adulta della favola di Collodi non può che confermare che l’amato burattino, prima del finale ‘riscatto’ che faceva piangere di malinconia Manganelli, non è un personaggio meno amorale. La sua coscienza è mai attraversata da preoccupazioni che non riguardino la propria sopravvivenza e soddisfazione. Le manifestazioni di pentimento e di dolore per l’incerto destino del buon Geppetto sono sempre troppo ‘utili’ per non apparire sospette. Del ‘povero babbo’, il burattino si ricorda solo quando si trova in grave pericolo, mentre sta impiccato a un albero, quando rischia di finire legna da ardere per cucinare la cena del mancato orco Mangiafuoco, mentre cerca di ottenere la benevolenza della Fata Turchina…
E, se nel caso di Pinocchio, burattino quindi sub-umano, il passaggio verso l’umanità avviene attraverso la preoccupazione sincera per l’altro, da un lato, e l’accettazione delle regole della società civile, dall’altro, prima fra tutte quella del lavoro, anche bestiale, abbracciato con entusiasmo (non così lontano da quell’Arbeit macht frei titolo di un romanzo di Lorenz Diefenbach –amico dei fratelli Grimm – prima che beffardo messaggio all’ingresso di molti campi di concentramento), nel caso di Bastiano la redenzione – sfiorata a più riprese, prima con l’amore per la figlia del padrone, poi con il ritrovamento della sorella gemella – è ben presto violentemente abortita.
Bastiano compie un viaggio al contrario, allontanandosi dagli uomini e tornando dentro il ventre della terra, dove ritrova, come Pinocchio nella pancia del pescecane, il padre. Fuori tempo massimo perché qualcosa si possa spiegare o salvare – il genitore è già cadavere – ma non troppo tardi per riconoscersi figlio degno di quel padre che, trucidando, maltrattando, sfuggendo alla legge, ha comunque protetto la sua famiglia, come poteva.
C’è crudeltà in questo? Alla fine della lettura, Bastiano non riesce a sembrarci cattivo. Mai, seguendo il flusso dei suoi pensieri, abbiamo incontrato desiderio di dare il male che non fosse rabbia per un sopruso ricevuto, che non fosse reazione istintiva, impulsiva. La sua natura semiselvaggia (inselvatichita, per mancanza di alternative, in tenerissima età, ma in seguito abbracciata, consapevolmente, in ogni passo del suo percorso), di animale tra gli altri animali (i suoi veri simili, di cui capisce perfettamente i comportamenti e i bisogni) non appare né buona né cattiva, fino al momento in cui non incontra e si scontra con gli altri uomini, vicini abbastanza perché Bastiano ne senta l’attrazione, troppo diversi perché possa comprenderli o rispettarli.
Secondo Rousseau, la convivenza tra uomini all’interno di una società fondata sulla proprietà privata e la divisione del lavoro non può che generare dipendenza degli uni verso gli altri, creando la diseguaglianza e alimentando la spaccatura tra ricchi e poveri, con la conseguente morte della naturale pietas del buon selvaggio; per Hobbes invece, la convivenza necessita di un patto sociale in grado di garantire la sicurezza degli individui, sebbene a prezzo del trasferimento del proprio diritto naturale a qualcuno delegato a gestirlo.
Nel caso di Bastiano, il diritto non potrebbe essere ceduto, semplicemente perché non è percepito. La vita di Bastiano e della disgraziata famiglia Cariolanti, costretta a vendere una figlia perché impossibilitata a mantenerla, a ricevere dal padre, dopo giorni di digiuno, il cadavere di un neonato abbandonato come mostruoso pasto, ogni giorno sulla Terra sembra anzi strappato al diritto naturale, sociale e forse anche divino, uno sgarro a tutte le forze che concordi indicano la morte come il destino naturale di questi esseri spuntati come la gramigna in un terreno – quello della miseria più nera e meno poetica – troppo ostile perché ne possa venir fuori qualcosa di buono. La società civile, che si regge sul privilegio di alcuni e la miseria degli altri, sembra ricordarsi del destino di questi ultimi solo quando ha bisogno di carne da cannone o di braccia disposte a lavorare in condizioni bestiali per un tozzo di pane, salvo poi indignarsi e inorridire quando individui trattati come bestie finiscono per comportarsi come bestie.
Bastiano, solo, isolato e senza più identità, costretto a seppellirla da quella società violenta che ha imposto le proprie regole al padre, non sembra trovare altra via se non quella di chiudere nel modo più violento ogni rapporto con i suoi simili, rinunciare al confronto, alla lotta e alla vicinanza. Cosa può accadere, però, quando molti Bastiano, più affamati che cattivi, più vessati che feroci, si ritrovano insieme a subire l’ennesimo, spietato torto?
Quando assistiamo a fatti come la recente rivolta dei migranti di Rosarno, quando il telegiornale ci racconta che un manipolo di giovani uomini ha attaccato “come bestie” un’auto su cui viaggiava una donna con i suoi bambini, rovesciandola, è difficile non inorridire, dalla nostra posizione. C’è un ‘grado zero’ di umanità, sopra il quale la gran parte del mondo occidentale vive: quello in cui non è in discussione la sopravvivenza, quello in cui si sa di possedere un diritto naturale da cedere a qualcuno che, possibilmente, non lo maltratti troppo. Per parlare dei fatti di Rosarno, per provare a capirli, bisogna scendere di almeno due gradi: superare il grado -1, in cui la sopravvivenza è a rischio ogni giorno, in cui si può morire di fame o stramazzare per la fatica in mezzo a un campo su cui il tuo cadavere di bestia da soma verrà lasciato a indurirsi sotto al sole fino a sera, e arrivare, con l’immaginazione, se possibile, al grado -2, in cui ti possono sparare addosso, mentre ti trascini, sfinito, verso la baracca fatiscente nella quale dormi senza acqua né un letto, magari perché uno con la pelle dello stesso colore della tua ha osato alzare la testa e chiedere di venire pagato per il lavoro che ha svolto, o magari in modo preventivo, solo per dissuadere te e gli altri come te dal provarci. O per estirpare il pensiero di una possibile fuga (scappare dove, poi, quando non sai dove ti trovi, e attorno vedi solo campagna, e le località che hai sentito nominare potrebbero essere ugualmente a trenta chilometri come a trecento? Campagna popolata da cani da guardia con automobili e fucili, pronti a cercarti finché non ti ritrovano).
Se l’immaginazione non riesce a spingersi abbastanza da vederli, questi nuovi schiavi, da indovinarne i pensieri, le paure, la rabbia – immaginare che situazioni così esistano non è facile come sembra, credere che possano accadere da qualche parte nel nostro Paese lo è ancora meno – può venire in aiuto un saggio del 2008 di Alessandro Leogrande, dal titolo Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud (Mondadori Strade blu). In modo coinvolgente ma rigoroso, questo saggio svela i meccanismi della barbarie, a partire da un’indagine portata a termine nel 2006 nella zona del Tavoliere delle Puglie, tra i raccoglitori di pomodori, non africani, in questo caso, ma polacchi.
Una diversità geografica che porta con sé altre, importanti, differenze, come spiega bene l’autore: “Per un africano, una volta compiuto il Grande Viaggio che gli ha permesso di venire in Italia, l’obiettivo principale è quello di continuare a vivere nel Belpaese. Per farlo, deve necessariamente andare alla ricerca di lavori che gli consentano di sopravvivere per tutto l’anno. Pertanto il sudanese (che spesso scende al Sud per la stagione agricola da Roma o da Milano) non accetterebbe mai meno di 20-25 euro al giorno. Non gli conviene, guadagnerebbe la stessa cifra come ambulante restando nella sua città. Per il disoccupato polacco o romeno che può attraversare i confini della Ue senza essere spedito in un Cpt, la prospettiva è radicalmente diversa. In genere non viene in Italia per stabilirsi, ma solo per lavorarvi alcuni mesi. Il suo obiettivo è tornare al proprio Paese con i soldi, con un gruzzolo tale da affrontare il resto dell’anno lì. Ma il costo della vita, al suo Paese, è di molto inferiore rispetto a quello che è costretto ad affrontare il sudanese a Roma o a Milano. Lui, l’europeo dell’Est, può permettersi di accettare una paga di 10 euro al giorno. Ciò che per il sudanese è inammissibile, per lui è meglio di niente”.
A questo punto non è male ricordare che, fino alla metà del secolo scorso, i braccianti sotto il bastone del caporale, del ‘soprastante’, erano italiani. Eppure, come ben ci spiega ancora Leogrande, i confini del caporalato erano leggermente diversi: ci si manteneva, ancora, attorno al ‘grado zero’ dell’umanità, quello in cui la sopravvivenza è difficile ma non in gioco ogni singolo giorno, quello in cui gli individui conservano delle radici, sono inseriti in una comunità, hanno un’idea di quello che è il proprio diritto naturale, per quanto bistrattato, hanno un futuro per il quale combattere. Proprio come è avvenuto di recente a Rosarno. I polacchi del Tavoliere non si sono rivoltati, nel 2006. Moltissimi hanno subìto e basta, pochi hanno cercato di fuggire, qualcuno ci è riuscito e tra questi solo pochissimi sono arrivati al consolato a chiedere aiuto. I polacchi non pensavano a un futuro, a una vita da costruire, avevano in mente solo un presente più o meno lungo, un inverno da passare, una casa e una famiglia a cui tornare. Gli africani di Rosarno, invece, molto probabilmente, sono fuggiti tagliando ogni ponte con il proprio Paese. Non potendo tornare indietro, hanno scelto di andare avanti, in un altro Stato, uno Stato democratico, uno Stato di diritto, e si sono ritrovati sprofondati in una giungla in cui il diritto è solo una parola spolpata e la parola giustizia vale, per loro, solo come minaccia; trattati come bestie, salvo poi riconoscere loro caratteristiche umane – devianza, crudeltà, sociopatia – nel momento in cui si ribellano a condizioni di vita più che inaccettabili, inimmaginabili.
Non rispettano le nostre leggi, non rispettano la nostra proprietà, queste le più moderate accuse. Chissà quale dose di rispetto ci si può ragionevolmente attendere da essere umani importati come merce viva, ammassati in un edificio fatiscente per il quale devono anche pagare un affitto – sottratto metodicamente ai loro ipotetici guadagni – portati nei campi a lavorare come bestie dall’alba al tramonto e poi chiusi di nuovo nel serraglio, appesi a promesse di un salario misero che non sempre arriverà, terrorizzati a suon di botte e minacce.
Ma la domanda probabilmente è più semplice di così. Forse dovremmo chiederci soltanto quale giustizia può applicarsi a chiunque di noi; chiederci se la Giustizia può esistere, nello stesso territorio in cui a tanti Bastiano è sistematicamente, violentemente negata.
(1) Cfr. Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, Carlo Collodi
(2) Da un’intervista a Lietta Manganelli di Alessandra Pigliaru, http://rebstein.wordpress.com/2010/05/05/omaggio-a-giorgio-manganelli-i/
I cariolanti, Sacha Naspini, Elliot edizioni, 2009
