| di Sabrina Campolongo |
Recensione de Le vergini suicide, Jeffrey Eugenides
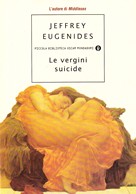
Da mesi, ormai, dalle pagine di ogni testata giornalistica o dalle poltrone di ogni talk show che si rispetti (ma anche in quelli poco rispettabili) ‘esperti’ di ogni tipo, opinionisti, artisti e intellettuali discettano del ‘corpo delle donne’. Corpo, poi, al singolare; piace così, come se tutte le donne condividessero la stessa struttura in comodato d’uso.
Il dibattito sul sopraccitato ‘corpo delle donne’ che ha, come al solito, giovato soprattutto alla popolarità di uomini, da Gad Lerner, a Vespa, a Ferrara, allo stesso premier, probabilmente, a Santoro – che non disdegna di addobbare lo studio di Annozero con signorine perfettamente intercambiabili e altrettanto inutili, belle sebbene non discinte (in qualcosa bisognerà pur distinguersi) – è senza dubbio partito dal dramma del corpo morto di Eluana Englaro, per spostarsi poi, con grande spargimento di flash e linguaggi pirotecnici, sui corpi tonici, mostrati da ogni angolazione, di aspiranti veline/eurodeputate (a scelta, i casting pare siano unificati) e su quelli di escort da mille euro a notte, per riprendere vigore a partire dall’offesa al corpo maturo e non certo televisivo di Rosy Bindi, e qui mi fermo.
Scorrendo i fiumi di inchiostro e di pixel di questi mesi, tra finti scandalizzati, finti preoccupati, veri puritani, genericamente disgustati, e poche e marginali voci di autentica ribellione, mi è tornato alla mente il romanzo Le vergini suicide, opera prima, pubblicata nel 1993, del premio Pulitzer 2003 Jeffrey Eugenides.
Significativo, forse, che a parlarmi dei ‘corpi delle donne’ in modo originale sia ancora una volta un libro scritto da un uomo, ma, se è vero – e io credo che lo sia – che l’artista travalica nella sua opera la propria identità (di genere e non) e pesca nella pozza dell’esperienza universale, credo che Eugenides abbia scritto Le vergini suicide immerso nella pozza ben oltre la cintura.
La storia è semplice e amarissima, feroce, anzi, e non bastano ad addolcirla né l’humour dissacrante di cui è pervasa, né i passaggi di malinconica poesia che la infiorano.
È una storia estrema, spinta oltre la verosimiglianza, forse, eppure è la storia, più o meno esasperata, del cappio stretto al collo di ogni donna.
Di ogni donna, sì. Non tutte lo avvertono allo stesso modo, anzi, molte si sono lasciate convincere che si tratti di un collier, e lo sfoggiano addirittura, con un misto di orgoglio e malizia; altre lo riconoscono come un leggero disagio con cui si può convivere, che si può ignorare quasi sempre; per altre ancora invece è una tortura costante, una sorta di parassita di cui è impossibile sbarazzarsi, che succhia energie e ore di sonno; qualcuna, infine, perde la vita o l’equilibrio (o entrambi) nella furiosa e perdente lotta per cercare di toglierselo.
Ciò che accomuna quasi tutte è il momento in cui per la prima volta si avverte la presenza della corda sul collo: un momento che si situa tra la pubertà e l’adolescenza, non a caso l’età in cui si conclude violentemente la vita delle protagoniste del romanzo di Eugenides.
Mentre emerge dal bozzolo dell’infanzia, con un corpo e pensieri ancora ibridi, in bilico tra la voglia di giocare ancora con le Barbie e quella di avere un seno come il loro, ogni ragazza si accorge di portarsi addosso il peso dello sguardo degli altri.
Né intenerito, né benevolo, non lo sguardo con cui le vecchie zie le accarezzavano, né quello frettoloso e distratto dei compagni di giochi del giorno prima. No, un tipo di sguardo del tutto diverso. Uno sguardo che soppesa, che valuta, che vuole o che disprezza. Da parte degli uomini, senz’altro, ma non solo.
Anche lo sguardo delle donne cambia. Diventa lo sguardo che ogni aspirante miss Abbiategrasso o miss Universo – la differenza non è significativa – riserva alle altre concorrenti, uno sguardo preso in prestito agli uomini, uno sguardo che si chiede, per prima cosa: che cosa vede, un uomo, in lei? Che cosa può apprezzare, che cosa le manca?
Il riferimento ai concorsi di bellezza non è casuale. Una ragazza intelligente capisce in fretta che, in quanto donna, è condannata a stare su una passerella. E capisce, altrettanto in fretta, che, volente o nolente, da quella passerella non potrà scendere mai più (o, forse, in età molto avanzata, quando smetterà di essere, agli occhi del mondo, una donna e diventerà semplicemente una vecchia).
Potrà fare del suo meglio per sedurre la giuria, oppure, al contrario, sfidarla, sputare sul suo giudizio, ribellarsi, spettinarsi i capelli, gettare via le scarpe con i tacchi, rifiutarsi di sfilare incostume da bagno, ma mai, in ogni caso, potrà passare dall’altra parte; essere lei, la giuria (forse per gioco, per finta, o per una concessione momentanea, premio o contentino, mai sul serio).
Non è solo la sua bellezza a essere oggetto di giudizio, è un insieme più complesso, che si riconduce comunque al corpo, all’apparenza, alla sua capacità di sedurre, di eccitare, di concedere, di tenere sulla corda – ma il giusto – di consolare all’occorrenza, di farsi piccola per far sentire l’altro immenso. Tutto ciò si può incasellare sotto la definizione di ‘femminilità’, con la precisazione fondamentale che il punto di vista che ha tracciato i confini e le implicazioni di tale concetto è storicamente e culturalmente maschile. È la giuria che stabilisce il metro di giudizio, non certo le concorrenti.
Con il tempo e l’esperienza, una donna realizza, più o meno dolorosamente, che, a meno di una rivoluzione, sola com’è (dalle altre concorrenti allo stesso titolo non può aspettarsi solidarietà), ha due sole vie, se vuole scendere dalla passerella: nascondersi (“C’è una donna nella stanza prima che entri uno che la vede?” si domandava sarcasticamente Karl Kraus, centrando però un punto nevralgico), oppure rinunciare definitivamente al mondo, al presunto premio e alla gara.
Ma le sorelle Lisbon, protagoniste del romanzo di Eugenides, non hanno ancora vissuto abbastanza per desiderare di nascondersi. Non hanno vissuto affatto, si può dire.
Cecilia, Lux, Bonnie, Mary e Therése hanno tra i 13 e i 17 anni, nel 1970. Sono nate e cresciute all’ombra di un olmo (malato, come lo sono tutti, inspiegabilmente, nel quartiere) in un anonimo sobborgo urbano americano, tra il ronzare dei tagliaerba per mantenere impeccabili i verdi prati, il via vai di station wagon, il rito collettivo della raccolta delle foglie secche e la messa domenicale. Una sorta di baluardo della decenza e della moralità borghese, che fa di tutto per respingere e tenere lontani i germi della rivoluzione che proprio in quegli anni sta scuotendo dalle fondamenta i centri pulsanti dell’Occidente.
La casa delle sorelle Lisbon appare, all’interno della roccaforte, come la torre più impenetrabile. Una casa spenta e fredda quanto un orfanotrofio religioso, retta da una madre che permette alle proprie figlie di uscire solo per andare a scuola (dove peraltro sono sotto gli occhi del padre, professore) e in chiesa, sempre infagottate in abiti informi; una madre che vieta loro feste, trucco, amici maschi (persino il giardiniere deve abbeverarsi dalla fontanella esterna, essendogli stato negato l’accesso al salotto-tepidarium in cui le sorelle si scambiano chiacchiere, sogni e confidenze, in così stretta simbiosi da avere mestrui sincronizzati); una madre che evita, lei stessa, di uscire di casa il più possibile e che si automortifica nell’aspetto fisico, tanto che il contrasto tra la sua spenta bruttezza e la luminosa bellezza delle figlie (bellezza che, vedremo poi, è più mitica che reale) non smette di sorprendere il vicinato.
L’unico uomo di casa, il signor Lisbon, padre e marito, è così debole, o così distratto, da accettare senza discutere le regole imposte dalla moglie, senza interrogarsi sulle sue motivazioni, o sullo squilibrio che ne è alla base, né sui desideri delle figlie, che pure, a modo suo, forse ama.
Se questo non bastasse, c’è poi tutto un vicinato che, ben lontano dal muovere un dito per aiutare le ragazze a uscire dall’isolamento e dalla fanatica intransigenza di questa madre-kapò, non fa che guardarle, spiarle, congetturare su di loro; le giudica, cerca interpretazioni ai loro comportamenti, prende nota di cosa fanno e cerca di scoprire cosa pensano, letteralmente se le mangia con gli occhi. In particolare, c’è un armonico e ormonico gruppo di adolescenti (ex adolescenti, al momento del racconto) che si costituisce io narrante e che ci conduce per mano in una sorta di indagine sulla vita e sulla morte delle sorelle.
Sì, perché, sappiamo già dalle prime pagine, tutte e cinque le ragazze moriranno suicide nel giro di un anno. Ecco che allora tutto, una volta che già si conosce il finale, diventa importante e può rivelarsi potenzialmente premonitore. In quanto lettori, siamo costretti, volenti o nolenti, a farci detective, psicologi da due soldi, innamorati senza speranze, soprattutto guardoni.
Con il distacco, ma anche la febbrile emozione sotterranea di un archeologo che mostri i suoi ritrovamenti, ci vengono messi davanti agli occhi abiti sgualciti, biancheria intima coperta di graffiti, unghie smozzicate, croste di sbucciature, tampax usati, saponi al gelsomino, pettini, braccialetti, diari intimi, dischi rotti, cartoline, racconti di testimoni, di prima o di terza mano, interviste improbabili, teorie pseudo-psicologiche o oscuramente metafisiche, interviste indiscrete ben oltre il limite della scorrettezza, voci di popolo, odori corporali e segni premonitori.
Il tutto per cercare una risposta.
La fine tragica delle ragazze e l’esigenza interamente umana di un ‘perché’ dovrebbero giustificare ogni morbosità, così come non ci sentiamo morbosi quando guardiamo le immagini proposte e riproposte delle impronte nel sangue di Chiara Poggi, del suo viso rotondo e sorridente di ragazza normale, dell’esterno della sua casa, delle fotografie custodite nel suo computer, mentre ascoltiamo cronisti recitare con voce accorata stralci dei suoi diari intimi, delle sue lettere personali.
Ma, nel caso delle sorelle Lisbon: davvero c’è bisogno di questa risposta? Davvero serve altro, oltre a un presente intollerabile e un’unica prospettiva di fuga gettandosi tra le braccia di un eccitato ragazzino che fatica a distinguere una sorella dall’altra, verso un futuro da ‘regina del focolare’ in una casa simile a quella da cui provengono, davvero c’è bisogno di altre occulte motivazioni per desiderare di infilare la testa nel forno, di lanciarsi giù da un balcone, o di imbottirsi di barbiturici e gin?
E non risulta molesto, urticante quasi, questo esercito narrante che fruga nei cestini della spazzatura in cerca di reperti, che ruba oggetti intimi, liste della spesa, ma anche ricordi ed emozioni, che vuole essere informato a ogni costo, che non si ferma davanti all’imbarazzo o al dolore, come non figurarseli come un branco di jene, come uno stormo di avvoltoi?
Come non chiedersi se non è, almeno in parte, verso di loro che dovremmo puntare il dito, cercando un colpevole?
Le sorelle Lisbon dovranno, alla fine, attirarli con l’inganno dentro casa, illudendoli di averli eletti propri salvatori e di essere pronte, in cambio, a concretizzare le loro fantasie; la conturbante Lux (l’unica che corrisponda davvero al concetto che i ragazzi si sono fatti delle cinque sorelle, l’unica davvero bella e sprizzante malizia) dovrà fingere di essere pronta a concedersi seduta stante a uno – a caso – di loro, e questo soltanto “per tenerli buoni e permettere a lei e le sorelle di morire in pace”.
Difficile non parteggiare per le sorelle Lisbon, non applaudire l’atto estremo con cui hanno sottratto i loro corpi e le loro vite agli sguardi unti della comunità, anche se per farlo hanno pagato il prezzo più alto. Difficile non tornare con il pensiero a Eluana Englaro; dimenticare la rissa in Senato all’annuncio della sua morte, l’onorevole Quagliariello che urlava: “Eluana non è morta, è stata ammazzata”; o le precedenti affermazioni di Berlusconi riguardo al suo essere “ancora bella” e in grado di procreare. Non ricordare gli emetici discorsi sostenuti da diversi uomini sul suo corpo spezzato, sul suo povero guscio, e mi chiedo se sia troppo azzardato supporre che parte di quella rabbia, e del veleno riversato su Beppe Englaro, derivi dal fatto che egli ha sottratto, di fatto, quel corpo agli sguardi, alle polemiche, al voyeurismo di ogni cittadino/spettatore, oltre che ai giochi di potere della classe politica. Non ricordare le insistenze e il malcelato fastidio che hanno accompagnato la decisione di un uomo di non mostrare né fotografie né riprese del corpo martoriato della propria figlia. La gente voleva vedere, reclamava il diritto di posare gli occhi su quel corpo, di indugiare sulle sue deformità, sulle sue piaghe e sulle sue ferite, come se fosse diventato (o fosse sempre stato) proprietà pubblica.
Allo stesso modo, la comunità tratteggiata da Jeffrey Eugenides reagisce con rabbia e sconcerto di fronte ai suicidi delle sorelle Lisbon. La gente, che non si perdeva un dettaglio dello spettacolo della loro caduta, offerto dietro le finestre illuminate, gratis e ancora più succoso perché ‘reale’, che pregustava anni ancora di dramma consumato sotto i propri occhi, si vede inopinatamente spegnere tutte le luci.
La potenza del gesto è così evidente che si evita di parlarne, si teme il contagio, piovono richieste di intervento all’Autorità (al preside della scuola, al governatore, ai giornali), la comunità intera ne è destabilizzata.
Anche se nessuno lo dice apertamente, quello che risulta tanto disturbante è che con quell’atto di suprema ribellione e di disperata arroganza, le sorelle Lisbon si sono riprese i loro corpi. Quei corpi sognati, esplorati, spiati, protagonisti delle fantasie di un intero quartiere non sono più a disposizione.
Il suicidio equivale a un No inequivocabile, inappellabile.
È un atto d’accusa: le sorelle Lisbon si uccidono per dire no a una vita che è morte, si uccidono per una feroce voglia di vivere.
Tutto parla di cancrena, nel tranquillo quartiere abitato dalla middle class americana, e l’autore non ce lo comunica solo con i fatti e le testimonianze, ma, già dalle prime righe, attraverso il sapiente utilizzo di immagini simboliche.
C’è la “misteriosa malattia” che come una piaga colpisce tutti gli alberi del quartiere, ci sono i milioni di insetti che ogni anno invadono la città, oscurandone il cielo, per venire a morire qui, coprendo ogni casa, ogni auto e ogni prato di un manto bruno di carcasse, c’è perfino lo sciopero dei necrofori che, protraendosi per mesi, riempie le celle frigorifere degli obitori di cadaveri in attesa di sepoltura.
Simbolica è sicuramente anche la scelta del titolo, Le vergini suicide, che porta l’eco di antichi riti sacrificali. Considerato che tecnicamente è un errore, o quantomeno una forzatura (Lux non è vergine, al momento della sua morte) e che l’autore non può ignorarlo, non resta che chiedersi quale sia il messaggio che intende veicolare. Se le comunità primitive sacrificavano le vergini per placare l’ira degli dei, il suicidio delle vergini si può leggere come una sorta di oscuro presagio, come confermerebbe questo passaggio: “Con il pas-sare del tempo la gente scordò i motivi personali che potevano averle indotte a quel gesto, le reazioni psicogene, i neurotrasmettitori carenti, per attribuire la loro morte alla capacità di prevedere la rovina. La gente ravvisava quella chiaroveggenza nello sterminio degli olmi, nella luce inclemente del sole, nel declino ininterrotto della nostra industria automobilistica”.
Ma, per quanto suggestiva possa essere questa lettura, non spiega perché l’autore abbia scelto cinque ragazze, e non cinque adolescenti, e le abbia fatte crescere, attraverso pagine e pagine di descrizioni meticolose, fino a trasformarle nell’immagine stessa della femminilità. Soprattutto, gli oscuri presagi non sono giustificati dai fatti che seguono la morte delle sorelle.
Per quanto cambiata, e per sempre marchiata da questa esperienza, la comunità riprende la sua vita, la casa dei Lisbon viene venduta e, dopo interminabili lavori di ristrutturazione, rimessa a nuovo, bonificata dai fantasmi.
Solo i ragazzi, intossicati dalla loro ossessione, invecchieranno senza crescere. Continueranno a ripassarsi tra le mani i ‘reperti’ raccolti, e a guardarli, come prima guardavano le ragazze, dalla stessa incolmabile distanza, con la stessa insanabile incomprensione.
Si convinceranno, alla fine, che “l’essenza di quei suicidi non era la tristezza, non era il mistero, ma un puro e semplice egocentrismo”.
Non faranno il passo successivo. Non realizzeranno che il suicidio è l’unico atto di volontà pura concesso alle sorelle Lisbon.
Schopenhauer affermava (condannandolo) che il suicidio non è una negazione della volontà di vivere, ma piuttosto una sua affermazione. Il suicida non vuole porre fine alla vita in quanto tale, è alla sua vita che dice no.
Lo sguardo allora dovrebbe smettere di cercare nel buio lo spettro delle sorelle Lisbon e chiedersi a quale vita, esse abbiano detto no: posarsi sui prati immacolati, guardare il rapido movimento con cui le tende vengono lasciate cadere, nascondendo chi, al sicuro dietro un vetro, stava a guardare, fermarsi ad ascoltare le parole con cui le madri mortificano le figlie, dimostrando di avere perfettamente interiorizzato un sistema nato per schiacciarle.
Sollevandosi dalla parola scritta, lo sguardo dovrebbe scrutare, con un nuovo disincanto, la nostra realtà, quella che ogni giorno passa sotto ai nostri occhi con colori sempre uguali, così squillanti che teniamo le palpebre abbassate, e nemmeno ce ne rendiamo più conto, di guardare senza vedere.
Cercare i segnali di morte, non nelle malattie degli olmi ma sui nostri muri, coperti di metri e metri di carne femminile esposta, guardare davvero la televisione (non spegnerla, e tantomeno tenerla accesa come confortante rumore di sottofondo, ma fermarci e guardarla) che è diventata la finestra da cui tutti noi vediamo lo stesso paesaggio di corpi femminili spogliati, omologati, mercificati, deprivati di ogni identità, erotizzati attraverso inquadrature porno soft e/o interventi chirurgici per gonfiare le curve che attirano lo sguardo, messi in mostra come nelle vetrine di Amsterdam, anche all’ora di cena, nel più banale dei quiz per famiglie.
Dovremmo parlare della frattura, tra i corpi esposti (che stanno a quelli reali come una bambola gonfiabile sta a una donna vera) e i corpi che guardano, che si eccitano nel guardare, che si mortificano nel guardare, che desiderano e vogliono comprare. Perché si sa che quei corpi sono in vendita. Per possederli o per indossarli, poco importa. Quel che conta è che si sa che si possono comprare, è un sapere ormai condiviso. E allora tutto può essere visto come un colossale spot pubblicitario.
La letteratura dovrebbe abitare questa frattura, e chiedersi, e spingerci a chiederci, quale sia, esattamente, l’oggetto della compravendita.
Chiedersi anche che cosa vede, oggi, una ragazzina di tredici anni, guardandosi attorno, quali prospettive può immaginare per sé, quando l’imperativo, declamato, sussurrato, calato dall’alto, echeggiato dal basso, è uno solo: impara a venderti.
E se non volesse starci?
La piccola Cecilia Lisbon dirà, al medico che, dopo averla salvata dal primo tentativo di suicidio, paternalmente le ricorda che non può sapere ancora “quanto è brutta la vita”: “Dottore, è evidente che lei non è mai stato una ragazza di tredici anni”.
Le vergini suicide,Jeffrey Eugenides, Mondadori, 1994
