Sabrina Campolongo
Recensione di Homo Faber, Max Frisch
Homo faber, l’uomo che fabbrica, in opposizione agli dèi creatori, la statistica contro il fato, tecnica contro natura, questo è il grande conflitto che si dipana lungo le pagine del romanzo di Max Frisch. Per sfuggire alla sua molesta compagnia, oltre che a causa di un malessere ricorrente allo stomaco, Faber cerca di perdere l’aereo approfittando di uno scalo, ma tutto congiura per riportarlo a bordo, dove lo attendono il suo posto vuoto vicino al tedesco e l’esperienza straniante di un’avaria dei motori del velivolo con conseguente atterraggio di fortuna nel bel mezzo del deserto messicano. Durante i giorni di immobilità forzata attorno al cadavere dell’aereo, tra Faber e il tedesco, Herbert, si stabilisce una certa complicità, agevolata dalla comune passione per gli scacchi. Faber scopre così che la destinazione di quest’ultimo è il Guatemala, dove la sua ditta ha impiantato una piantagione di tabacco, al momento gestita dal fratello Joachim; scopre soprattutto che questo fratello è un vecchio amico, di cui ha perso le tracce più di vent’anni prima.
Walter Faber, cinquantenne di nazionalità svizzera, ma abitante a New York nel 1956, anno in cui si svolge la narrazione, è il rappresentante perfetto del positivismo: appassionato di tecnologia, gira il mondo per lavoro, non legge romanzi – non capisce proprio il bisogno di aggiungere finzione alla realtà – l’arte non lo impressiona, il passato non lo affascina se non come esperienza dalla quale attingere per progredire, la natura lo interessa soltanto come complesso di fenomeni misurabili e analizzabili, gli altri esseri umani lo affaticano. Per questo preferisce osservare i motori dell’aereo su cui sta viaggiando da New York a Caracas, dove dovrà controllare certe turbine nella sua qualità di tecnico al servizio dell’Unesco, piuttosto che parlare con il vicino tedesco, che pur avendo una faccia ‘già vista’ non gli è simpatico, a pelle, e non solo perché legge un romanzetto tascabile.
In conversazioni successive, Faber apprende anche che Joachim ha sposato Hanna, la donna di cui Faber è stato innamorato, prima di perderla di vista nel 1936, dopo averle consigliato di abortire il loro bambino; in aggiunta, viene a sapere che Joachim, che ha divorziato da Hanna, al momento vive solo nella giungla con gli indios e non dà più notizie di sé da mesi. Un altro vedrebbe in questa incredibile concatenazione di accadimenti un’eclatante trama del destino, ma non Faber. Per lui si tratta solo di coincidenze, perfettamente spiegabili con le leggi della probabilità.
Walter Faber è un uomo che viaggia per il mondo intero con un rasoio elettrico e nessuna lametta, sebbene soffra di un fastidio al tempo stesso fisico e mentale quasi insopportabile, quando non riesce a rasarsi. Un dettaglio già da solo illuminante sulla personalità di questo tecnico, di questo ingegnere: la sua fiducia totale nelle macchine e in un mondo tecnologico in cui non può venire a mancare una presa di corrente, in aereo come in un hotel di Caracas, così incrollabile che non pensa nemmeno a soluzioni alternative. Eppure, per la prima volta, fa una scelta fuori dagli schemi: rientrato all’aeroporto grazie ai soccorsi, invece di proseguire per Caracas dove le sue turbine l’aspettano, decide di seguire Herbert in Guatemala, per rivedere Joachim.
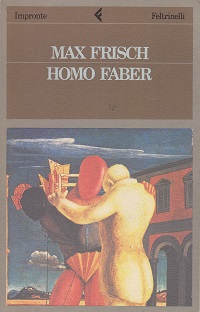
La morte e la riproduzione sono strettamente legate, nella mente di Faber, e il nodo è evidentemente la donna. “La melma schizzava da tutte le parti mentre passavamo nelle pozzanghere nell’aurora – a un certo punto Marcel disse: «Tu sais che la mort est femme!» Io lo guardai «Et que la terre est femme!» disse e quell’ultima frase la capii, perché proprio di questa aveva l’aspetto, e risi forte, senza volerlo, come di un’oscenità.”
Una volta risvegliato, il fantasma di Hanna lo segue, con il tintinnare di catene dei dubbi rimasti senza risposta, delle passate inadeguatezze e incomprensioni, forse del rimpianto. Il viaggio alla ricerca di Joachim è lento e primitivo, osteggiato dall’arretratezza delle terre attraversate, dai ritmi arcaici dei loro abitanti, da una natura arrogantemente presente, indomita, che soggioga Faber e lo respinge allo stesso tempo. “Mi davano ai nervi: le salamandre in ogni pantano, in ogni pozzanghera, un brulichio di salamandre – e in genere quest’orgia di riproduzione dovunque, puzza di fertilità, di putrefazione rigogliosa.”
Non sorprende che Faber non abbia amicizie femminili: nel suo mondo la donna ha spazio solo all’interno di ruoli circoscritti: amante/moglie/madre/figlia. Nel 1936 ha chiesto ad Hanna di sposarlo, perché lei era ebrea e lui desiderava proteggerla dandole un passaporto svizzero, e perché aspettava un figlio da lui – sebbene Faber le avesse parlato del nascituro come del tuo bambino, non il nostro, mentre le consigliava di rivolgersi all’amico Joachim, in quanto medico, per aiutarla a gestire la faccenda. Hanna però non ci è stata, all’ultimo ha rifiutato di sposarlo, e Faber non ha ancora capito il perché. Non essendovi una spiegazione razionale, dal suo punto di vista, il fatto rimane un mistero, come rimane un mistero perché né Hanna né Joachim gli abbiano mai comunicato di essersi poi sposati.
Il vecchio amico non può essere di nessun aiuto nello svelare l’arcano, dal momento che quando finalmente arrivano alla piantagione di tabacco lo trovano che pende da una trave della sua baracca, chiusa dall’interno. Anche le ragioni del suicidio sono avvolte dal mistero, ma Faber non mostra un particolare interesse nel decriptarle, dal momento che la causa della morte è, invece, sotto ai suoi occhi, perfettamente spiegabile.
Tornato a New York, dopo aver chiuso in modo piuttosto goffo la relazione con la sua amante, Ivy, Faber si imbarca su una nave per l’Europa, dove lo aspettano – a Parigi – di nuovo per lavoro. Questa volta evita l’aereo, non certo per paura di un nuovo incidente – le probabilità sarebbero ridicole – quanto per lasciarsi alle spalle New York e Ivy, verso la quale prova ormai un generale fastidio in cui si intromettono, per brevi istanti, lampi di lussuria o di tenerezza. Il viaggio, non come scoperta ma come puro movimento, sembra avere un ruolo centrale nella sua esistenza; l’uomo tecnologico non si ferma mai, non c’è un luogo che possa chiamare casa. L’appartamento di New York è un puro punto di transito, nel quale si ferma per brevi pause tra un viaggio e l’altro, non vede la Svizzera da anni, la sua vita è scandita da scadenze minuziosamente appuntate, che punteggiano la sua prosa spezzata, telegrafica, ridotta all’essenziale, quasi come se temesse di aggiungere qualcosa alla realtà, mettendo in relazione le frasi.
“Odiavo anche me stesso –
Ivy canticchiava, come per sfottermi.
Le avevo scritto che era finita e lei aveva
la mia lettera in tasca (lo capivo) –
Adesso si vendicava.”
Nel corso della traversata, Faber conosce Elisabeth, che ribattezza Sabeth, una ragazza che lo colpisce, nonostante sia probabilmente troppo giovane per lui, forse perché in qualche modo gli ricorda Hanna. Tra i due nasce un’intesa quasi immediata, che sfocia in una relazione sentimentale, dopo lo sbarco a Parigi e durante un successivo ‘viaggio di nozze’ verso il sud della Francia, l’Italia e quindi la Grecia. Sabeth è, in realtà, la figlia di Hanna e dello stesso Faber, verità che lui scopre solo a incesto consumato, ma che il lettore apprende quasi subito, come se Frisch abbia sentito il bisogno di mettere in chiaro che il suo intento non è quello di far salire la tensione attorno all’incesto, ma al contrario di depotenziarlo della sua carica simbolica, per ricondurlo al mito di Edipo prima di Freud: la prova dell’ineluttabilità del Fato.
È evidente, e non solo perché continua a ripeterselo, che Faber non poteva in nessun modo immaginare che Sabeth fosse sua figlia, né la logica né la statistica e nemmeno la comune morale possono condannarlo per essersi innamorato di una sconosciuta incontrata a bordo di una nave. Il destino si prende gioco dell’homo faber e delle sue illusioni di controllo sul mondo. Sabeth, perfetta rappresentazione della gioia di vivere, per un certo tempo sembra riuscire a strappare Faber al suo rassegnato disincanto, alla sua tranquilla disperazione, conducendolo, timoroso ma disponibile come mai prima di allora, nel suo mondo fatto di entusiasmi, libertà e bellezza. Ma, come conclude Sofocle nel suo Edipo Re, non si può giudicare un uomo felice prima che abbia “della vita il cammin tutto compiuto”.
La tragedia è infatti dietro l’angolo. Sabeth muore, dopo essere stata morsa da un serpente su una spiaggia greca, sebbene la causa della morte non sia il veleno – combattuto con un siero grazie alla rocambolesca corsa di Faber verso l’ospedale – ma il colpo in testa preso cadendo, mentre, confusa dal morso, cercava di sfuggirgli. Nel frattempo Faber ha scoperto che Sabeth è figlia di Hanna, ma ancora, per un meccanismo di negazione a questo punto, si rifiuta di credere che sia anche figlia sua.
Hanna e Faber si ritrovano al capezzale di Sabeth (che Hanna chiama Elsbeth, come a voler suggerire che la figlia e l’amante sono, in fondo, due persone distinte), accomunati dall’amore per la ragazza, ma ancora incapaci di capirsi. Hanna è diventata una madre totalmente consacrata al suo ruolo, che ama Elsbeth di un amore così assoluto che, forse temendo di gettarvi un’ombra mettendo al mondo un altro figlio, dopo di lei aveva scelto di farsi sterilizzare. Oppure, la sterilizzazione potrebbe invece essere il simbolo di un’istanza del tutto diversa: non più madre, non più moglie, non più amante di nessuno (vive sola), forse Hanna ha voluto abdicare da ogni ruolo impostole dagli uomini. Faber la chiama, con ironia, “proletaria della creazione”.
“Trova stupido da parte di una donna voler essere compresa da un uomo; l’uomo (dice Hanna) vuole la donna come mistero, per entusiasmarsi ed eccitarsi della propria incomprensione. L’uomo ascolta solo se stesso, secondo Hanna, perciò la vita di una donna che vuol essere compresa da un uomo è inevitabilmente sciupata. […] L’uomo vede se stesso come signore del mondo, e la donna come suo specchio. Il signore è costretto ad apprendere la lingua degli oppressi; la donna è costretta ad apprendere la lingua del signore, ma non le serve a niente, al contrario, impara una lingua che le dà sempre torto.”
Nell’opposizione uomo-donna, così espressa da Hanna, si riflette quella tra progresso e destino, tra tecnica e natura, tra l’illusione dell’immortalità, affidata al progresso della scienza, e la certezza terrena dell’impermanenza. Marchiato dalla morte – non solo quella di Sabeth ma anche la propria, visto che il fastidio allo stomaco che compare dalla prima scena si rivela essere la manifestazione di un cancro – Faber riscopre la terra, la vita, forse anche una forma dolente di gioia. La prosa, ancora spezzata, si fa poetica, palpitante:
“Valli nella luce obliqua del tardo pomeriggio, pendii in ombra, burroni nell’ombra, i torrenti bianchi sullo sfondo, pascoli nella luce obliqua, mucchi di fieno, arrossati dal sole, una mandria in una conca piena di pietrame, al di sopra del limite dei boschi: come larve bianche di insetti! (Sabeth naturalmente le battezzerebbe altrimenti, ma non so come.) La fronte contro il finestrino freddo, con pensieri oziosi –
Desiderio di sentir odor di fieno!
Mai più volare!
Desiderio di camminare sulla terra – là sotto gli ultimi abeti ancora illuminati dal sole, respirarne l’odor di resina e udire l’acqua, probabilmente un rombo, bere acqua –
Tutto fugge come in un film!
Desiderio di afferrare la terra.”
Così, la luce emanata dalla croce piantata sulla cima della montagna, quando viene colpita dai raggi del sole al tramonto, è bellissima ma “del tutto solitaria”, dal momento che nessun uomo può vederla, nessuno può trovarsi a quell’altitudine al calar del sole, se non vuole rischiare di non riuscire più a scendere, ma allo stesso tempo rimane bellissima, e Faber si rende conto che sarebbe pronto a pagare con la morte la visione di una tale luce, proprio lui che trovava che “la luna sopra il deserto di Tamaulipas – più chiara che mai, può darsi [fosse] sempre una massa commensurabile, che rotea attorno al nostro pianeta, una questione di gravitazione, interessante, ma perché emozionante?”
Nelle ultime righe del romanzo, mentre aspetta i medici che vengano a prenderlo per operarlo o per fingere di farlo, Faber dice di se stesso “che distrugge tutto”. Parla, certo, della morte di Sabeth, di cui a questo punto si sente responsabile, ma, dopo duecento pagine in cui ha chiamato a raccolta una moltitudine di teorie scientifiche per dimostrare la propria innocenza, la sua assunzione di responsabilità non può che essere più vasta. Come Edipo, Faber non ha nessuna colpa, ma allo stesso tempo non è innocente. Quello di cui si accusa è di non aver saputo sorprendersi, di non aver saputo gioire della gravidanza di Hanna vent’anni prima, di non aver saputo dire il nostro bambino, di non aver saputo vedere altro che una formazione rocciosa in una montagna, la colpa della propria cecità, del proprio fallimento umano.
Homo Faber, Max Frisch, Feltrinell, 1959


