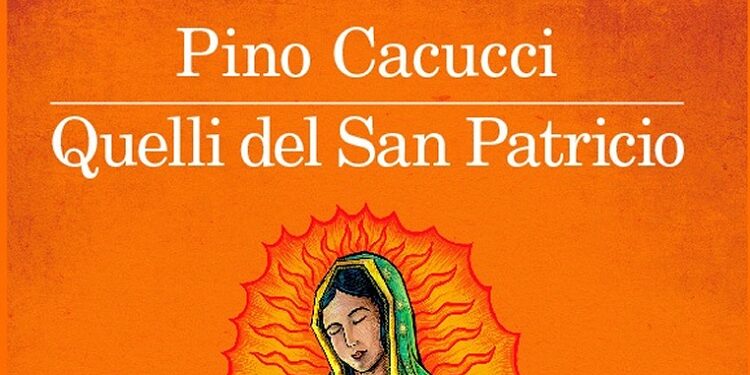Intervista di Giuseppe Ciarallo
La definizione che più si attaglia a Pino Cacucci è quella di ‘scrittore libertario’, non solo per le simpatie che l’artista alessandrino di nascita e bolognese di adozione ha sempre mostrato per l’ideale libertario, ma anche per le tematiche delle sue opere letterarie, sempre dense di impegno sociale e in qualche modo ‘pedagogiche’, atte a far conoscere al pubblico dei lettori personaggi della storia del passato ripescati dal dimenticatoio in cui sono stati relegati, e riproposti ridando loro lo spazio e la dignità che meritano.
Negli anni Cacucci ha raccontato le vite di Tina Modotti, fotografa e militante comunista italiana trasferitasi in Messico, le cui vicende sono legate in qualche modo anche all’assassinio di Lev Trockij (Tina, Interno Giallo, 1991), del bandito anarchico Jules Bonnot, nella Francia della Belle Epoque (In ogni caso nessun rimorso, Longanesi, 1994), di Guido Picelli, fondatore delle Guardie Rosse e degli Arditi del Popolo, eroe della battaglia di Oltretorrente a Parma che alla testa dei suoi uomini nel 1922 fermò l’avanzata delle squadracce fasciste guidate da Italo Balbo (Oltretorrente, Feltrinelli, 2003). E poi Horst Fantazzini (Nessuno può portarti un fiore, Feltrinelli, 2012), Frida Kahlo (Viva la vida!, Feltrinelli, 2010), e nel libro Ribelli! (Feltrinelli, 2001) Sacco e Vanzetti, Alexandre Marius Jacob, Clément Duval, Sante Pollastro, Louis Chabas. Fino al suo ultimo lavoro Quelli del San Patricio (Feltrinelli, 2015) nel quale viene narrata la storia di John Riley e di un nutrito manipolo di soldati, perlopiù irlandesi, che inquadrati inizialmente nelle file dell’esercito statunitense impegnato nella guerra di conquista del Messico, disertano per unirsi alle resistenti truppe messicane pur consci della sproporzionata superiorità delle armate yankee.
Dunque Pino, in questo tuo ultimo lavoro riproponi una tematica a te molto cara: quella della sconfitta, una sconfitta sempre prevedibile, anzi sempre prevista dai protagonisti delle storie che racconti. Nessuno dei tuoi ‘eroi’ ha potuto assaporare la vittoria (tranne forse Picelli, ma si trattò di un trionfo provvisorio, come sappiamo) né ha mai sperato in cuor suo di poter vincere, pensiamo a un Jules Bonnot, e questo rende quasi mitologica la loro capitolazione.
Un artista e militante rivoluzionario messicano nei primi decenni del ‘900 disse: “La cosa peggiore che possa accadere ai rivoluzionari è di vincere la rivoluzione”; l’asserzione conteneva una buona dose di autoironia, e si riferiva al fatto che la ‘vittoria’ comporta la presa del potere e quindi la gestione – quasi sempre in modo dispotico o quanto meno autoritario – delle mille incombenze che ne conseguono. Forse è soprattutto per questo che prediligo le storie di ribelli, cioè persone che senza darsi uno scopo supremo, semplicemente considerano inaccettabile una certa situazione di ingiustizia e sopruso, e quindi combattono, più che per un ideale, per una causa immediata: vendicarsi delle carogne che hanno rovinato la vita a tanti solo per ricavarne privilegi abominevoli. In effetti gli ‘eroi’ di cui racconto le vite e le imprese sono votati alla sconfitta e spesso lo sanno fin dall’inizio delle loro rivolte, ma non sono ‘vinti’, cioè restano indomiti e non si rassegnano a chinare la testa, malgrado l’ineluttabilità della sconfitta. In fin dei conti, perdono tutto, la vita stessa, ma conservano quello che considerano il bene supremo: la dignità.

Ma veniamo a Quelli del San Patricio. Quando e come ti capita tra le mani questa storia? E quali sono state le tue fonti di documentazione?
Frequentando il Messico da oltre trent’anni, la memoria degli irlandesi del Battaglione San Patricio l’ho ritrovata viva in diverse occasioni, a Città del Messico ogni anno si tengono commemorazioni a cui partecipano rappresentanti dell’ambasciata irlandese e la famosa Banda de gaitas Batallón San Patricio, per lo più giovani sia maschi che femmine che suonano cornamuse e tamburi – molti di loro sono discendenti di irlandesi e scozzesi – e soprattutto a Coyoacán, non distante dalla Casa Museo di Frida Kahlo e dalla Casa Museo di Trockij, c’è l’ex convento fortificato di Churubusco, dove avvenne l’ultima battaglia prima della caduta della capitale nelle mani dell’esercito di invasione statunitense, trasformato in museo delle invasioni subite, e molte sale sono dedicate a quella guerra e ai San Patricio.
Poi ci sono lapidi con alcuni dei loro nomi (addirittura nella Camera dei Deputati gli irlandesi figurano tra i nomi degli “eroi della patria messicana” incisi a lettere d’oro) e un busto di John Riley nella piazza dove allora avvennero le impiccagioni e i supplizi. Insomma, il Messico non li dimentica e ne rinnova costantemente la memoria. Poi, una decina di anni fa, decisi di compiere ricerche approfondite per capire se sarei stato in grado di ricostruire non solo le battaglie e i retroscena della guerra, ma anche e soprattutto la vicenda umana di John Riley, emblematica di una realtà di migranti fuggiti dall’Irlanda per la fame e le vessazioni della dominazione inglese, migranti che erano comunque ribelli da generazioni (il mio romanzo, in fondo, è una storia di emigrazione…). E molto mi hanno aiutato amici messicani che di storie del genere ne sanno non poco, come Paco Taibo II e suo fratello Benito, che mi hanno procurato diversi volumi di memorie di ufficiali messicani che combatterono quella guerra o testi di storiografi dell’Ottocento; e non pochi materiali li ho trovati proprio nel museo di Churubusco, dove in questi ultimi dieci anni ho trascorso diverse giornate.
Mi sono sempre chiesto, e giro la domanda a te non essendo mai riuscito a trovare una risposta convincente: come è possibile che gli Stati Uniti d’America siano riusciti, a livello mondiale, a far passare un’immagine di se stessi nei panni di portatori universali di pace e democrazia, vista la loro storia lastricata di cadaveri e di sangue, soprattutto altrui.
Credo che la loro forza maggiore stia nella capacità di comunicazione, ‘conquistare le menti e i cuori’, o meglio di controllo della comunicazione su vari livelli e innumerevoli mezzi, e l’hanno consolidata dalla seconda guerra mondiale in poi, quando hanno esteso il dominio sull’Europa (e dimostrando il talento di saper instillare in quella parte dell’Est non ancora assoggettata, il ‘sogno americano’ che era essenzialmente un inganno per i più e un osceno arricchimento per pochi, come di fatto accade oggi, che i Paesi dell’Est sono diventati ‘democratici’, fermo restando che i loro avversari, i miserabili stalinisti che hanno trasformato a loro volta il sogno del ‘comunismo’ in un incubo, hanno spianato la strada all’american dream). Questo grazie al fatto che agli occhi di tutti apparivano come i vincitori della ‘guerra giusta’ (e per certi versi lo era: sconfiggere il nazifascismo era indubbiamente encomiabile e urgente), però anche su questo occorrerebbe conoscere tanti retroscena e le vere motivazioni, tutt’altro che ‘democratiche’: consiglio al riguardo un saggio illuminante, Il mito della guerra buona. Gli Usa e la seconda guerra mondiale, dello storico belga Jacques R. Pawels, che sfata ogni mito al riguardo.
Ma non dobbiamo ignorare che mentre questa immagine regge in Europa, in America latina solo le élite delle oligarchie la propagandano; i governi genuinamente democratici di tanti Paesi latinoamericani di questi ultimi anni dimostrano che quei popoli non ci hanno creduto affatto, e hanno ben chiaro che per loro c’è sempre stato ‘l’incubo americano’ (anzi, estadounidense, perché a quelle latitudini rivendicano giustamente il nome America per tutti i Paesi del continente dove tutti gli abitanti sono americani). Persino in Messico, dove i politici che si sono succeduti al potere da un secolo a questa parte hanno sempre fatto gli interessi di Washington, sussiste una cultura (che non è solo di intellettuali ma anche ‘popolare’ nel senso migliore del termine) che coltiva la memoria degli innumerevoli soprusi subiti dagli Stati Uniti, a partire dalla guerra di invasione che strappò oltre la metà del territorio nazionale. La guerra in cui un pugno di irlandesi diede filo da torcere e versò il proprio sangue accanto a decine di migliaia di soldati messicani e guerriglieri (tra i quali non furono poche le donne), in difesa della dignità contro entrambi i nemici: gli invasori statunitensi e i corrotti e codardi generali messicani.
La corruzione… scorrendo le pagine del tuo romanzo pensavo a quanto la letteratura riesca a universalizzare i messaggi che lancia. Leggi Santa Anna, generalissimo dell’esercito messicano nell’Ottocento e poi Presidente della Repubblica, e pensi alle decine e decine di capi di Stato che nel mondo, nell’ultimo secolo hanno abdicato la sovranità nazionale, per meri interessi personali economici o di potere, agli Stati Uniti, cedendo loro, di fatto, il potere su questioni vitali per un popolo, come quelle economiche, commerciali, militari e di sicurezza…
Oggi molto più che allora, se ci riferiamo al Messico – perché altri Paesi del continente americano, come dicevo, stanno dimostrando una notevole difesa della sovranità nazionale. L’immane flusso di denaro prodotto dal narcotraffico (che supera persino quello del petrolio) inquina e corrompe tutto, in primo luogo la politica. L’ambizioso e camaleontico Santa Anna ne fu il prototipo e l’antesignano: governante che si illudeva di fregare gli uni e gli altri (gli Usa e il popolo messicano) e finì per ingannare solo quest’ultimo. Oggi il problema non si pone: sanno già chi è più facile truffare (non senza scatenare rivolte, il Messico è costantemente in rivolta e il sangue scorre senza sosta). La guerra di invasione del 1846-48 sancì che chiunque ostacolasse gli interessi degli Stati Uniti poteva essere invaso, bombardato, o semplicemente assassinato, magari con sofisticati ‘incidenti aerei’; da quando i capi di Stato si spostano via aria, la casistica è talmente ricca di tali episodi che le statistiche dovrebbero decretare che gli aerei presidenziali sono il mezzo di trasporto meno sicuro della storia (noi ne sappiamo qualcosa con la strage di Ustica, raro caso di piano fallito che doveva abbattere Gheddafi sui nostri cieli).
Leggendo Quelli del San Patricio mi ha fatto sorridere la presenza di Ciro, l’infallibile cecchino napoletano. È un personaggio inventato, funzionale alla storia, o hai trovato tracce documentali della presenza di un nostro connazionale particolarmente bravo con le armi?
L’unico dato certo, che ho riscontrato in diversi libri di memorie di reduci messicani, è che nel battaglione San Patricio c’erano almeno tre italiani. Non sono riuscito a trovare alcun nome, quindi ho inventato il personaggio di Ciro, emblema di quei tre senza nome. Del resto, le guerre di liberazione e le rivoluzioni dei Paesi latinoamericani hanno visto la partecipazione di tanti ribelli italiani, che in tanti casi erano ‘avventurieri’, come si usava dire allora. Lo stesso Garibaldi, per molti era solo un avventuriero, mentre per tanti altri era mosso da ideali.
E a proposito di Garibaldi: è molto più ricordato in America latina che in Italia (compreso il Messico dove non combatté, ma in compenso un suo nipote, Peppino, fu al fianco di Pancho Villa, con alterne vicende perché un giorno i due fecero a pugni… ma poi si riconciliarono con le lacrime agli occhi al cospetto del presidente Francisco Madero).
È corretto pensare a quelli del battaglione San Patricio come a degli antesignani delle Brigate Internazionali che combatterono a fianco dei repubblicani nella Guerra di Spagna o il paragone è improprio?
A me sembra storicamente logico paragonare il battaglione San Patricio alle Brigate Internazionali in Spagna, tanto che io stesso nel libro lo definisco “una brigata internazionale della dignità”. Mentre gli Stati Uniti tentarono di definirli “legione straniera”, insinuando che fossero mercenari, loro assunsero quel nome e quella bandiera per sancire che erano combattenti volontari dalla parte degli aggrediti e contro gli aggressori.
Il fatto che, tra la maggioranza di irlandesi, vi fossero tedeschi, polacchi, scozzesi, spagnoli, francesi, persino non pochi ex schiavi africani fuggiti nel Paese – il Messico – che per primo abolì la schiavitù, non può non rimandare alle Brigate della Guerra di Spagna. In quanto ai ‘mercenari’, quelli ci furono, eccome: le milizie di ‘volontari’ degli Stati del Sud dell’Unione, primi fra tutti i ranger del Texas (ma anche tanti tagliagole del Nord, come quelli calati da New York), parteciparono alla guerra di invasione per poter depredare, saccheggiare e stuprare.
Il numero di civili messicani uccisi da quelle milizie di mercenari resta uno dei dati in sospeso della Storia, ma è lecito usare il termine ‘genocidio’ perché fu un immane massacro.
Nel nome di Dio, così come avevano già fatto nel corso delle cosiddette guerre indiane, i soldati statunitensi non si fecero troppi scrupoli nello sterminare anche donne e bambini messicani per ‘liberare’ quei territori che la Bibbia dichiarava essere destinati per volontà divina allo sfruttamento, e che a loro avviso erano impropriamente occupati da una popolazione pigra, dissoluta e improduttiva. Come spesso succede, nel passato come oggi, Dio viene sempre tirato in ballo per motivi che hanno a che fare con il denaro più che con la spiritualità. Inoltre, nella storia che racconti possiamo intravvedere, in nuce, i principi di un capitalismo liberista che nel tempo diventerà sempre più vorace e aggressivo…
I monoteismi sono la vera tragedia dell’umanità: tutti contrabbandano un Dio misericordioso e giusto, e intanto lo usano per massacrare gli altri… ma la religione è sempre stata e continua a essere un pretesto per la conquista, come fecero gli spagnoli in Messico cinque secoli fa e come fanno oggi i tagliagole dell’Isis. Senza però dimenticare – parlando della storia della Conquista del Messico – che vi furono non pochi spagnoli che preferirono il Vangelo alla Bibbia e si schierarono dalla parte degli indios (esempi da non dimenticare come Bartolomé de Las Casas in Chiapas e Vasco de Quiroga nel Michoacán, acerrimi oppositori del potere militare e coloniale di allora). Riguardo gli Stati Uniti, a metà dell’Ottocento usarono persino il pretesto della religione, per convincere la loro opinione pubblica che i messicani andavano assoggettati e resi schiavi. “Nel nome di Dio” mi ricorda il “Gott Mit Uns” che le SS portavano inciso sulla fibbia del cinturone della divisa… Ma in entrambi i casi era solo il becero pretesto per aizzare le proprie schiere e schiacciare gli altri. Eppure già allora – non dimentichiamolo – negli Usa c’era una coscienza critica, con casi come quello di Henry David Thoreau che si fece arrestare per le proteste contro la guerra di invasione, e arrivando ai giorni nostri, uno degli scrittori che più amo, Cormac McCarthy, ha scritto più volte nei suoi romanzi che la sua è una nazione sorta dalla violenza e dal genocidio, dunque…
Tra le tue tante attività (sei scrittore, sceneggiatore, giornalista, fotografo) quella a cui sei particolarmente legato è la traduzione. Oramai vai quasi per il centinaio di titoli della letteratura spagnola e latinoamericana tradotti. Rendendomi conto, da profano, della delicatezza di questa operazione, mi sono sempre chiesto quale sia il corretto atteggiamento che il traduttore deve avere nei confronti dell’opera che si appresta a tradurre e dell’autore della stessa. È necessario, per il traduttore, tenere a bada il proprio ego (per evitare il rischio di dare all’opera un’impronta troppo personale), o è un pericolo che non si corre? Tu ti sei dato delle regole, anche ‘morali’, nell’affrontare questa affascinante attività?
Tradurre è ormai il mio ‘mestiere principale’, non solo considerando il tempo che gli dedico ma soprattutto alla passione con cui lo faccio. Tradurre è anche il miglior mezzo per conoscere scrittori e scrittrici che stimo, ai quali ormai mi lega un rapporto di amicizia che va oltre gli episodi di traduzione di ogni loro singolo libro. L’unico caso in cui non ho potuto instaurare un rapporto personale, è stato con un ‘certo’ Ernesto Guevara: traducevo i cosiddetti Diari della motocicletta, quando con l’amico per la pelle Alberto Granado percorrevano l’America latina, e vivevo assieme a lui le vicissitudini di un giovane avventuroso che pur essendo già dotato di un incrollabile ideale, era di fatto un ragazzo incline a fare le tipiche azioni scapestrate e divertenti di chi ha vent’anni o poco più: ogni tanto, traducendo, mi veniva in mente che non avrei mai potuto conoscerlo e questo mi sembrava strano, visto che con tutti gli altri l’avevo sempre fatto… Traducendo, più che regole, seguo l’istinto, senza mai dimenticare che va rispettato il ritmo, l’identità, le scelte narrative di ogni singolo autore, e se da un lato l’essere scrittore mi aiuta a trasmettere emozioni nella mia lingua, dall’altro presenta l’insidia della tentazione di scrivere alla mia maniera (un esempio banale: l’autore tradotto che usa le ripetizioni volutamente, o una
certa costruzione della frase che io avrei costruito in altro modo… be’, è lì che devo mettermi da parte e rispettare le scelte di chi sto traducendo). Credo che nella traduzione non esistano regole precise, occorre stare sempre all’erta per impedire al proprio modo di narrare di prevalere sul modo di narrare altrui.
Per concludere, la domanda di rito riguarda i tuoi prossimi impegni… Hai già pensato a un nuovo personaggio da raccontare?
Per ora ho, per fortuna, traduzioni in corso: il secondo romanzo del messicano Jorge Zepeda, altro caso di amicizia nata dalla traduzione del primo libro (ci siamo visti varie volte a Città del Messico e ormai ci sentiamo anche per commentare le cose della vita) e un nuovo romanzo dell’argentina Claudia Piñeiro, che stimo molto e che non ho ancora incontrato di persona ma con la quale ho un lungo rapporto epistolare. Riguardo eventuali mie nuove storie… di personaggi ne avrei, da raccontare, ma per il momento aspetto. Quien sabe.
* Qui non si arrende nessuno!