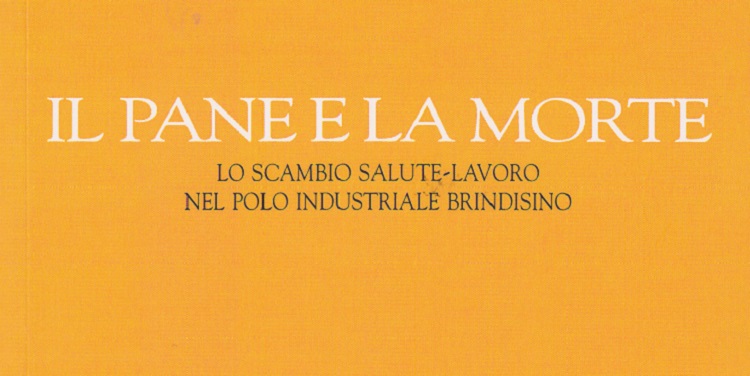Il ricatto salute-lavoro: inquinamento e tumori in cambio di un salario
Incontro-dibattito sul libro Il pane e la morte. Lo scambio salute-lavoro nel polo industriale brindisino a cura di Renato Curcio (Quaderni di ricerca sociale, Sensibili alle foglie) presso l’Ambulatorio medico popolare (Milano), 5 luglio 2014
“Meglio morire di cancro che di fame”: è una frase che a Brindisi pronunciano ancora, e ci porta indietro negli anni Sessanta e Settanta, a Marghera, quando molti operai del polo chimico che provenivano da paesi dicevano: “Meglio morire con la pancia piena che con la pancia vuota”. È una specie di gergo, di razionalizzazione di una situazione di ricatto che le persone vivono e a un certo punto normalizzano. Il tema della salute in relazione al mondo del lavoro è relativamente recente: si inizia a parlarne solo negli anni Settanta, grazie a Giulio Maccacaro, medico e grande ricercatore, che comincia a interessarsi seriamente del problema a Castellanza, dove esiste una forte presenza industriale inquinante: la Montecatini. È un importante cambiamento di prospettiva, perché fino a quel momento la salute era rimasta sempre sullo sfondo, anche sul piano del conflitto sociale, a causa di una grave carenza culturale della storia del movimento operaio italiano, che in tutto il dopoguerra ha immaginato e costruito i suoi percorsi di lotta prevalentemente intorno a temi economici.
Eppure già in quegli anni era chiaro che nelle sue strategie produttive lo sviluppo industriale italiano, e quindi la grande industria italiana, aveva messo in conto la morte di moltissimi lavoratori; tant’è che la morte era silenziosa, non appariva sul terreno sociale. La Montecatini poi è importante perché tutti i poli industriali, che vennero costruiti intorno agli anni Sessanta, ne hanno raccolto l’eredità, ed era un lascito criminale, perché la Montecatini era un’industria chimica criminale – e uso il termine in senso tecnico, non a effetto politico. Già negli anni Venti operava a Cengio ed era contestata in maniera violentissima dalla popolazione di tutta la valle, non solamente dagli operai della fabbrica. Stiamo parlando di un’azienda che si alleò con la Farben – un’industria chimica tedesca nota agli storici perché produceva lo Zyklon B, il gas utilizzato per lo sterminio, e perché fu la prima a trasferire i suoi lavoratori dentro i campi di concentramento – la quale impose di applicare in modo rigoroso le leggi razziali del 1938; la Montecatini a quel punto, per affrontare in maniera drastica la situazione, come era d’uso fare all’epoca rispetto alle lotte operaie, formò dei reparti razziali in cui trasferì anche gli operai sindacalizzati e rivoltosi, persone che poi vennero inviate nei campi di concentramento. La Montecatini era quindi un’industria che non indietreggiava di fronte a nulla, e nel dopoguerra mantenne la stessa politica nella costruzione dei poli chimici a Marghera e poi al sud Italia.
L’espansione nel meridione iniziò nel 1960, quando la politica cominciò a discutere sull’industrializzazione del sud – una grande bufala, nel senso che fino a quel momento il territorio era stato spogliato di tutte le sue risorse, comprese quelle lavorative – e soprattutto quando il conflitto sociale, che a Cengio era continuato anche nel dopoguerra e aveva cominciato a manifestarsi anche a Porto Marghera, iniziò a divenire insostenibile. Si pensò quindi di trasferire nel meridione le lavorazioni nocive, e tra queste ve ne era una di straordinaria importanza per quegli anni: la lavorazione della plastica. Un processo industriale che utilizza il cloruro vinile monomero, una sostanza altamente tossica e tumorale; in altre parole, una sostanza che uccide.
Una nocività che nel 1960 era ampiamente nota alla comunità scientifica internazionale, poiché già nel 1949 era stato pubblicato un saggio, prima in Unione sovietica e poi riconosciuto in tutto il mondo, che trattava proprio la questione della pericolosità della lavorazione del cloruro vinile monomero per la salute delle persone. È vero che in Italia il livello culturale della comunità scientifica non era particolarmente brillante, nel senso che quei pochi che indagavano seriamente questi temi all’interno dell’università erano al servizio della grande industria ed è solo alla fine degli anni Sessanta, primi anni Settanta, che iniziano a uscire dall’accademia delle figure che si contrappongono a questo schieramento apertamente di classe; ma è anche vero che alcuni medici di base, interni alla stessa Montecatini, soprattutto nel polo di Livorno dove c’era la Solvay, e più di tutti un medico che si chiamava Cesare Maltoni, avevano iniziato a diffondere informazioni sulla nocività di questa sostanza e sulla sua pericolosità per la vita dei lavoratori. Quindi si conosceva la realtà della situazione quando vengono costruiti i poli industriali. Eppure in una città come Brindisi, che dal 1960 è stato uno dei centri più importanti per la lavorazione del cloruro vinile monomero, non è mai stata detta una parola sulla sua nocività.
Un cantiere sociale non è un luogo di interviste ma un luogo che parte dall’idea, ormai molto trascurata, che i migliori conoscitori di un contesto sono coloro che lo vivono e lo frequentano abitualmente; solo chi vive un problema, in questo caso una situazione tragica perché si confronta con la morte, è anche colui che ne conosce l’anima e il senso, l’esperienza. Questo cantiere è nato dall’incontro con un epidemiologo molto importante che lavora a Brindisi, Maurizio Portaluri, e con alcuni operai di quella generazione che ha iniziato la storia del polo industriale, ancora vivi ma tutti malati di cancro.

I vecchi lavoratori sono stati molto importanti perché volevamo ricostruire la storia del polo chimico, non come storia della grande industria che si può leggere su qualche libro ma come storia di chi l’ha attraversata, fatta, costruita, e caso mai ci è anche morto; una vecchia generazione che ha vissuto la fabbrica dalla nascita, nel 1960, fino al 1974, persone che erano già organizzate nel “Comitato di difesa delle vittime del petrolchimico”, che ha costruito relazioni con 300 ex lavoratori, in parte morti e in parte ammalati di tumore. È importante anche la storia di questo comitato, perché è nato dal trauma di uno di loro, un operaio che per tantissimo tempo aveva portato avanti con assoluta tranquillità il paradigma “meglio morire di cancro che morire di fame”: quando si rompevano i tubi nei reparti del vinile e fuoriusciva una pioggia di polvere bianca che si depositava dappertutto – tanto che tra i lavoratori era nato il modo di dire “anche oggi ha nevicato” – lui si proponeva per andare a rattoppare i condotti; non è detto che venga il cancro, diceva, sono tutte storie, casomai mi date un giorno di riposo in più, ho una famiglia da mantenere ecc. Finché un giorno il cancro se l’è trovato. Quel giorno, anziché far propria la cultura cittadina, una cultura colonizzata che ha origini molto lontane nella storia europea e italiana e che vuole che la malattia debba essere nascosta, ha deciso di andare a cercare gli ex colleghi, e bussando di casa in casa si è sentito dire che erano morti; da qui è nato il comitato.
Abbiamo poi cercato gli operai più giovani, perché a un certo punto la Montedison ha esternalizzato il settore più pericoloso, quello dell’intervento di manutenzione sulle tubature, e li abbiamo trovati facilmente perché sono lavoratori molto precari e molto arrabbiati, per la semplice ragione che hanno dei contratti giornalieri. Loro ci hanno spiegato come funziona il sistema: una piccola impresa si propone per l’appalto della manutenzione e utilizza lavoratori interinali, assumendoli a condizione che lavorino a chiamata a qualunque ora del giorno e della notte; prima di effettuare l’intervento al polo chimico, poi, devono firmare quello che si chiama “permesso di lavoro”, vale a dire un documento in cui il lavoratore dichiara di aver fatto una verifica personale e di aver riscontrato che tutto è a norma, che non c’è alcun materiale nocivo e nulla di pericoloso; se l’operaio rifiuta di firmarlo l’azienda non lo chiama più. È chiaro che lo firma.
Ai lavoratori si sono uniti nel cantiere anche un gruppo di medici ricercatori, degli ambientalisti e un giovane talento italiano studioso di problemi di statistica applicata all’epidemiologia. Con tutti loro abbiamo lavorato quasi un anno, creando un gruppo complesso e articolato di figure sociali.
Tutti insieme, abbiamo quindi esplorato diversi territori.
Il primo è stato un territorio dovuto, ossia la storia dell’insediamento dell’industria in una zona come Brindisi, che originariamente non aveva un’esperienza operaia. Tutti i lavoratori che entrano in fabbrica vengono dunque dal mondo della campagna, della pesca, della pastorizia, del piccolo e povero artigianato locale, figure che davanti a una struttura come la Montecatini sono fortemente spaesate. Abbiamo quindi ricostruito la cultura operaia degli anni ‘60-70 e ‘70-80, i cicli di lotte e il loro senso, lotte durissime ma tutte incentrate sull’aspetto economico, contro le gabbie salariali.
Abbiamo poi ricostruito i cicli lavorativi, per cercare di capire i contesti dal punto di vista della loro reale nocività e incidenza sul problema della vita, affrontando anche l’aspetto ambientale per trovare la relazione tra la sostanza tossica che fuoriesce dal processo lavorativo e la popolazione che lavora e abita nei territori vicini.
Qui occorre ricordare che il polo brindisino non è solo il petrolchimico, dove un tempo operava la Montecatini/Montedison e oggi l’Eni, con la società Versalis; ci sono anche tre centrali termoelettriche: la Federico II di Cerano, in capo all’Enel, la Edipower, di proprietà della A2A, e la EniPower, di proprietà dell’Eni. Il primo elemento strepitosamente nitido è il carbone. In tutto il mondo ormai è risaputo che il carbone è un potente biocida, una sostanza la cui polvere, i cui fumi e le cui ceneri generano effetti tragici sulla vita delle persone e sull’ambiente, e la tendenza è a chiudere le centrali a carbone, eppure a Brindisi si vive ancora questa realtà. I camini della centrale di Cerano sputano una quantità immensa di anidride carbonica e di anidride solforosa, una sostanza nota e indagata perché fonte delle malformazioni neonatali; come conseguenza, Brindisi registra una media superiore del 16% rispetto a quella europea relativamente alla nascita di bambini con malformazioni.
Lo sguardo sui fumi ci ha portato a porre attenzione anche alle polveri, che sono radioattive e quindi producono non solo effetti sulla salute, leucemie e linfomi, ma anche una terribile espansione di danni ambientali; particelle che si depositano sui terreni e sui vegetali, entrano in circolazione e vanno a inquinare profondamente le falde acquifere.
Dai fumi siamo passati al ciclo delle ceneri, e qui abbiamo dovuto fare i conti con un’ideologia perfida e perversa molto diffusa in Italia, quella di attribuire alla mafia tutti i problemi e i danni causati dallo sversamento dei rifiuti. Occorre invece ragionare, perché è una narrazione diffusa dalle grandi industrie per scagionare se stesse. Le ceneri tossiche che vengono disperse sul territorio in vario modo non sono prodotte dalla mafia o dalla ‘ndrangheta ma dall’Enel, che per legge ha il dovere di monitorare il percorso delle sue ceneri dagli stabilimenti fino ai luoghi in cui vengono rielaborate; se le ceneri finiscono in un cementificio, quindi, o sottoterra dove non dovrebbero, l’Enel ne è responsabile.
Più persone al cantiere hanno raccontato i differenti percorsi di dispersione delle ceneri, che di fatto sono molto semplici da ricostruire, perché è l’azienda stessa che negli anni ha contattato personalmente molti contadini per acquistare o prendere in affitto a pochi soldi i loro campi, già fortemente svalorizzati dalla ricaduta della polvere di carbone, per utilizzarli per lo smistamento dei rifiuti tossici. Una situazione che ha portato le amministrazioni comunali a imporre, per decreto, l’impossibilità a qualunque tipo di uso, qualunque, non solo agricolo, per aree di chilometri quadrati intorno agli stabilimenti. Eppure non ci sono processi, persone punite per via legale, responsabilità.
Anche i cementifici sono stati un ricettacolo di grandissimo interesse, perché le ceneri tossiche venivano trasformate in materiale per l’edilizia; Africo ne è una tragica conseguenza, un paese dove la popolazione muore di leucemie e tumori perché le case sono state costruite con il cemento prodotto da quelle aziende che ricevevano le ceneri dall’Enel di Cerano. Così come se muoiono i delfini intorno al mare del golfo di Otranto non è per colpa di qualche mafioso che ha scaricato i rifiuti tossici del petrolchimico, ma è colpa del petrolchimico stesso, la Montedison: uno dei lavoratori più vecchi del porto di Brindisi, che conosce tutte le dinamiche storiche di ciò che un tempo entrava e usciva dal porto, ha raccontato che partivano navi per destinazioni dichiarate ignote. Un magistrato ha provato a scoprirle e ci è riuscito: il carico di rifiuti tossici veniva seminato a metà del Mediterraneo. Ha quindi inquisito l’azienda, ma quest’ultima ha presentato una lettera del ministero dell’Ambiente che la autorizzava a scaricare in una zona considerata non più a rischio per la salute della popolazione. Legalmente, quindi, non aveva commesso alcun reato.
Abbiamo infine indagato il ciclo di controllo del lavoro, un aspetto molto importante perché se è vero che Brindisi è una città dove da cinquant’anni non succede nulla occorre tuttavia chiedersi perché i diretti interessati, cioè gli operai, siano stati zitti. Non è stato facile approfondire questa dinamica, abbiamo incontrato una legittima e comprensibile difesa da parte delle persone, anche perché la Montedison ha messo in atto il dispositivo della disseminazione delle minacce e dei privilegi. Un meccanismo che agisce in modo molto semplice: quando accade un piccolo incidente in un reparto, una valvola perde e fuoriesce una sostanza tossica, il caporeparto chiama le persone una per una e propone di “mettersi d’accordo”, offre trasferimenti in reparti meno pericolosi e piccoli aumenti in busta paga. E questo approccio è il primo livello.
Poi c’è un secondo: la prospettiva di assunzione dei figli quando si verificheranno le conseguenze sulla salute e l’inabilità al lavoro. Ed ecco che il ricatto si estende alla sfera familiare. Alcune persone del cantiere hanno raccontato di essere state contattate dall’azienda per l’assunzione a condizione che non denunciassero la morte del padre come un decesso legato al lavoro, e quindi che non si prestassero a mettere in moto azioni giudiziarie.
Poi c’è il ricatto estremo, quello dei precari della manutenzione, a cui abbiamo già accennato: la firma su un foglio, il “permesso di lavoro”, prima ancora che il lavoratore venga investito da una situazione tossica; un meccanismo che lo chiama nello stesso sistema di responsabilità dell’azienda, pena la perdita del lavoro.
Il sistema di controllo passa anche attraverso i medici di fabbrica, che attuano un filtro molto importante da un punto di vista tecnico, perché è vero che le malattie tumorali legate a sostanze tossiche si manifestano una ventina d’anni dopo, ma è indubbio che ci sono ben prima dei segnali rivelatori, e i medici interni li colgono con una certa attenzione; a quel punto l’azienda si libera degli operai, pagando loro una buonuscita. Come conseguenza, abbiamo tutta una serie di persone che solo dopo anni che non lavorano più al petrolchimico denunciano al sistema medico ospedaliero il loro stato di salute. Un sistema che Casson aveva già svelato a Porto Marghera, perché è un dispositivo che la Montedison ha seguito per decenni in tutti i suoi stabilimenti.
Esistono però anche altri dispositivi che producono il silenzio, che molto spesso non è non tacere le cose, non è una censura – se non in una maniera molto sofisticata – ma la produzione di una narrazione sostitutiva della realtà, di un’altra storia che possa polarizzare l’attenzione; una storia costruita dagli uffici di public relation delle grandi aziende, che nega fondamento scientifico a tutti i discorsi sulla nocività delle centrali elettriche e del polo chimico e racconta che i tumori, molti, che non è possibile negare, sono causati dal fatto che gli operai fumano molto, bevono molto, mangiano molti frutti di mare e quindi l’arsenico può arrivare da lì. Un’altra storia che per anni ha costruito una letteratura anche giornalistica.
C’è poi il silenzio burocratico, che passa attraverso la cancellazione delle tracce. Per molti anni la Asl di Brindisi non ha tenuto un registro dei tumori. È un atto illegale, ma non c’è alcun processo aperto contro l’Asl. Noi l’abbiamo scritto nel libro, l’abbiamo denunciato pubblicamente, molti operai l’hanno denunciato, ma tutto questo non ha prodotto assolutamente nulla, perché, dicono, bisogna vedere come mai è successo, ricostruire le carriere, sono percorsi lunghi. Il punto è che senza il registro dei tumori non sono possibili indagini epidemiologiche, necessarie anche per aprire inchieste.
Sul piano giudiziario occorrono prassi normate, che sono costruite dai processi pilota, in questo caso quello alla Montedison di Marghera, nel quale l’azienda si è servita di un legittimatore di altissimo profilo accademico, un quasi premio nobel, il dottor Richard Doll, il quale si è ben guardato dall’affermare che non esiste una relazione tra il cloruro vinile monomero e i tumori, ma ha sostenuto che questa relazione passa per un tipo particolare di tumore, l’angiosarcoma epatico: se c’è questo tumore la probabilità che vi sia una relazione è molto alta, se c’è un altro tipo di tumore la probabilità è bassa. Un paradigma mono-causale che la magistratura ha fatto proprio fino alla Cassazione, la quale ha stabilito che solo nel caso in cui vi siano angiosarcoma epatici rilevabili da un’indagine epidemiologica ben precisa e normata in un certo modo – che a Brindisi non si può fare perché non ci sono i registri dei tumori! – si può procede per via legale ad accusare l’azienda. La magistratura deve avere la certezza del nesso di causa e non la sola probabilità, e di fatto già l’idea che l’angiosarcoma epatico riveli una relazione con il cloruro ‘altamente probabile’ e non ‘pienamente certa’ è una situazione dubbia sul piano legale; se poi addirittura il tipo di tumore è un altro la relazione diventa ancora più insostenibile, diventa una illazione, che può dar luogo a un processo contro chi la fa: contro di me, per esempio, che firmo il libro, perché potrei diffondere il panico tra la popolazione e notizie allarmanti.
E se esiste un parola d’ordine che tesse la cultura della burocrazia è proprio “non creare allarme”, come abbiamo purtroppo imparato con la vicenda dell’Icmesa di Seveso, quando la popolazione venne informata della tossicità della diossina solamente una settimana dopo il disastro, e per tutto il tempo del fallout non furono messe in atto misure di sicurezza per le persone.
In conclusione, dall’esperienza di questo cantiere possiamo individuare quattro territori di tipo generale su cui riflettere.
Innanzitutto la sottostima del problema della salute, che in questo Paese, per storia politica e culturale del movimento sindacale, è sempre stato visto come qualcosa che si presenta nel momento in cui la persona si ammala; è un’idea completamente sbagliata, perché la grande maggioranza dei problemi della salute nascono e sono da affrontare molto prima rispetto al momento in cui la malattia si presenta, soprattutto quando ci riferiamo al mondo del lavoro, dove si pone una questione di fondo che non è solo etica e politica ma di cultura generale: perché qualcuno deve lavorare se la sua salute non è totalmente garantita a priori? Nel lavoro mettiamo in gioco talenti, capacità, abilità e forza lavoro, ossia tempo; mettiamo in gioco gli ingredienti necessari per un certo tipo di lavoro, non la nostra vita, quindi perché dobbiamo invece rischiarla? La risposta è ovvia: perché viviamo in un sistema capitalistico, nel quale la vita delle persone non ha alcuna importanza. Però questa è una risposta ideologica, mentre a me interessa una risposta di cultura popolare, personale: perché io, personalmente, quando mi offro sul mondo del lavoro non pongo anzitutto la questione che non sto mettendo in gioco la mia vita ma una quantità di ore del mio lavoro, e quindi voglio che la mia salute sia garantita mentre svolgo quel lavoro per qualcun altro? Accade perché abbiamo una sottovalutazione generalizzata del problema.
In seconda battuta, poniamo attenzione al modo in cui ci viene presentata la questione della salute, perché esiste un dispositivo, ormai entrato nella cultura del Paese, che rovescia la percezione sociale del problema: la personalizzazione della malattia. Chi ha il tumore? Giovanni. Chi ha il linfoma? Anna. È falso. Giovanni è stato colpito da quella organizzazione del lavoro e dunque è l’esito di quel lavoro. Non devo curare Giovanni ma l’organizzazione del lavoro, perché ciò che è patologico è anzitutto quell’organizzazione del lavoro che genera quella conseguenza.
Come terza questione, introduco un tema che ha posto Norbert Elias riflettendo sulla morte e sulla malattia nei campi di concentramento. È un tema importante, perché su queste morti nell’ambito del lavoro ci sono responsabilità non generiche: quando esiste una catena di comando dentro un’azienda che prevede dei controlli sanitari ben precisi, è chiaro che in quella catena di comando, dai vertici fino al medico di reparto, ci sono persone che sanno perfettamente quello che sta accadendo. Elias si è posto questo problema: che cultura hanno queste persone? Come fanno ad andare a dormire tranquille? C’è un problema di fondo che riguarda questa cultura, un problema impalpabile, perché quando entriamo nell’ambito della burocrazia troviamo una immensa serie di persone che si deresponsabilizza e che è deresponsabilizzata dal dispositivo, con meccanismi piuttosto semplici: sono solo un passacarte, ho avuto un’informazione ma se dico qualcosa mi licenziano, cosa c’entro io sarà qualcun altro… e si finisce per non capire più chi è responsabile di qualcosa. Allora viene fuori il mafioso, che è la figura che lucra su un infame dispositivo di tipo culturale, ma questo è un problema della magistratura; quello su cui invece dobbiamo interrogarci noi è la cultura di questa catena di comando.
Infine, pongo l’attenzione su quanto sia importante rompere il silenzio, perché il silenzio ci coinvolge e ci responsabilizza: non dire ciò che si sa di quello che avviene all’interno dei propri mondi del lavoro significa diventare corresponsabili di questa cultura e di questa catena di comando. La necessità di rompere il silenzio passa attraverso la convinzione che ciascuno di noi possa rinnovare profondamente la vita sociale, perché ogni persona ha una intrinseca potenza, deve solo fare i conti con le culture che colonizzano il suo sguardo e da qui decidere di entrare in relazione con gli altri. Rompere il silenzio vuol dire aprire una interlocuzione sociale, raccontare, e tutti siamo capaci di farlo. Prendere la parola sui posti di lavoro, nei quartieri in cui viviamo, e insieme costruire dei processi che chiedano di rendere conto del loro operato e dei loro silenzi alle varie figure di responsabilità. Dobbiamo farlo noi, perché non possiamo aspettarci che qualcun altro lo faccia.