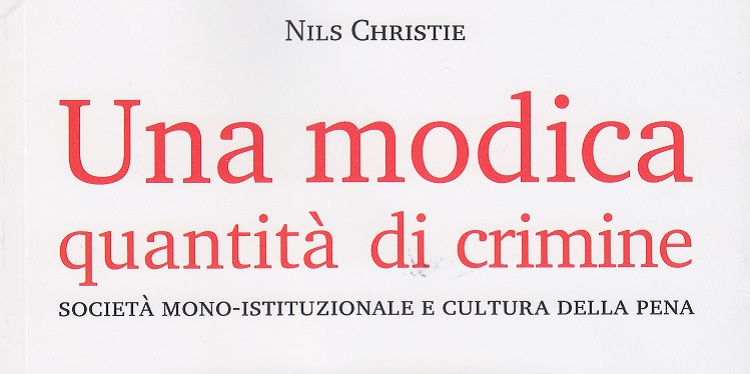Nils Christie, Giuliano Spazzali e Tommaso Spazzali
Incontro dibattito a margine del libro Una modica quantità di crimine. Società mono-istituzionale e cultura della pena di Nils Christie (Edizioni Colibrì, 2012)
Tommaso Spazzali. L’archivio Primo Moroni ospita dal 2004 una sezione dedicata all’abolizionismo carcerario ed è in questo contesto che si forma l’intenzione di tradurre e pubblicare in edizione italiana il libro di Nils Christie A suitable amount of crime, tradotto con Una modica quantità di crimine.
L’Italia è un Paese in cui le condizioni e le modalità di applicazione delle pene inflitte dal diritto hanno da tempo superato il limite del tollerabile. Vi è il sovraffollamento, tema noto. L’associazione Antigone riporta la presenza di quasi 66.500 persone detenute all’interno delle carceri, alla fine del 2012, con una capienza di 45.500: quasi 150 persone in uno spazio destinato a 100, spesso in condizioni fatiscenti e degradanti per la dignità umana. Ma se questo avviene in deroga ai dettami della normativa, altre cause di malessere stanno proprio nelle stesse prescrizioni del diritto. L’introduzione del reato di clandestinità (legge Bossi-Fini) e la penalizzazione del consumo di stupefacenti (legge Fini-Giovanardi) aumentano la tensione sociale e riempiono le prigioni di uomini e donne la cui unica colpa è quella di aver cercato di sopravvivere in un mondo che non gli si è mostrato ospitale.
Ma ancora peggio la legislazione premiale introduce pericolosi livelli di arbitrarietà del diritto e discrezionalità della pena, e fa merce di scambio di valori, sentimenti, identità, per arrivare all’incredibile formula dell’ergastolo ostativo per cui per alcune fattispecie di reato (mafia e terrorismo) non si ha diritto ai benefici di legge se non si collabora con la giustizia, ossia se non si manda in prigione qualcuno al proprio posto. L’Italia è il Paese dove l’ergastolo prevede un fine pena al giorno 99 del mese 99 dell’anno 9999. Carmelo Musumeci, ergastolano ostativo molto impegnato nella battaglia contro l’ergastolo, scrive a Nils, nel giugno 2012:
“Lettera aperta al criminologo con l’amore sociale nel cuore.
“Gentile Professor Nils Christie, non sono sicuro se riuscirò a farle avere questa lettera, se riuscirò a tradurla in inglese e non so neppure se lei mi risponderà, ma ci provo lo stesso perché mi piacciono le imprese impossibili. Innanzitutto mi presento: sono un ‘uomo ombra’, così si chiamano fra di loro in Italia gli ergastolani ostativi a qualsiasi beneficio penitenziario, detenuto nel carcere di Spoleto. Sono un ‘cattivo e colpevole per sempre’ destinato a morire in carcere se al mio posto in cella non ci metto qualcun altro, perché sono condannato alla Pena di Morte Viva, infatti in Italia una legge prevede che se non parli e non fai condannare qualcun altro al tuo posto, la tua pena non finirà mai e si esclude completamente ogni speranza di reinserimento sociale. Questa condanna è peggiore, più dolorosa e più lunga, della pena di morte, perché è una pena di morte al rallentatore, che ti ammazza lasciandoti vivo.
“Professor Nils Christie, un amico sconosciuto (le amicizie con gli sconosciuti sono le più belle) mi ha inviato e donato il suo saggio. L’ho letto in un solo giorno e condivido molto i suoi pensieri e tutto quello che ha scritto. Anch’io penso che la mafia e la criminalità organizzata come tutti i poteri nascono dall’alto e non dal popolo e dai poveracci, ma piuttosto dai potenti e dai ricchi. Poi quando lo Stato-Mafia è in difficoltà manda in catene le persone che ha usato per raggiungere e mantenere il potere. Spesso in Italia sono propri i mafiosi che urlano di lottare contro la mafia per fare sapere che non sono mafiosi. Lo so, non ho prove per dimostrare queste affermazioni, ma io non sono un giudice (e neppure un criminologo) e non ho bisogno di prove perché non devo condannare nessuno, tento solo di pensarla diversamente da come lo Stato-Mafia vuole farmi pensare. Non so cosa accade negli altri Paesi, ma il carcere in Italia non ti vuole solo togliere la libertà, ma ti vuole anche possedere. Credo che sia impossibile ‘rieducare’ una persona che ha commesso un crimine se questo non si sente amato e perdonato dalla società.
“Professor Nils Christie, a questo punto lei si domanderà perché le sto scrivendo.
“Ebbene, sono tanti anni che lotto contro i mulini a vento, quasi da solo, per l’abolizione dell’ergastolo ostativo in Italia. Dal suo libro mi sono fatto un’idea della sua coscienza sociale e penso che lei non sia d’accordo che una persona possa essere cattiva e colpevole per sempre e murarla viva fino all’ultimo dei suoi giorni, senza neppure la compassione di ucciderla. Per questo ho pensato di scriverle per chiederle di aiutarmi a fare conoscere all’estero la Pena di Morte Viva che esiste in Italia, unico Paese al mondo che se parli esci e se no stai dentro, come nel Medioevo”.

Il risultato più drammatico, immediato e tangibile di questa situazione è il numero delle morti in carcere. Ristretti Orizzonti riporta il dato di circa 60 suicidi all’anno, su 150-200 decessi totali. Il motivo, però, che ci ha spinti a tradurre e a pubblicare il libro di Nils, è un altro. Non riguarda l’esistenza di storture nell’applicazione delle pene o nella formulazione delle regole del diritto. Il tema che attraversa le pagine del libro e degli scritti di Christie è quello della necessità di rimettere in discussione l’intero approccio. Il sistema penale si pone come argomento astratto, predeterminato e uguale per tutti (imparziale) avente lo scopo di dominare il conflitto. Al contrario, le società sono fatte di uomini e donne concreti, che cambiano nel tempo, per nulla eguali e che manifestano nei loro gesti e nelle loro relazioni il loro esistere. Talvolta contesti, gesti e relazioni scoprono situazioni di disequilibrio che sfociano in piccoli o grandi conflitti. Il disequilibrio è il motore della vita, e questo vale per la materia naturale quanto per quella sociale, e voler cancellare i suoi segnali ingabbiandolo in un sistema chiuso di regole nega a tutti una incredibile forma di conoscenza, crescita e trasformazione e ci intrappola in una soluzione compressa da cui le storture descritte prima sono un esito quasi inevitabile. Al contrario, le società necessitano di più spazio per il conflitto.
Scrive Nils in un articolo del 1977: “Le società altamente industrializzate non hanno troppi conflitti interni, ne hanno troppo pochi. Noi dobbiamo organizzare dei sistemi sociali in modo che i conflitti siano al tempo stesso alimentati e resi visibili, preoccupandoci anche del fatto che non siano dei professionisti a monopolizzarne la gestione”. Nelle società in cui prevale l’istituzione mercantile (le società mono-istituzionali) si riducono le occasioni di contatto diretto, di scambio su basi di valori diversi da quelli monetari; la relazione si fa astratta e astratta prevale la norma. In questo contesto la coppia diritto-pena è trasformata in una triade crimine-diritto-pena, dove il crimine è, possiamo dire, la rappresentazione narrativa che sostiene l’impianto.
Beninteso, Christie non si nasconde che accadano delle cose spiacevoli, non nega che vi siano delle cose che non vanno bene, anzi, paradossalmente, dice, è il bollarle come ‘crimine’, dargli una rappresentazione in bianco/nero, giusto/sbagliato, che fa sembrare che sia tutto a posto, sotto controllo, e che nasconde la vera essenza del conflitto. Non si tratta quindi di correggere dette temporanee storture ma di rivedere nel suo complesso la gestione del disequilibrio e la comprensione degli accadimenti non desiderati. In questo senso la tesi (e con essa le parole del testo) esce dagli argini stretti del dibattito criminologico e affronta aspetti più disparati dell’esistenza delle persone (la salute, fisica e mentale, la scuola, il lavoro, il denaro…). In questo senso una soluzione alternativa alla società criminologica deve e può essere trovata fuori. Esempi positivi se ne contano, nascosti nelle pieghe della storia, e considerarli ci aiuta a trovare e sperimentare una strada migliore.
Nils Christie. Questo dibattito vuole ragionare sulle possibili alternative al sistema penale. Ne esistono? Sì, e la risposta è molto semplice: si tratta innanzitutto di imprigionare meno, di dare meno sofferenza. Credo sia molto importante porre attenzione alle parole che usiamo quando parliamo di ‘crimine’, di ‘controllo del crimine’ e di ‘alternative alla punizione’, e dobbiamo riflettere su che cosa abbiamo in mente quando diciamo ‘sistema penale’, quale sia la sua essenza: il sistema penale è un sistema strutturato per infliggere pena, un sistema la cui principale attività è quella di fare in modo, intenzionalmente, che delle persona soffrano. In Germania la terminologia è più chiara, non si parla infatti di ‘legge penale’ ma di ‘legge punitiva’ – anche se personalmente non trovo corretta nemmeno questa definizione, perché nell’attuale sistema le leggi non regolano una ‘punizione’ ma infliggono, appunto, una ‘pena’, ossia una sofferenza.
Penso che dobbiamo essere onesti sulla terminologia che usiamo, perché rappresenta il punto di partenza con cui analizzare e valutare il valore di un Paese. L’Italia, per esempio, è un Paese molto bello, sotto diversi punti di vista, ma le sue istituzioni detentive infliggono molta pena. Se le confronto con le carceri scandinave, la differenza è evidente. In Scandinavia non abbiamo prigionieri ma ‘ospiti’, non abbiamo guardie ma ‘inservienti’, non abbiamo celle ma ‘stanze’. Eppure, non è tutto roseo come appare. Sono stato in una piccola isola nel fiordo di Oslo, un posto bellissimo, un paradiso da vacanze estive, dove è situato un istituto penitenziario; ci sono una piccola fattoria, diverse case, e nessuna chiave. Ho fatto una passeggiata per il luogo, alcune persone lavoravano, altre riposavano al sole; ho osservato un uomo che stava riposando, era un uomo che aveva ucciso molte persone. Dopo la passeggiata ho tenuto una sorta di lezione al personale amministrativo e ai detenuti della prigione, durante la quale ho descritto la bellezza del posto e ho detto che molte persone avrebbero voluto soggiornarci per le vacanze estive; a quel punto ho chiesto ai prigionieri: se aveste la possibilità di stare qui quattro settimane extra, in un piccolo cottage da soli, magari anche con la vostra famiglia, in questo paradiso estivo, cosa fareste? Tutti i prigionieri hanno iniziato a bisbigliare rumorosamente, e prima ancora che finissi di parlare si è alzata una voce forte che ha risposto: “Mai e poi mai un giorno in più qui!”.
Questo aneddoto mostra quale sia il cuore di ciò che intendiamo per ‘pena’, ed è il degrado. Anche se le prigioni sono aperte e situate in luoghi piacevoli, esse rimangono prigioni; non si può sfuggire a questo, anche se ciò non toglie che si debba cercare di rendere gli istituti penitenziari dei luoghi più confortevoli. Ragionare sulle alternative al sistema penale significa anche chiedersi che cos’è il ‘crimine’ e quali persone finiscono in prigione. Innanzitutto il crimine non esiste, esistono gli atti, cui spesso vengono attribuiti diversi significati all’interno di differenti strutture sociali. Il crimine è dunque il prodotto di un processo culturale, sociale e mentale. Questo significa che la dimensione della popolazione carceraria in ogni società è il risultato della storia nazionale passata, delle idee politiche correnti e anche, in misura non secondaria, della buona volontà di trovare soluzioni diverse da quelle penali.
In seconda battuta, la società di oggi è mono-istituzionale, nel senso che l’unica ‘istituzione’ riconosciuta è la razionalità economica, e i suoi ‘ideali’ hanno invaso le istituzioni circostanti; viviamo in nazioni di produttori e consumatori, e in queste società un gran numero di abitanti si trova nella condizione di perdere la piena partecipazione a quelle attività che sono considerate le uniche importanti: le attività di produzione e consumo. Dal punto di vista della razionalità economica, non c’è un gran bisogno di manodopera nelle società altamente industrializzate: quello che molti fanno bene, le macchine o i lavoratori che provengono dai Paesi meno industrializzati possono anche farlo meglio. Essere in ‘esubero’ è dunque il destino di un numero notevole di persone – tra i giovani, gli anziani, gli ammalati, i meno qualificati, chi ha il colore della pelle sbagliato o la cultura sbagliata. Per un gran numero di costoro il lavoro retribuito è veramente un sogno lontano. E dunque la reclusione è il modo, per alcuni Paesi, di affrontare il problema della povertà.
Se guardiamo i dati, il primo grande incarceratore mondiale sono gli Stati Uniti, che hanno oggi 2,2 milioni di persone in carcere e altre 4,7 milioni soggette a misure restrittive come la condizionale o la sospensione della pena o la libertà su cauzione; negli Usa ci sono quindi quasi 7 milioni di persone sotto il controllo del sistema penale. E chi sono queste persone? La maggior parte sono neri o latinoamericani. Al secondo posto di questa particolare classifica abbiamo la Russia, con 592 detenuti ogni 100 mila abitanti – contro i 748 su 100 mila degli Usa – poi seguono Cile (313 su 100 mila), Brasile (253 su 100 mila), Messico (204 su 100 mila), i Paesi dell’est Europa come Ucraina (330 su 100 mila) e Lettonia (314 su 100 mila); abbiamo poi una fascia intermedia, rappresentata da Spagna (163 su 100 mila), Inghilterra (155 su 100 mila), Italia (112 su 100 mila); infine abbiamo il livello più basso, i Paesi con meno detenuti: Germania (88 su 100 mila), Norvegia (71 su 100 mila), Finlandia (60 su 100 mila). Perché queste differenze?
Per dare una risposta è interessante rilevare la diversità tra Stati Uniti e Canada: quest’ultimo ha 117 prigionieri ogni 100 mila abitanti, contro i 748 degli Usa. Due Paesi così vicini eppure così diversi, un confine unico da costa a costa, la stessa lingua, quasi la stessa religione, in una certa misura quasi gli stessi contenuti mediatici e anche molti degli stessi ideali, quando si tratta del denaro e dello stile di vita. Come possiamo quindi spiegare queste differenze nel volume carcerario? Non esiste certo una risposta univoca, ma sicuramente a uno che viene dal nord Europa come me il Canada ricorda la Scandinavia: un po’ noioso, forse, un Paese ben regolato, un comportamento ordinato, relazioni educate e, soprattutto, un sistema di welfare. Il Canada ha tutto: pensioni di vecchiaia, assistenza sanitaria, permesso per maternità, sussidio di disoccupazione; il Canada ha insomma un forte stato sociale, come i Paesi scandinavi, che nella classifica degli incarceratori si trovano al livello più basso. Questo fa sì che la condizione dei poveri è fondamentalmente diversa tra il Canada e gli Stati Uniti.
In Italia poi c’è una peculiarità: la quantità di detenuti in attesa di giudizio. Sono dati scioccanti, il 38,7% dei detenuti non è stato giudicato. È opinione comune, nelle ricerche sulla prigione, che essere incarcerati senza essere giudicati produce una sofferenza aggiuntiva. Esiste poi un altro aspetto da tenere in considerazione: la distanza tra le persone. Più si è vicini a una persona meno si è portati a infliggerle una sofferenza, perché la si vede non attraverso gli stereotipi della figura del ‘criminale’ ma come un essere umano. Quando ero ancora uno studente universitario, ho avuto modo di seguire una vicenda terribile. Quando, verso la fine della seconda guerra mondiale, la Norvegia scoprì quello che accadeva nei campi di concentramento in Germania, rimase scioccata; ci pareva incredibile perché consideravamo la Germania la culla della nostra cultura. Ma c’era qualcosa di ancora più terribile da affrontare: si scoprì che anche in Norvegia c’erano stati campi di concentramento per serbi, croati e jugoslavi in genere, le cui guardie erano norvegesi. Fui coinvolto dal mio professore nell’analisi di questa vicenda giudiziaria, con l’intento di comprenderla. Proposi allora di andare a chiedere direttamente a loro, alle guardie, com’era stato possibile che questo accadesse.
Ne ho così incontrate diverse, alcune già giudicate altre in attesa di processo, alcune che avevano ucciso altre che non lo avevano fatto. A nessuna chiesi: perché hai ucciso?, ma domandai: chi erano i prigionieri jugoslavi?, descrivetemeli. Coloro che avevano ucciso mi risposero che non erano mai entrati in contatto con i prigionieri, per loro erano solo pericolosi animali dei Balcani; coloro che non avevano ucciso mi raccontarono invece molte storie sugli jugoslavi, mi dissero che gli avevano mostrato le fotografie di Belgrado, che cantavano la sera e che avevano spesso parlato con loro. Ho poi conosciuto uno dei prigionieri, che mi disse che fu una sola frase a salvargli la vita. Mi raccontò che appena sbarcato dalla nave trovò un dizionario tedesco-norvegese; era un maestro di scuola e conosceva il tedesco e così imparò l’essenziale della lingua norvegese; poi, un giorno, stavano uscendo dal campo in riga, erano 5-6 prigionieri e le guardie, davanti e dietro, e la guardia norvegese che era in coda domandò a quella in testa: “Hai un fiammifero?” La guardia in testa rispose di no, e a quel punto il prigioniero serbo disse, in norvegese: “Io ho un fiammifero”. È una storia che non ho mai dimenticato, e un insegnamento che mi sono portato dietro per tutta la vita: bisogna avvicinare le persone fino a vederle come esseri umani. Perché questo ha salvato la vita al prigioniero jugoslavo, con quella frase lui è apparso alle guardie non più come un animale dei Balcani ma come un essere umano che parlava il loro linguaggio, il norvegese, e non furono più in grado di ucciderlo.
In conclusione, per riprendere il titolo di questo incontro, la migliore alternativa al sistema penale è una società egualitaria, perché la maggior parte dei prigionieri di tutti i Paesi, indipendentemente dal sistema politico, sono poveri e miserabili, e dunque per far sì che il sistema penale sia adeguato, ridotto al minimo, occorre eliminare le diseguaglianze sociali. Insieme a questo, un’alternativa per risolvere i conflitti, applicata nel mio Paese, è un sistema che permette alle ‘vittime’ di incontrare i ‘colpevoli’ e parlarsi tra loro, e il punto è che quando si incontra qualcuno che ha fatto qualcosa di terribile, non si inizia chiedendo: perché l’hai fatto?, ma: che cosa è accaduto? Solo se una persona racconta la propria storia è possibile capire perché una cosa è accaduta, ed è assolutamente necessario capirlo per comprendere il fenomeno; e se c’è comprensione, da parte della vittima, di quel che è accaduto, la pena può risultare addirittura non più necessaria. Occorre dunque creare un sistema che permetta alle persone di incontrarsi e capire, perché il punto principale è capire i conflitti, non punirli.
Giuliano Spazzali. Devo innanzitutto premettere che io ho fatto per 46 anni un mestiere molto criticato nel libro di Christie, cioè l’avvocato. Critiche che accetto con una precisazione: ho fatto piuttosto il mestiere di difensore, che è un’altra cosa che fare semplicemente l’avvocato. Dopo aver lottato contro ogni forma di pena detentiva (e non solo per i miei assistiti) e dopo aver perso spesso le mie battaglie (qualche volta le ho vinte), ho continuato a mantenere la posizione di massima contrarietà alla pena detentiva proprio adesso che ho l’autorizzazione a visitare all’interno un carcere importante, quello di San Vittore a Milano. Tutti i carceri in Italia non sono belli, forse è bello quello di Oslo. Qui le galere sono decisamente orrende, anche se insediate in edifici storici, come quello appunto di Milano che risale al tempo dell’Unità d’Italia e che ha l’apparente struttura di un panottico, come lo avrebbe voluto Bentham. Quando andavo a un colloquio con mio difeso, superavo un solo cancello e subito ero nelle stanzette destinate a questo scopo. Ora, per entrare nei reparti, devo passare altri sette cancelli, e già questa è un’esperienza forte, sconvolgente.
Il libro del professor Christie mi ha particolarmente interessato e anche sorpreso. I limiti del mio intervento è che io non sono un sociologo, non sono un criminologo, non sono uno psichiatra e tanto meno uno psicoanalista. Molti aspetti degli scritti di Christie seguono invece un tracciato complesso che tiene conto della criminologia e anche della psicoanalisi e perciò bisognerebbe tenere in debito conto ogni parte di questo audace percorso. E poi: all’evidenza non sono un legislatore, ma quel che è certo è che credo di poter affermare di aver sempre visto, e dunque guardato, i soggetti che ho difeso e che ho interrogato, non dal punto di vista del delitto del quale venivano accusati ma delle loro storie personali e del sistema collettivo che le conteneva. Questo per affermare che la nostra procedura penale è cosa assai diversa del diritto penale sostanziale e che è più orizzontale di quanto sembri o, per lo meno, la si può rendere per così dire più orizzontale, quando, difendendo, veramente lo si voglia. Nel libro di Christie c’è un’attenzione particolare alla differenza tra una giustizia ‘orizzontale’ e una ‘verticale’. Si suppone e si dice che quella verticale ora sia quella del diritto, ora della legge, ora delle norme penali specifiche. La prima osservazione che mi viene da fare, pur tenendo conto delle importanti differenze segnalate da Christie, è che non bisogna mai confondere i termini ‘diritto’, ‘legge’, ‘norma’.
Il diritto è storia, è filosofia, è persino letteratura. La legislazione è il massimo della astrazione del sistema dei divieti. La norma è un ‘dire’ specifico diretto a un soggetto concreto specifico: è la forma legale unica con la quale viene definita una specifica responsabilità e quella sola, una alla volta e in ogni singolo processo, anch’esso uno alla volta. In questo non c’è nulla di astratto, nulla di ripetibile, nulla di preesistente. Se non si lavora entro questo orizzonte logico/pratico, si può essere avvocato ma non si può fare il difensore. E si può fare il difensore (questa essendo la sua unica e vera funzione quando, dopo il normale cursus honorum, è stato nominato avvocato) solo se, pur conoscendo tutto che ciò che c’è da conoscere intorno al diritto e alla legge, si è però in grado di rendere elasticamente orizzontale la procedura. In poche parole: è esistente (c’è) solo il divieto che è anche applicabile per la prima e unica volta. Muovendosi in questo modo si può istituire un rapporto fecondo tra difensore e difeso, perché questo è anche l’unico modo che il difeso ha di concepire la storia processuale facendola sua.
Va detto qualcosa a proposito della quantità dei divieti penali: il nostro codice di diritto sostanziale contiene circa 700 reati che sono già molti, ma molti di più sono i ‘non puoi’ i ‘non si fa’ delle legislazioni speciali. Per esempio, e al volo, quella sull’immigrazione, quella sul riciclaggio, quella sulla criminalità informatica, quella sulla violenza sessuale, quella sullo sfruttamento della prostituzione, quella sull’evasione fiscale, quella sul contrabbando dei tabacchi, quella sul terrorismo internazionale, quella sugli incidenti sul lavoro e sul lavoro in nero, quella sul maltrattamento degli animali, quella sulla pedopornografia, quella sulla mutilazione dell’organo genitale femminile, quella del codice della strada, e tutto questo è ancora niente. E perché succede tutto questo? Ogni anno vengono emanati circa 3.000 (tremila!) leggi. Ciascuna di queste contiene almeno un divieto penale. Se si sommano tutti questi divieti-reati si capisce perché si stia imponendo un principio in contrasto con la secolare tradizione secondo la quale “l’ignoranza della legge non scusa”. Ora spesso scusa, eccome, dato che sempre più frequentemente ci sono divieti che nemmeno i magistrati dell’accusa o quelli giudicanti conoscono e tanto meno gli avvocati.
Questi sono problemi in qualche modo risolvibili, altri sono molto più difficili da risolvere e sono quelli dei quali il professor Christie si fa carico e che segnala proponendoli alla discussione. In sintesi, si tratta di un punto di vista che credo di aver praticato intuitivamente senza troppo rifletterci sopra, ma che ora riconsidero e ripenso logicamente. Il punto di vista è di fatto una risposta a un quesito normalmente occultato che bisogna invece rendere esplicito. Il sistema giudiziario (più precisamente il ‘procedimento penale’) entra nel conflitto sociale senza sopprimere la vendetta? Se non vi rinuncia, se non la sopprime, allora cosa fa, entro la catena (o le catene) dei conflitti? Perché e come interviene negandosi come ‘giustiziere’ ma assumendosi come promotore di giustizia?
Secondo la mia opinione il sistema penal/processuale italiano ha la pretesa di sommare e produrre in contemporanea sia il principio di giustizia che il principio di vendetta dove la ‘giusta vendetta’ consiste in una reciprocità (violenta) di retribuzione. Poiché è ben chiaro il divieto di farsi giustizia da soli, ad agire in risposta allo ‘sgradevole’ comportamento sociale dell’autore non è la vittima in proprio o il suo clan di riferimento, ma è un soggetto terzo e terzo è appunto il giudice non coinvolto nel conflitto, anzi che è a esso del tutto estraneo. Non essere coinvolti ma ugualmente intervenire, è preciso e concreto sintomo di una mediazione che non sopprime la vendetta ma la disloca su un piano concentrato in un’unica rappresaglia, chiudendo con ciò il circuito senza fine delle vendette permanenti. Dunque la modulazione di questa rappresaglia ha tre aspetti: evita la riproduzione a catena di infinite vendette; deve anche essere consonante con le sensibilità individuali e collettive; infine, è anche depurata dall’arbitrio punitivo eccessivamente violento.
Ma se questo è immaginato teoricamente, le conseguenze di una pratica deformante e deformata sono spesso molto diverse, sicché il cattivo uso di questi strumenti originari di interpretazione e realizzazione vanifica le aspettative sistemiche pure affermanti come assolutamente necessarie in difesa di una pretesa pace sociale. Qui si vede bene che ho chiama ‘sensibilità individuali e collettive’ tutto ciò che dipende da fattori culturali e politici mutevoli e sempre insidiati da vocazioni autoritarie o anche disgregative. E altrettanto debba dirsi della ‘pace sociale’, che spesso viene sostituita dalla sottomissione collettiva imposta dai più forti sui più deboli, pur mantenendo lo stesso nome di facciata.
Ma la questione più ardua e subito attuale da esaminare è proprio quella della ‘rappresaglia-retribuzione’ che viene individuata nella pena detentiva (con diversi livelli di gravità) e che dovrebbe essere rappresentata, da noi, da una ‘pena costituzionale’. Comminata e vissuta come utile, flessibile, funzionale alla risocializzazione di chi viene condannato. Questa ri-socializzazione è un fattore assai discutibile perché dipende da fattori soggettivi molto diversi a partire dal più immediato e semplice: condannato sì, ma per essere restituito tale quale al proprio sistema di vita abituale, alle proprie relazioni sociali, non a una dimensione altra. Il che dice chiaramente come il problema abbia subito due facce, per così dire, rieducative: quella del condannato escluso dal contesto sociale e però anche quello del contesto sociale che dovrebbe ri-accoglierlo.
Allo stato delle cose si afferma che la pena deve essere almeno differenziata in ragione della soggettività di chi è stato condannato (elaborazione del suo senso di colpa?): così prevede il nostro ordinamento. Ma così non è: la pena è il carcere di San Vittore, la pena è qui dentro. Se fosse mai possibile mi piacerebbe accompagnare il professor Christie al terzo o al settimo raggio o a quello dei giovani adulti o a quello dei detenuti ‘protetti’, e così potrebbe vedere in cosa consiste la pena-retribuzione in nulla assimilabile alla personalizzazione soggettiva in vista di un qualche ragionevole scopo, pena priva di duttilità, di elasticità e anche di umanità. La nostra pratica punitiva fa a botte con qualsiasi ragionamento logico sociale o con qualsiasi previsione costituzionale. La pena detentiva è una sconfitta definitiva della mediazione penal/processuale. Si tratta di un nodo drammaticamente difficile da sciogliere.
Faccio un passo indietro e seguo il ragionamento di Nils Christie, quello sulla giustizia orizzontale rappresentato da una figura simbolica: le donne alla fontana che, in un villaggio qualsiasi, lavano i panni e intanto parlano, discutono, ragionano sugli avvenimenti e sui fatti collettivi. Gli uomini magari si trovano da qualche altra parte e anche loro mettono in luce fatti sgradevoli occorsi dentro la loro comunità, dentro la loro vita associata. Cosa c’è di utile in questo fitto parlare delle donne e degli uomini? Di utile c’è che ci sono punti di aggregazione, di incontro, nei quali innanzitutto vengono descritti gli eventi che hanno dato origine ai conflitti. Cosa è veramente successo e come mai è successo? Non si tratta tanto di qualificare come ‘crimine’ quella ‘cosa’, ma si tratta certamente di un alcunché di sgradevole, inopportuno, incoerente con ciò che è la vita comunitaria, con la giusta necessità di vivere in comune. Descrivere a fondo gli eventi è un fatto importante perché in questo modo si mette a fuoco un comune sentire su ciò che è ‘giusto’ e ciò che è ‘sbagliato’. E anche, osservo io, si mette a fuoco chi ha tenuto un comportamento giusto e chi quello sbagliato, poiché non esistono eventi separabili dai loro autori e spesso gli autori sono perfettamente identificati e nominati da questi eventi che, appunto, modificano la loro identità.
Senza necessità di parlare di delitti, di condanne e di pene, queste intense conversazioni producono un sistema di compensazioni sociali che leniscono la dannosità degli eventi sgradevoli e anche un sistema di norme per interazione. Ecco che le donne alla fontana realizzano i piani di una sensibilità soggettiva e collettiva, promuovono norme di comportamento che distinguono lo sbagliato dal giusto, compensano il danno e in qualche modo rieducano il danneggiatore. Escluso che, nella società metropolitana nella quale viviamo, esistano fontane ove si raccolgono donne a lavare i panni e a fare il punto sulla situazione e dunque qui si possano avverare tutte le interessanti cose appena descritte, resta aperta la questione centrale: la inconferenza della bulimia dei precetti penali, la innaturalezza dei relativi processi e, specialmente, la inutilità della pena detentiva.
Ciò che è pertinente nel ragionamento del professor Christie, al di là del racconto simbolico, è che non esista legge astratta ma solo norma specifica da misurare sul soggetto sotto esame (da parte di un aggregato sociale condiviso dal soggetto, o da un ente specializzato non condiviso se non per la storia comune che ha unificato gli aggregati) quasi fosse, appunto, di sua esclusiva pertinenza. Questa parte centrale dell’insegnamento di Nils Christie la condivido del tutto, cosi come quella molto più problematica della pena, cioè del contrappasso.
Comunque, se anche nella nostra attuale condizione di vita ci sono gruppi di condivisione e di aggregazione (da quelli familiari a quelli di partito o di movimento o di giocatori di scopone al bar), per il resto, che è un resto maggioritario, noi tutti viviamo dentro una società complessivamente frantumata e sgrammaticata: non ci vediamo, non ci conosciamo, non ci incontriamo, non formiamo nuclei stabili e perciò non siamo in grado, come le donne alla fontana, di selezionare ciò che è davvero rilevante al fine di descrivere l’evento sgradevole purgandolo da tutti gli elementi irrilevanti.
In ogni narrazione (anche in quella propriamente processuale) di singoli episodi e delle circostanze soggettive di ciascuno, la selezione che viene effettuata degli elementi rilevanti è decisiva specie quando, nel nostro sistema ordinario, la figura del reato è descritta in modo essenziale ed è dotata di pochi elementi circostanziali. Le attenuanti, le aggravanti, la preterintenzione, la capacità di intendere e di volere, per esempio, così come i fraintendimenti, la provocazione, la tenuità del danno, il caso fortuito, il concorso eventuale indiretto, e altro ancora, tutto questo apre spiragli, non sempre modesti, in direzione di sguardi più penetranti verso l’imputato, ma al fondo si mantiene sempre la consueta rigidità definitoria degli elementi essenziali e rilevanti.
Al contrario le donne alla fontana sembrano togliere ogni rigidità formale al loro sguardo quando prendono in considerazione i ‘moventi’ ( il movente è parola chiave nel libro di Christie) e anche la provocazione o meglio la sola ombra della provocazione. Ma, quel che più conta, non c’è nulla di predeterminato nelle conclusioni finali quasi dando per ammesso che sempre ci sia un nesso rovesciabile tra le due posizioni, quella di chi si impone e quella di chi è costretto, di chi è l’autore/attore e di chi è la vittima, di chi, in altri termini si potrà dire, è incubo e di chi è succubo.
Christie osserva che così procedendo si rende inessenziale la pena, essenziale piuttosto essendo la comprensione/compensazione la quale dipende necessariamente da una classificazione, di volta in volta nuova, degli elementi rilevanti del fatto e di una loro ridefinizione quando non anche di una loro moltiplicazione sorprendente e magari nemmeno prima immaginata.
Credo di non aver capito bene che cosa precisamente dovrebbe succedere a questo punto. Mi sembra che si richieda, anzi si esiga, che dal soggetto in discussione emerga, si manifesti, sgorghi finalmente, un preciso senso di colpa, un riconoscimento di essere entrato in contraddizione non solo con un qualcuno ma con l’intera comunità. Un riconoscimento che attesta un ‘ho sbagliato’, un ‘ho commesso un errore’, un ‘così nessuno deve comportarsi’. Rispetto alla rigidità e alla inflessibilità, manifestata nel compimento dell’’atto socialmente sgradito’ e alla perseveranza difensiva di questo atto, si arriva alla compensazione con la premonizione che il suo nucleo sociale di riferimento lo considera provvisoriamente un estraneo, lasciandogli però una prospettiva, quella di ri-accoglierlo poiché ha coltivato ed espresso il senso della sua colpa. Tutto questo è anche inteso come sostanziale ‘risarcimento’ in favore della ‘vittima’, benché Christie non vuole che la si chiami così: perché da un lato la stessa parola indica la permanenza del conflitto, e dall’altro non esiste mai una vittima esente da colpe. Uso per comodità questo termine (vittima) per indicare la controparte di un conflitto.
Resta il fatto che nell’incontro sociale risolutorio, questa controparte è inevitabilmente esclusa quando sia morta; però potrebbero esserci al suo posto i parenti prossimi ben vivi o gli amici fidati ben stretti, tutti animati da uno spirito magari irriducibilmente reattivo. Non ci si dovrebbe meravigliare. Leggo poco le cronache giudiziarie dei giornali, ne ho lette troppe negli incarti processuali. In ogni caso non ho mai chiesto ai miei difesi se fossero colpevoli o se si reputassero innocenti, non ho mai chiesto le loro opinioni sui fatti contestati e anche ora, entrando in carcere, non chiedo di sapere dai miei interlocutori perché siano detenuti. Ci sono fin troppe e altre cose di cui parlare e anche troppe e altre cose da ascoltare, più decisive di quelle che sono state già dette o che già ho ascoltate. Tuttavia c’è sempre qualcuno, in tutte queste vicende, che si duole di avvenimenti ‘sgradevoli’, non accettabili. Per mio conto, uso un’altra parola e così entro in un altro sistema che non è solo comunicativo e che non è solo tecnicolegale.
È ben vero che ogni volta che si cambia una nominazione si cambia anche il sistema di riferimento. Chiamo dunque con un’altra parola ciò che nel processo penale è chiamato ‘reato’. Chiamo i ‘non puoi’, i ‘non devi’, limiti non superabili che hanno esistenza, origine e forme di controllo derivate sia da formazioni sociali allargate che da organismi normativi ristretti. Limiti che riguardano non solo l’uccidere, ma nemmeno il rubare le elemosine in chiesa, oppure l’aggiotaggio, e anche l’organizzazione dell’accattonaggio o dei venditori di fiori senza licenza che fanno la posta ai clienti fuori dai ristoranti, e così le corruzioni di ogni genere. Non si possono fare un mucchio di cose, non si possono valicare molti limiti. I limiti funzionano per il mantenimento di rapporti sociali come dati e questo è un paradosso, questo è il limite dei limiti. Capisco benissimo che a qualsiasi sistema penale, compreso a quello italiano, non si possa né si debba dare un fondamento di natura teologica, ma, per la sua bulimia, nemmeno uno teleologico, cioè finalizzato. La mancanza di un fondamento dipende dalla fragilità degli ammassi legislativi prodotti da autorità pubbliche troppo spesso inaffidabili, incerte, emotive, che a loro volta diffondono incertezza, confusione, disorientamento, intorno al ‘che fare” socialmente utile, produttivo ed escludente comportamenti sgraditi.
Mi vado allora convincendo di questo: come tutte le donne intorno alla fontana, ciascuno di noi è chiamato ad assumersi responsabilità pubbliche nel senso di assolvere, al momento opportuno, il compito di orientare e di canalizzare bisogni e desideri sia personali che collettivi e sociali.
Tutti come donne alla fontana, ma anche con gli uomini riavvicinati per non lasciarli soli a discutere. Lo capisco nel senso di una necessità: quella di diventare tutti ‘testimoni’ dei limiti e non solo ‘spettatori’ dei limiti. Appunto testimoni: laddove la testimonianza come termine nuovo di riferimento ha una precisa derivazione etimologica che dovrebbe piacere anche a Christie. La sua derivazione è latina, testis, a sua volta derivata da terstis, come colui che sta come terzo nel conflitto ed è chiamato a collaborare nella soluzione dei contrasti. O, con termine greco, marturya che nulla ha a che fare con i martiri o il martirio, ma piuttosto riporta non già a un sanguinoso sacrificio bensì al mantenimento di una buona memoria.
In questa società nella quale fioriscono quantità esagerate di precetti penali e di divieti, in questa società non etica ma cosiddetta ‘del tutto penale’, risulta ben chiaro che questo essere ‘tutto penale’ non è per nulla efficace, non lo è nemmeno la minaccia delle pene, perché il corpo sociale si dibatte tra istanze moralizzatrici e spaventose tendenze a rifiutare qualsiasi remora sociale. Una volta c’erano i padri legislatori. La giustizia verticale è rappresentata icasticamente da Mosè che scende dal monte con le sue tavole della legge. Padre nobile lui, come padri nobili sono i fondatori di tutte le religioni ‘del libro’ e anche di tutte le legislazioni laiche. Ebbene tutti questi ‘padri’, e specialmente quelli della molteplicità dei prodotti penali diffusi, si sono ridotti a un padre solo ma evaporato, disciolto, e anche dissoluto: disciolto perché non è più controllabile, liquido com’è; dissoluto perché, lui per primo, si è liberato dalle regole, da ogni regola. Ecco perché la testimonianza delle donne alla fontana (in questo momento mi piacerebbe essere una di loro) è una testimonianza contro la dissoluzione del padre, contro la rinuncia a esercitare il senso e il valore del limite, perciò anche contro la violenza come metodo risolutore dei conflitti.
Desidero che l’ultima parola spetti a Platone nel Protagora e gliela cedo sintetizzandola: “Vergogna e giustizia, da parte del padre Zeus, sono state diffuse su tutti e per tutti, allo scopo che la legge fondamentale sia questa: chi non partecipa della vergogna e della giustizia deve essere senz’altro escluso dalla città”. Il legame sociale è disciplinato da una unità tra aidos (vergogna) e dike (giustizia) senza delegare a nessun specialista la funzione esclusiva del controllo dei limiti. Questo è forse il punto di convergenza che, seppure con natura diversa originata da diversi sistemi socio-giudiziari, potrebbe intersecare utilmente la strada aperta da Nils Christie. Almeno lo spero.