C’era una volta il buon vecchio medico di famiglia. Conosceva vita morti e miracoli di tutto il tuo parentado, talvolta indietro fino al bisnonno, e non c’era verso di dirgli e spiegargli cosa avevi. Lui ti guardava, girandoti da tutti i lati; ti batteva petto e schiena (talvolta i release delle rotule); annusava il tuo fiato e forse anche le urine e le feci. Solo dopo un po’ (talvolta un bel po’) emetteva la diagnosi. Se non poteva prescrivere lui il rimedio, diceva che c’erano da fare delle analisi in ospedale e poi si sarebbe visto. Ma se non c’erano complicazioni, allora, era tutto più semplice: cominciavi la cura e guai sgarrare. Perché poi s’informava, dalla mamma o dal papà, e voleva vedere come e se ti rimettevi in salute.
Solo coscienza professionale? Sono portato a pensare che – nei casi migliori, ovviamente – quel tipo di medico possedesse anche una forte dose di empatia e un genuino interesse per l’essere umano che si ritrovava davanti. Grazie a questo tipo di medico ho imparato a capire che cosa significa ‘razza in via d’estinzione’, e a non fidarmi mai dei medici di nuova generazione. Credo di avere individuato, in particolare, un paio di sintomi rivelatori infallibili, segnali d’allarme rosso a cui obbedisco religiosamente senza fiatare. Anche perché – purtroppo – c’è tutta una serie di professionisti che a starli ad ascoltare attentamente ti rivelano prima o poi gli stessi sintomi. I geometri e i ragionieri, in particolare, se arrivano ad acquisire lo status di intellettuale – una sorta di genius loci ad alto grado di autovalorizzazione – sono tra quelli da cui rifuggo, girando l’angolo anche in funzione preventiva e non solo curativa. So bene che se entrassi in discussione con tali figuri potrei guastarmi la giornata e allora per reazione diverrei feroce, difensore civico di me stesso, pubblico ministero del tribunale del malato occasionale (vado dal medico sì e no una volta l’anno), Torquemada dei regolamenti condominiali a vantaggio degli inquilini e non dei proprietari.
Dicevo, un paio di sintomi: guardate male chiunque, che chiamato da voi a dare il suo parere su un qualunque oggetto di conoscenza, vi dice: «È particolare». Guardate ancora peggio chi si esprime in modo impersonale nei confronti di qualcosa che deve essere fatta, meglio prima che poi, e vi dice: «C’è da fare questo… c’è da fare quello».
Come diceva Gramsci (citando Hegel), non sopporto chi non prende partito. Parto dal sacrosanto principio secondo cui non è possibile non comunicare. Qualunque atteggiamento, anche l’immobilità e il mutismo assoluti, possono comunicare – e di fatto spesso comunicano assai meglio che una sola parola. Dunque, tanto vale dire ciò che si pensa, francamente, garbatamente, senza nascondersi dietro l’ipocrita aggettivo ‘particolare’ o dietro l’ancora più ipocrita enunciazione di un dovere da compiere senza individuare l’attore che debba compierlo.
Nel primo caso, come spesso accade, avete semplicemente un po’ di timore a dire la vostra, oppure vi sentire sminuiti se non riuscite a esprimere nemmeno un piccolo giudizio di valore, e allora ricorrete a un aggettivo che a parer mio è più un autogoal che altro. ‘Particolare’ è equivalente a ‘specifico’, o meglio a ‘speciale’, nel senso che la sensazione che provate (visiva, auditiva, gustativa, olfattiva ecc.), ma anche il giudizio che siete chiamati a esprimere su persone, cose, luoghi, accadimenti, non è mai derivante da un giudizio generale ma, appunto, da un giudizio che isola la sensazione o l’opinione dal contesto e le rende particolarmente rilevanti, speciali, starei per dire uniche nel loro genere. Di fatto, state esprimendo un giudizio piuttosto netto, cioè il contrario esatto di ciò che volevate fare. Cosa ancora più sorprendente, capita più spesso che volentieri di incontrare persone che la pensano in modo diametralmente opposto al vostro su una certa cosa: infallibilmente, vi ritrovate affratellati a loro per opera di quello sciaguratissimo aggettivo. A dire il vero il più delle volte, dietro un uso così maldestro, si cela pura e semplice ignoranza (non è più schietto dire semplicemente: «Non capisco bene, ho bisogno di riflettere»?).
L’effetto di tutto questo è terrificante: milioni di italiani che rifiutano di esprimere un’opinione chiara e definita, usando aggettivi inequivocabili, e si limitano a dirvi con un sorrisino che ciò che hanno davanti si distingue dalla massa. Possibile siano diventati tutti ipocriti, o piuttosto non possiedano altro vocabolo per dire l’indicibile?
Ho sentito raccontare di alcuni indigeni (polinesiani, credo) che entrati a contatto con l’uomo bianco e avendone ricevuta violenza, divennero terribilmente tristi, vedendo il loro mondo tramontare con velocità impensabile oltre che incredibile. Ma più ancora della tristezza per la fine di un Eden, pare che a portare molti di loro al suicidio sia stata addirittura l’impossibilità di trovare non dico un aggettivo, ma neanche una perifrasi per esprimere il loro dolore.
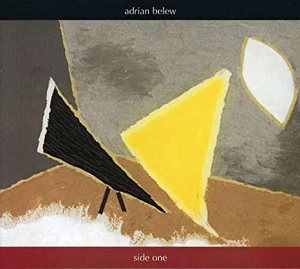
Non andiamo meglio se pensiamo all’altra ipocrita locuzione: «C’è da fare questo…». Qui, quello che fu il Belpaese mostra il suo lato più degenerato: non solo afasia aggettivale, ma somma dimostrazione del male nazionale, ovvero la mancanza di senso di responsabilità, la mancata assunzione di un ruolo, di un onere. Se ricoprite un ruolo gerarchico ci si aspetta da voi che, una volta individuato il compito da svolgere, scegliate anche chi lo debba svolgere. E dunque dovreste dire: «Fai questo, fai quello». Magari anche con modi e maniere cortesi e non autoritari. Se non avete invece un ruolo gerarchico, e siete un parigrado, abbiate il senso di responsabilità di dire: «Io non ne voglio sapere di fare questo. Fallo tu, se credi». Nel caso precedente mancavano le parole, qui le azioni.
Peste lo colga, dunque, a colui che messo di fronte a questi quattro album (Side One, Side Two, Side Three e Side Four) del chitarrista statunitense Adrian Belew, non riesce a dire altro che: «Particolare». Uguale destino per chi, dopo averli ascoltati, vi dica: «C’è da andare a comprare questi album». Senza dirvi che vuole ci andiate voi per suo conto, o che non vuole proprio muoversi e tocca a voi. Io per conto mio mi sbilancio, e non poco.
Belew è un mostro: ha suonato, richiestissimo ingrediente di pregio, neanche fosse l’uovo afrodisiaco di un animale esotico, in dischi memorabili come Discipline dei King Crimson (suo il barrito elefantiaco di Elefant Talk) e Sheik Yarbouti di Frank Zappa, Lodger di David Bowie, Remain in Light dei Talking Heads e al live The Name of This Band is Talking Heads. A metà degli anni Ottanta, Laurie Anderson lo ha chiamato per partecipare al tour di Home of the Brave. Sono tutti di Adrian i suoni più alieni, strazianti, inconsueti o semplicemente intriganti. Sua è l’inconsueta (e dunque rara) abilità di piazzarsi intelligentemente negli interstizi delle melodie principali, facendole assomigliare a qualcosa che non esiste ma che sapete che c’è ed è bellissimo.
Attonito, presenziai alla tappa bolognese (1980) del tour di Remain in Light, un album talmente denso da richiedere una doppia formazione per il tour dal vivo. Lì mi convinsi che Belew (seconda chitarra, in realtà leader assoluto) non era solo un mostro di bravura, ma anche un nuovo tipo di musicista, capace di filtrare tutte le sue chitarre attraverso un sintetizzatore Roland e di inserire quegli stessi suoni e relative scale e appropriati a solo assolutamente nonsense in complesse polifonie mutuate dall’Africa. La regia retrostante era di Brian Eno (e ho detto tutto). Da quel giorno Belew è decollato, rimanendo poi sempre sulla cresta dell’onda senza soluzione di continuità.
Se dovessi immaginare che questi quattro album, con (quasi) lo stesso titolo, appartengono a un medesimo coerente progetto (come fosse il White Album dei Beatles), direi che il nostro Side One è l’album della metafisica pura. Diversamente da Zappa, che faceva passare cose complicate (arrangiamenti, ritmi, suoni) attraverso l’ironia dei testi e la mimica sul palco, Belew ha la capacità di far passare lisce cose complicatissime, anche se non lo vedete e non capite i testi. Ma non per spirito snob, perché è fatto così. Tutto l’album è intensamente pervaso di spirito progressive, per quanto questo termine possa ancora significare qualcosa di vivo, vitale e fortemente inventivo pur nella forma canzone (che rischia di virare alla suite ogni tre per due, se capite cosa voglio dire). Lasciatevi andare a questa narrenschiff. Solo così capirete come godervi Writing on the Wall, immaginando la voce di un ventenne per scoprire che ne ha sessanta; e leviterete solo se pensate alle piazze di De Chirico, ascoltando la tabla di Matchless Man e il basso simile a un serpente che esce dalla cesta dell’incantatore (niente di meno che Les Claypool dei Primus!). Lasciatevi andare.
Eviterete di rincoglionire tentando di capire il tempo di Ampersand (suonato da Danny Carey dei Tool!) e non vi interrogherete su come riescano a dialogare chitarra e basso in Madness. Ancora: il basso di Walk Around the Wall nella figura in A è un gioiellino di struttura recursiva; in Beat Box Guitar non potete non pensare al cavaliere della valle solitaria che gira a vuoto come la puntina di un giradischi contro un granello di sporco: una chitarra dal giro armonico epico, insomma, anche se perdente. L’inizio di quella miniatura che è Under the Radar fa pensare a certe atmosfere patafisiche della Penguin Cafè Orchestra, con l’ultimo uomo rimasto sulla faccia della terra che va in vacanza sotto una parabolica. Elephants è, appunto, un incubo elefantiaco; Pause è la politica dell’interstizio.
A voi studio. E guai a voi se non ascoltate anche gli altri tre album, specie il secondo. Non fosse altro per quella per la beatlesiana che è Quicksand.
Adrian Belew, Side One, Sanctuary records, 2005

