Intervista di Massimo Vaggi
“Le risorse umane” di Angelo Ferracuti sono esseri umani che lavorano e vivono fuori dalla notizia, nella quotidianità di un’esistenza tanto poco patinata quanto, per loro, memorabile. Uomini e donne le cui vicende l’Autore indaga con occhio infi nitamente interessato e insieme partecipe e commosso, attento com’è a coglierne e trasmetterne il valore e l’unicità. Al confine dell’inchiesta, ma sempre ben lontano dal piccolo cabotaggio della cronaca, Ferracuti ferma la nostra corsa indicandoci la necessità dell’empatia e l’urgenza della curiosità. Il libro, uscito nel 2006, è ora fuori catalogo, ma l’attualità e originalità della proposta di Ferracuti è confermata dalla prossima pubblicazione per Einaudi e Alegre – nel 2013 – di due lavori con temi e caratteristiche del tutto simili.
Dopo l’esperienza della narrativa pura, con Le risorse umane confermi la scelta di una scrittura ibrida, contaminata dal desiderio del raccontare e al tempo stesso dagli elementi del reportage. Quali sono le ragioni di questa decisione?
Nel 2002 uscì un mio romanzo, Un poco di buono, che collezionò una serie incredibile di stroncature, ma stavo già riflettendo da tempo sul fatto che nella Società dello spettacolo e del reality la fiction era omologata allo stesso sistema; forse bisognava trovare altre strade per scrivere in una maniera diversa, meno codifi cata. Io stesso leggevo più saggi, inchieste e libri di storia, avevo l’impressione che mi dicessero più cose sul mondo, sulla società contemporanea.
Mi sembravano libri più vitali, più colti, meno legati alle solite combriccole degli scrittori, insomma. La recensione, il premio, la collaborazione, cose molto italiane. Quelle stroncature, alcune delle quali feroci, accelerarono forse il mio ripensamento. Ma avvenne anche perché nel frattempo avevo conosciuto Mario Dondero, il Kapuscinski italiano, fu il suo modo rabdomantico di fare reportage fotogiornalistici ad affascinarmi e spingermi verso la scelta di una scrittura dal vero. Anzi, sempre grazie a lui cominciai a collaborare al Diario, dove poi alcune di queste storie uscirono in anteprima. Da allora non ho scritto più una riga di fiction e non ho smesso più di scrivere in questo modo un po’ ibrido, rabdomantico, che sento davvero congeniale. È una forma di scrittura molto duttile, dentro il suo sedimentato possono finirci materiali diversi che concorrono tutti insieme allo stesso racconto. Notazioni di viaggio, nozioni storiche, geografiche, racconto in presa diretta, frammenti di un film, persino dei versi. Molte volte dentro un disordine prestabilito di cose, qualcosa di molto ondivago e molto libero. Tutto il contrario di una trama di un romanzo.
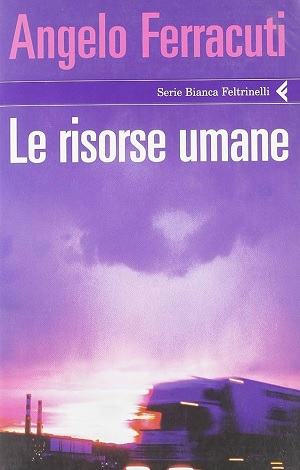
Tutti i racconti del libro mescolano l’esperienza degli intervistati con quella dell’intervistatore, che non vuole affatto nascondere dietro un presunto asettico ruolo di scientifico analista la propria esistenza, e con essa il suo sentire, le sue emozioni, la sua partecipazione, che invece diventano parte necessaria della storia. In questo modo superi molti cliché: quello della narrativa che vuole l’autore sullo sfondo della vicenda nell’esercizio di una finzione di imparzialità e quello del giornalismo d’inchiesta che esclude l’emotività dal contesto di dati e di parole.
Vero. Ma sia la narrativa tout court che il giornalismo si stanno reinventando in questi anni, e forse una nuova idea di realismo può venire solo da queste scritture se sono scritture alte e con un alto tasso anche di emotività. Ho fatto tutto questo in modo abbastanza istintivo, naturale, anche se ogni scelta espressiva comporta un ragionamento estetico anche molto profondo, e certo per scrivere un reportage dal vero serve anche tutto l’armamentario dello scrittore, le forme, i modi, solo che tutto questo deve scomparire un secondo prima che possa diventare finzione. Ma restare, invece, nell’efficacia dei dialoghi, nella maggiore espressività della lingua, nella descrizione dei luoghi, dei paesaggi, delle persone, e anche nel riuscire a creare un immaginario capace di andare oltre la soglia di un fatto per illuminare quella zona grigia dove forse sta la verità di una storia. In tutto questo però il regista, il centro, l’occhio onnisciente che controlla tutto è sempre quello di chi scrive, che però partecipa, mette in comunione se stesso con gli altri nel rapporto di empatia, che è fondamentale in questo tipo di lavoro sul campo, una cosa che fanno anche i grandi giornalisti. Il problema a volte è trovare lo spazio adeguato per questi reportage, e siccome sulla carta stampata ce ne è sempre di meno, almeno in Italia, il libro è l’oggetto più meditato dove l’arte dell’avvicinamento a una storia, personale o collettiva, avviene e si compie in modo migliore.
Racconti il lavoro, ma attraverso quello il tuo interesse è per l’uomo che lavora, per quell’uomo che lavora.
Mi interessa perché ha un grande immaginario. Al di là dell’interesse politico, del rapporto tra capitale e lavoro, è qualcosa che ha avuto un’epica e tuttora può essere un ottimo argomento per uno scrittore. Nel lavoro c’è una attività corporale molto forte. Tutto quello che facciamo nella nostra vita confina con uno dei mondi del lavoro, e questi con la nostra esistenza, con la disumanità della fatica e l’umanità di chi quella fatica la sopporta, ne viene cambiato persino nei lineamenti del corpo, invecchia o muore mentre sta lavorando, oppure è sopra una gru e protesta perché è stato licenziato. In una accezione di epica moderna, di epica minore, quella del quotidiano, il mondo del lavoro ha degli scenari straordinari dove di più e meglio si misurano anche i conflitti inesplosi, qualcosa che cova e magari non ha voce ed è urgente raccontare. Andare di notte in una fabbrica mentre gli scioperanti fanno i picchetti e altri operai vogliono andare a lavorare, magari perché sono precari, apprendisti, perché hanno paura di perdere anche il poco che hanno, vedere e raccontare gli incontri di questi corpi e percepirne il trauma silenzioso è per uno scrittore un materiale incandescente. È un’epica invece poco raccontata dai giornali borghesi, che in genere preferiscono quella dei capitani d’industria, che poi ne sono a volte anche i proprietari o i maggiori inserzionisti.
Il mondo del lavoro è tema estremamente difficile, perché oggi è abitudine quella di raccontarne la dimensione esclusivamente economica o per così dire finanziaria. Nei giornali come alla televisione, come nelle girandola di opinioni che determinano il dibattito comune, gli uomini sono letti e interpretati nella qualità di funzioni produttive. Le masse dei lavoratori sono le somme di cifre di compatibilità. Attraverso i tuoi racconti la vita entra prepotente, e reclama il suo spazio di soggetto principale.
Oggi il lavoro dovrebbe essere il racconto principale dell’epoca, come lo fu nel periodo della Grande Depressione, soprattutto negli Stati Uniti, ma non c’è adesso un romanzo, almeno in Italia, che abbia raccontato tutto questo, non c’è un Memoriale di Paolo Volponi, un Donnarumma all’assalto di Ottieri. Il mio libro, ma anche tutto quello che ho continuato a scrivere dopo, soprattutto per il Manifesto, ha l’ambizione di ricominciare un racconto interrotto, un racconto letterario della realtà delle vite lavorative. Infatti il titolo ha questa connotazione, così come l’epigrafe di Saul Bellow: “La vita di un uomo non è una impresa commerciale”.
Il movimento operaio ha lottato tutto un secolo per alcuni diritti fondamentali, oggi erosi dal neoliberismo su scala planetaria. Solo la polizia di Scelba lasciò sulle piazze italiane oltre cento morti e migliaia di feriti nel corso di scioperi e manifestazioni di protesta. ‘Risorse umane’ invece è una dicitura ipocritica di un sistema di organizzazione che non mira tanto alla valorizzazione delle persone quanto allo sfruttamento di esse, all’ottimizzazione in termini di produttività, quindi anche il lavoratore diventa una merce nel mercato occupazionale, un uomo usa e getta, l’uomo flessibile di Sennett per intenderci. La sconfitta comincia nel linguaggio, è quello che va combattuto, svelato. Volevo ricordare che dietro un lavoratore c’è una persona, ci sono le sue emozioni, le sue umiliazioni, i suoi sogni, che in un luogo del genere si sviluppano legami sociali importanti non solo in termini economici, ma anche umani, cosa che per esempio la precarietà ha ridotto fortemente, sostituendo l’individuo alla comunità, l’egoismo alla solidarietà, l’arrivismo e la competizione alla lotta di classe.
Un viaggio su un Tir insieme a un camionista. Entrare nei bar e dentro i negozi della Chinatown pratese. Vivere è davvero l’unico modo per comprendere fino in fondo la realtà?
No, assolutamente, a volte la realtà mente. Forse è una risposta al voyeurismo televisivo e alla vita immateriale dei labirinti senza fili di internet, voglio pensare. Quel ‘naturale’ contro ‘l’artificiale’ di cui parlava Volponi, cioè una critica al finanzcapitalismo e alle società mediatiche, dove le forme di dominio passano attraverso i mezzi tecnologici.
Anche se non è una cosa nata ieri, questo tipo di esperienza della scrittura c’è sempre stata, a cominciare dal Milione di Marco Polo o dal gran tour che gli scrittori facevano in Europa, da Goethe a molti altri, per non dire del De Amicis che Sull’Oceano racconta l’emigrazione italiana di fine Ottocento, o quel classico che è Viaggio in Italia di Piovene. Quindi questa scrittura che nasce sul campo è appartenuta soprattutto ai viaggiatori, agli esploratori, si pensi a Fosco Maraini, per esempio, ed è assolutamente ipersoggettiva, sempre molto parziale, ma va sempre più in profondità di un servizio del tg o di un articolo di cronaca, quella in stile anglosassone che si attiene ai fatti. C’è anche un elemento poi di avventura e anche l’idea che la scrittura non è un fatto solitario ed elitario ma come dice proprio Ryszard Kapuscinski un’opera collettiva, firmata da uno ma scritta da tutti quelli che abbiamo incontrato lungo la strada e che ci hanno fornito informazioni, racconti, persino aiuti pratici. È proprio un altro modo di concepire la scrittura.
Nonostante l’evidente scelta di stare da una parte sola, non trascuri di appassionarti alle vicende di coloro che a rigore dovrebbero essere estranei a quel mondo che più appartiene alla tua dimensione, quello operaio. L’artista di altissimo livello, il manager, ottengono la tua attenzione solo in ragione di un evento drammatico che colpisce la loro vita?
Certo che mi interessa la vita dei manager. Mi interessa tutto, persino quella forma di cinismo culturale che guarda al profitto come l’unica via possibile al benessere sociale. La disumanizzazione avvenuta nei mondi del lavoro negli ultimi vent’anni è esemplare nelle esistenze che conducono certi di loro. Un’idea mistica del lavoro come missione non solo economica, o narcisistica, ma quasi religiosa, in senso negativo, e in parte militare. La struttura organizzativa di una azienda, l’organigramma è di tipo autoritario, verticale, e la fabbrica architettonicamente ha qualcosa di concentrazionario.
Anche Auschwitz era una fabbrica, anche Dachau, all’entrata c’era una scritta agghiacciante in metallo che diceva: “Il lavoro rende liberi”. Ma anche i tagliatori di teste mi interessano. Mi interessano perché sono uno scrittore e ho anche il dovere morale di raccontare tutto ciò che è sommerso. I tagliatori di teste, o i rottamatori di aziende la mattina danno un bacio tenero alla moglie, accompagnano i figli a scuola, poi vanno in azienda a licenziare le persone. Anche loro si trincerano dietro all’idea che hanno eseguito solo gli ordini del capo, dell’amministratore delegato, del direttore generale. È solo un fatto tecnico quello di tagliare i rami secchi, rende solo più forte l’azienda in termini competitivi. È una cosa giusta. Il cinema negli ultimi anni ha raccontato molto bene questo aspetto, a cominciare proprio da Risorse umane di Cantet. Quando mi dissero che esisteva un film con quel titolo, che purtroppo mi era sfuggito, avevo già dato lo stesso al mio libro al quale stavo lavorando. Mi sembrava molto giusto, perfetto per i miei reportage, così decisi di non cambiarlo.
Il libro è dedicato a uno dei più grandi fotografi italiani Mario Dondero. La potenza comunicativa dell’immagine fotografica, tua grande passione, determina un certo modo di rappresentare la realtà nelle tue pagine?
Mario Dondero è davvero un raffinato intellettuale che ha attraversato il Novecento, ed è solo credo un dettaglio che l’abbia fatto con la macchina fotografica. Poteva essere, se solo avesse voluto, anche un grande scrittore o uno storico. Questo per dire che fotografare è stato credo il risultato di tante altre cose. Di lui mi piace il grande impegno, questo voler fare sempre la fotografia politica, sociale, essere con ostinazione e generosità dentro i più importanti eventi della Storia, ma allo stesso tempo però raccontare con grande classicità la commedia umana, scansando ogni retorica. Se ruba una foto al processo Panagulis prima di essere arrestato dalla polizia, non ritrae solo l’eroe greco della Resistenza, il militante comunista, ma anche un uomo giusto che viene ingiustamente condannato a morte dal potere. Quella foto è dentro la Storia del momento ma diventa anche qualcosa di assoluto, cioè il prototipo di tutte quelle storie della Storia.
Come dicevo all’inizio lo considero un po’ il mio maestro, quello che è riuscito a farmi capire come si fa un reportage, ma soprattutto che scrivere, fotografare, oppure fare un altro lavoro artistico, serve come «collante delle relazioni umane» come dice lui, e non ha assolutamente fini mondani o carrieristici, i quali vanno a minare la missione etica. Però è anche vero che amo la fotografia e i fotografi, anche perché la mia è una terra fotocentrica, a cominciare da Luigi Crocenzi, che conobbi e frequentai giovanissimo, il quale m’incoraggiò a scrivere, l’inventore del racconto fotografico neorealista e impaginatore del Politecnico di Elio Vittorini, e spesso mi sono avvalso della collaborazione di alcuni di loro. Di Mario Dondero, ma anche di Ennio Brilli, che ha una tempra più etnografica, più legata al reporter di viaggio, ma che non ha nulla da invidiare in quanto passione politica. La mia idea è che quando si incontrano un bravo scrittore e un altrettanto fotografo sensibile e di talento i loro sguardi si incrociano e il risultato finale è qualcosa di più forte, nato da un potenziamento reciproco. Forse però c’è anche un elemento umano, e cioè il fatto che in due si rompe l’accerchiamento della solitudine, che però a volte è necessaria per lavorare in assoluta concentrazione e con i propri tempi.
Un lavoro ‘in solitaria’ che somiglia a quello dei velisti, che non è solo fisico, corporale, ma anche mentale, quasi ossessivo, e che non finisce fin quando qualcuno ti dice che il libro deve andare in stampa, non c’è più tempo, tocca tirare i remi in barca, bisogna chiudere.
Angelo Ferracuti è nato a Fermo nel 1960, dove ancora vive e lavora. Per Transeuropa ha pubblicato Norvegia (1993) e Nafta (1997). Guanda ha pubblicato Attenti al cane (1999) e nuovamente, nel 2000, Nafta. Nel 2002 è uscito Un poco di buono (Rizzoli). È del 2006 Le risorse umane (Feltrinelli), con il quale ha vinto il Premio Sandro Onofri, tradotto in Spagna, e del 2009 altri due libri di reportage: Viaggi da Fermo (Laterza) e Il mondo in una regione (Ediesse). Nel maggio 2013 uscirà nella collana Frontiere di Einaudi, Il costo della vita, che ricostruisce la più grande tragedia operaia del dopoguerra, avvenuta a Ravenna nel 1987, con un inserto fotografico di Mario Dondero, e sempre nell’ottobre dello stesso anno, da Alegre, la raccolta di reportage I tempi che corrono. Collabora con il Manifesto, L’Indice dei libri del mese, e per Ediesse cura la collana Carta bianca.


