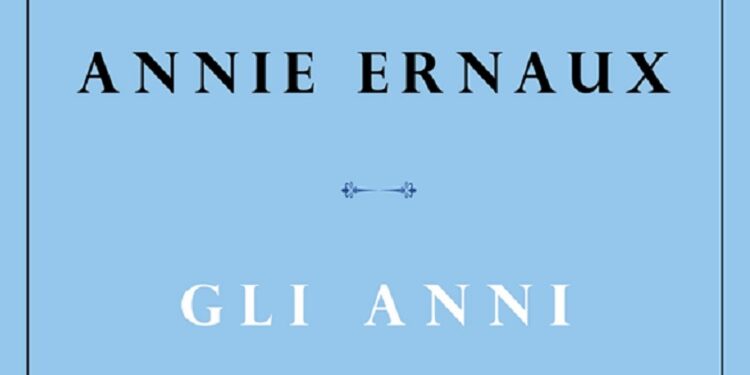Sabrina Campolongo
Recensione de Gli anni, Annie Ernaux
Nei suoi quasi quarant’anni di carriera letteraria, Annie Ernaux ha scritto più di venti romanzi, quasi tutti rigorosamente autobiografici, che sono stati tradotti in moltissimi Paesi, e alcuni riadattati per il teatro e il cinema; in Francia è tra gli intellettuali più noti, è studiata all’università, considerata un punto di riferimento imprescindibile nel genere dell’autofiction. Potrebbe, o dovrebbe sorprendere che in Italia sia rimasta sostanzialmente sconosciuta, sebbene Rizzoli abbia provato troppo timidamente a tradurla negli anni Novanta (opere finite troppo presto fuori catalogo). Sarà forse che la categoria dell’autofiction mal si applica alle opere di Annie Ernaux, sorprendentemente poco autoreferenziali, anche quelle più intimistiche, come Passione semplice.
Scavando nella propria vita, Ernaux ricerca il superamento di sé come individuo, concentrandosi invece sullo stretto legame tra memoria privata e memoria collettiva, sulla forza dei condizionamenti sociali, su ciò che la rende figlia e interprete di un ben determinato momento storico e paradigma culturale. Parlando del suo lavoro, Annie Ernaux utilizza un ossimoro, autobiografia impersonale, che ben sintetizza l’unicità della sua opera e anche la sua importanza.
Per fortuna, una meritata seconda possibilità nel nostro distratto Paese le è stata offerta nel 2014 da L’Orma editore, che coraggiosamente ha tradotto uno dei suoi romanzi fondamentali e più rischiosi, Il posto, pubblicato in Francia nel 1983, nel quale, dipingendo il ritratto del padre e della sua ricerca di riscatto sociale, da contadino a operaio e infine piccolo commerciante, presto spazzato via dalla concorrenza della grande distribuzione, Ernaux ricostruisce la realtà della provincia francese nell’ultimo secolo. Segue, nel 2015, quello che probabilmente è il suo capolavoro, Gli anni, opera frutto di appunti raccolti in un ventennio e pubblicata in Francia nel 2008.
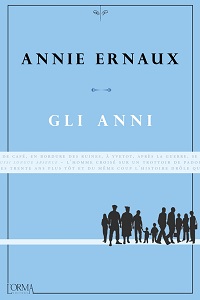
Un romanzo che rappresenta il tentativo ambizioso di restituire il fluire della vita stessa, in cui i grandi avvenimenti della Storia e i piccoli fatti quotidiani sembrano avere uguale peso in un flusso ininterrotto di parole raccolte in paragrafi brevi, eppure mai didascalici; le notizie che arrivano da un fronte di guerra lontano e la réclame pervasiva di nuovi prodotti, il centro commerciale e la piazza, i luoghi dei bombardamenti e quelli prescelti per le vacanze che scorrono come un fiume sullo schermo del ricordo e che eppure, grazie alla solidità della struttura ma, più ancora, all’acutezza, alla profondità, all’intransigenza della scrittura diventa grande narrativa, capace di emozionare, ma anche di indignare, di irritare e coinvolgere il lettore, di metterlo in discussione senza offrirgli mai il facile conforto dell’immedesimazione.
La voce narrante si mantiene incredibilmente neutrale, come è caratteristica di un’autrice che da sempre rifugge il sentimentalismo, tanto più quanto i temi trattati le sono vicini. La prima persona è bandita in favore della terza, alternata alla prima persona plurale per le ampie porzioni in cui la protagonista si perde e si espande dentro una realtà più vasta, quella della sua generazione.
“Ci si meravigliava delle invenzioni che in un istante cancellavano secoli di gesti e sforzi, inaugurando un tempo in cui, come si diceva, non si avrebbe più avuto niente da fare.” “Non potevamo fare a meno, nostro malgrado, di notare le maniere altrui, il brodo bevuto dal piatto, lo zucchero fatto sciogliere agitando la tazza, le espressioni usate per designare ‘una persona altolocata’, e d’un tratto percepivamo il nostro ambiente familiare come se ne fossimo estranei, come se di trattasse di un mondo chiuso al quale non appartenevamo più”.
Ernaux sembra voler tradire i principî stessi del narrare: la sua è una storia in cui la protagonista emerge solo a tratti, raccontandosi dal punto di vista di un osservatore esterno, un’eroina senza ostacoli da superare o missioni da compiere, trascinata nel flusso della vita all’interno di una massa indistinta, uomini e soprattutto donne, mossi inesorabilmente verso lo sbocco di un destino individuale e collettivo che non appare frutto di una vera scelta. La potenza del condizionamento sociale sulle esistenze di tutti quanti, libere solo in apparenza, si rispecchia, all’interno del romanzo, nella soverchiante preponderanza degli eventi esterni sulle vicissitudini private, su quelle variazioni minime che creano l’illusione di un’unicità delle nostre vite. I fatti si susseguono apparentemente senza distinzioni: matrimoni, figli, divorzi, elezioni, vacanze, guerre, acquisti, libri, rivolte, lavori, case, guerre… semplicemente accadono uno dopo l’altro, ma ben presto è chiaro che la casualità è solo apparente, e che se il tono della narrazione è volutamente neutrale non lo è il pensiero che la conduce.
L’analisi dell’autore si manifesta con forza ancora maggiore dal momento che non è espressa direttamente, ma lasciata emergere dai fatti, nudi, certo, spogliati del corollario di emozioni che li accompagna nella narrazione classica, ma messi in fila in modo tutt’altro che inconsapevole. La scelta di non utilizzare la prima persona singolare è già una dichiarazione di intenti. L’utilizzo dell’Io avrebbe presupposto infatti un punto di vista costante, un’unità della voce che si esprime, uno sguardo e uno solo su un mondo in trasformazione, quando invece la ricerca di Ernaux va in direzione contraria, quel che vuole è ritrovare l’Io di ogni fase della sua vita, il modo in cui questo Io cangiante e instabile vedeva se stesso e la realtà.
Non a caso, quello delle prime pagine è del tutto inconsapevole, è quello di un neonato, il quale, non avendo consapevolezza di sé come di qualcosa di separato dal mondo non può raccontarsi, non può dire né pensare Io, tanto meno sa di essere una femmina. “È una foto virata seppia, ovale […] Un neonato grassoccio con la bocca imbronciata, i capelli scuri a formare un ricciolo sulla testa […] In questo documento d’archivio famigliare – che deve risalire al 1941 – è impossibile leggere altro oltre alla messinscena rituale, modellata sui canoni della piccola borghesia, dell’entrata nel mondo.” Una foto dopo l’altra, vedremo questo neonato atteggiato a cherubino da un fotografo, così come era di moda allora, diventare una bambina e poi un’adolescente, una giovane donna e una donna matura, la vedremo tra amiche e amici, fidanzata, sposata e madre, divorziata e innamorata, al lavoro e in vacanza, in famiglia e spesso sola. Dagli anni Quaranta a oggi, dall’immediato dopoguerra all’era di internet e della mondializzazione, passando per gli anni Settanta della liberazione, dalla delusione degli anni Ottanta, le immagini segnano l’itinerario personale di una donna, ma sono anche finestre spalancate sulla memoria collettiva.
Lo spartiacque tra un’epoca all’altra è ben marcato dal rituale del pranzo domenicale con la famiglia, occasione di confronto tra generazioni, ma anche tra linguaggi diversi che si cercano, contaminandosi. Quello dei primi pranzi, nella campagna francese lontana dai grandi avvenimenti e da Parigi, è un linguaggio ancorato strettamente al reale e al tangibile, che aderisce e si fa interprete di un codice etico antico, solido, poco permeabile alle novità, puro ma anche conservatore, che Ernaux non ammanta di romanticismo. “Una lingua che, come tutte le altre, gerarchizzava, stigmatizzava, le donne di malaffare, ‘gli svitati’ e ‘i satiri’, i bambini ‘ritardati’, lodava ‘i ragazzi in gamba’, le ragazze serie, riconosceva gli altolocati e ‘i pezzi grossi’, ammoniva, ‘la vita ti farà rigare dritto’.”
I primi pranzi vedono la protagonista, così come gli altri bambini, muto spettatore dei discorsi degli adulti, discorsi che quasi sempre tornano alla guerra, anche dopo che questa si è conclusa: si finisce sempre a parlare di privazioni, di paura, ma anche di piccoli eroismi, si celebra in qualche modo il fatto di essere sopravvissuti. Il bisogno di parlarne appare altrettanto forte di quello di dimenticare che altre guerre sono ancora in corso, l’Algeria, il Vietnam… troppo lontane, così come nessuno parla di campi di concentramento o del massacro di Hiroshima, perché “non avevano abbastanza talento o convinzione per raccontare ciò che sapevano ma che non avevano visto con i loro occhi”.
In seguito, la guerra perde il suo posto d’onore a tavola, lasciando spazio ad altri argomenti, mentre i bambini cresciuti, ora studenti di città, tornano a casa nel fine settimana con i panni da lavare e le pance vuote, partecipando, tra l’imbarazzo e la paura di rivelarsi già troppo lontani, ai nuovi discorsi sulle cose, gli oggetti che sempre più occupano le menti, i sogni, le ambizioni di tutti quanti. Il linguaggio muta e si adatta, prende sempre più spesso parole in prestito alla pubblicità delle merci. L’esaltazione del consumo, dopo le ristrettezze della guerra, conquista a poco a poco anche i più scettici; chi non partecipa a quell’euforia generale inizia a essere visto come sofferente di un qualche complesso o irrimediabilmente antico, mentre possedere una televisione fornisce argomenti di conversazione comuni, rimanere aggiornati sulle nuove mode sembra conferire “un diritto di parola superiore”.
Dalla sua condizione di donna, la giovane protagonista vede nello studio prima e nel lavoro poi il modo di sfuggire alle catene che hanno bloccato le donne in passato, catene di cui comunque avverte il fascino: perdersi in un uomo, nelle relazioni, chiudersi in una routine fatta di affetti, di cura della casa, accudimento dei figli. Eppure, da una strada diversa, benché con una nuova consapevolezza, anche chi ha letto la De Beauvoir non riesce a sfuggire dalla trappola delle antiche dinamiche. “Avevano pensato che non sarebbero mai diventate come le loro madri e ora, con più leggerezza, con una forma di disinvoltura incoraggiata dalla lettura di libri quali Il secondo sesso e da slogan come Moulinex libera la donna, ne prendevano il testimone, rifiutando però, a differenza loro, di riconoscere un qualsiasi valore a ciò che tuttavia si sentivano tenute a fare senza sapere bene perché.”
La forza dell’habitus, per dirla con Bourdieu, sembra resistere al vento libertario che esplode nel Maggio francese, soprattutto per quanto riguarda la generazione delle giovani donne che sono già sposate quando gli studenti scendono in piazza, e finiscono così per seguire da dietro le finestre la lotta che infiamma le strade, di cui eppure comprendono l’importanza e il senso. La libertà conferita dalla pillola concezionale, che pure si vergogneranno ancora a lungo ad acquistare, la fine degli aborti praticati nelle cucine (per sempre, si sperava allora), la nuova spregiudicatezza delle ragazze le riempie di fiducia in un futuro diverso e migliore. L’euforia di quel momento viene presto ridimensionata dalle delusioni politiche e sociali e da nuove paure: il crollo delle ideologie, “sperare in una rivoluzione era diventato ignominioso”, lo strapotere delle merci, la paura dell’aids, la crisi economica e la disoccupazione, il tradimento della classe politica di sinistra, la vittoria della verità televisiva sulla realtà, la desolante perdita di senso delle parole, “la ‘lotta di classe’, l’’impegno’, l’opposizione tra ‘capitale’ e ‘lavoro’ suscitavano sorrisi di commiserazione”, la progressiva quanto inesorabile corruzione del linguaggio.
Le ceneri del Maggio si spengono e, con l’eccezione degli scioperi dell’inverno del ‘95 contro il governo Chirac, nessuno proverà più a riaccendere quel fuoco. “L’anomia regnava. Il linguaggio si scollava dalla realtà come un segno di distinzione intellettuale. Competitività, precarietà, occupabilità, flessibilità andavano per la maggiore”. Dalla “dittatura dolce e felice” dei centri commerciali, della televisione, dei nuovi media è sparita la voglia di ribellarsi, l’essere umano declinato principalmente come consumatore non lotta e non desidera la rivoluzione, coltiva il suo edonismo senza vergognarsene, preferisce rapportarsi da essere disincarnato ad altri esseri virtuali, la cui sorte non lo tocca. “Ciò che contava era quello che si poteva fare con loro, la legge dello scambio, il piacere”.
Durante gli ultimi pranzi di festa, dopo il passaggio del secolo, superato in modo sorprendentemente indolore, con i figli ormai cresciuti e diventati a loro volta genitori, a tavola si parla di prestazioni di pc e altri apparecchi tecnologici, i bambini e gli adulti sono accomunati dagli stessi giochi e svaghi, gli adulti incagliati in un’imperitura adolescenza. La guerra delle prime pagine è completamente cancellata dai discorsi, le altre guerre invisibili non interessano a nessuno, la disoccupazione è lo stato delle cose, la povertà esibita a ogni angolo di strada una seccatura. “Si rispolveravano vecchi valori, l’ordine, il lavoro, l’identità nazionale, branditi come vessilli minacciosi contro nemici che si lasciava alle ‘persone per bene’ il compito di identificare, disoccupati, giovani dei quartieri popolari, immigrati clandestini, irregolari, ladri, stupratori eccetera.”
Un inventario, è stato detto di questo libro, ma anche una straziante testimonianza, dove lo strazio non è nelle parole, misurate e asciutte, ma nel non detto, nell’inesprimibile malinconia dovuta al fallimento di una generazione, di un’epoca, di un sogno. Viene da chiedersi se abbia ancora senso, a questo punto, una letteratura che non sia di puro intrattenimento, una scrittura impegnata, per usare un aggettivo decisamente fuori moda. Eppure il ruolo dell’intellettuale, altro termine velato ormai di un’aura di biasimo e ridicolo nella lingua vincente e senza memoria dell’era del consumo, dovrebbe essere fondamentale oggi più che mai. Quando è stato più urgente ritrovare, nel regno dell’irrealtà, in questo presente frantumato e inafferrabile, gli elementi in grado di rendere più chiara e leggibile la realtà anche a chi non possiede gli strumenti per comporre da sé un quadro completo, anche alla nutrita schiera degli orfani, per lo più inconsapevoli, della parola?
In questo senso, Gli anni è un testamento pubblico, di cui Annie Ernaux si fa estensore consapevole e accurato, un testimone da passare intatto a chi forse, un giorno, sarà pronto a raccoglierlo. Ma è, vale la pena di ricordarlo, anche un testo privato, intimo, che si legge d’un fiato, scritto con enorme padronanza dei meccanismi narrativi, ricco di immagini vividissime e rischiarato da un autentico e contagioso amore per la lingua, da una fede evidentemente ancora forte, malgrado le disillusioni, nel potere salvifico della parola. “Nella mescolanza dei concetti era sempre più difficile trovare una frase per sé, la frase che, pronunciata in silenzio, aiuta a vivere.”
Gli anni, Annie Ernaux, L’orma editore, 2015
(traduzione di Lorenzo Flabbi)