Prologo: Bologna, inverno del 1994 o 1995.
Qualche benemerito, non si sa quanto consciamente, organizza un concerto di Giora Feidman, l’ultimo dei grandi clarinettisti Klezmer della vecchia generazione, quella di Naftule Brandwein (e, perché no, Benny Goodman). Amici musicisti, ore prima, mi hanno introdotto a un sassofonista napoletano che ho ascoltato da poco e che mi intriga assai, di nome Daniele Sepe. Anche lui è con noi a vedere il grande Giora, che comincia la sua (quasi solitaria) performance nel silenzio più assoluto: lente salgono le note di una ninna-nanna struggente, note che sanno di casa, latte, fieno, dolcezze rurali di un qualche shtetl ucraino o bulgaro: adesso c’è come un’increspatura, qualche nota sospetta e – come dire – in tono sì ma un poco troppo colta… Tra le spalle mie e del mio amico un soffio: è Daniele Sepe che bisbiglia – dando risposta alla domanda che si stava affacciando: «…è la Prima sinfonia di Mahler, la riconosci?»
Straordinario Giora Feidman, per quello che stava facendo. Quasi allo stesso livello l’orecchio del ragazzo napoletano per averlo capito. Ne farà di strada, penso. Speriamo solo non si guasti.
Roma, Villa Giulia, estate del 1999.
Due ore e mezza filate di concerto tirate allo spasimo con un caldo umido bestiale e zanzare modello Apocalypse Now. Al termine, Daniele Sepe viene richiamato per due volte sul palco per i bis di turno. La terza volta c’è un descamisado, scalmanato e quasi afono sulla destra, proprio sotto il palco, che reclama a gran voce un brano. Si ode a stento il titolo ma a contare di più è la faccia del sassofonista, madida di sudore come il resto del corpo magretto, ma ancora reattiva. Sepe ha un attimo di indecisione e poi torna sul palco, scontornato da un occhio di bue azzurro cielo. Parte da solo mentre gli altri del gruppo si risistemano, innalzando ampie volute di una melopea di sapore vagamente balcanico. Il descamisado piange lanciandogli baci e urlando (per quel che può): grazie grazie sei meraviglioso. Tutto parrebbe annunciare una qualche improvvisazione collettiva ma, come fosse il fumo che esce dalla lampada di Aladino, ecco che da quella melopea si sviluppa inopinatamente, per arcane analogie, il caraibico tema di St. Thomas di Sonny Rollins. Stupefatio, incredulità, qualche imbarazzato risolino sospeso.
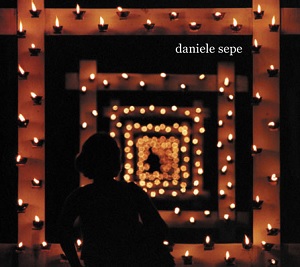
Note vigliaccamente arrotondate, e poi acciaccate, sbucciate, arricciate: l’ultimo respiro di un si bemolle viene reiterato una due quattro volte, diventa un quattro quarti fasullo sostenuto da basso batteria chitarra e improvvisamente – cuore trafitto tieni ancora un poco – ecco, deciso e perentorio, quasi un manifesto scampato al ’77, non già Luglio, agosto, settembre (nero) degli Area, bensì la sua anima macedone, cioè Yerakina, la storia della più carina e scassapalle del paese che finì per stufare financo l’acqua del pozzo, che sempre le ripeteva essere lei la più bella, e i villani, che ancor più stufi e, in accordo al comune sentire, nel medesimo pozzo la catafotterono. Amen.
Balla la gente di Villa Giulia, in preda all’ultimo inaspettato raptus collettivo. Balla il descamisado, le braccia aperte da derviscio rotolante il corpo di lucertola elettrica, il volto rapito in ineffabile comunione totale con ciò che accade. Io, in altrettanta beata estasi, sebbene più misurata, abbandono la mischia in anticipo, ancora incredulo. E sorge in me il ricordo di tutte le volte che anche a me, sì anche a me, è capitato di volare da una scala all’altra, di transitare leggero da un ignoto balcanico cinque quarti, trasportato dall’etere fino a casa mia dall’altra parte dell’Adriatico, a uno sciocco e ahimè premiato valzerino sanremese.
Non riesco a ringraziare Daniele Sepe per questa sua levità, che qualcuno chiama zappiana. Che volete, non ci riesco ancora oggi: confesso che ne sono allegramente invidioso, dato che vorrei essere capace di soffiare e volare esattamente come lui, di fiore in fiore di scala in scala a una velocità pazzesca, anche perché il pensier mio tavolta, lo ripeto, fa esattamente le stesse cose, ma non le sa suonare: la mente si muove così, cogliendo di volta in volta imbarazzanti più che insospettate derive o svolte da ciò che seriosamente si esegue, più che suonarlo. E non per questo si scandalizza, anzi.
Ebbe a dire una volta il grande Dizzy Gillespie, sull’etimologia della parola jazz, che jasi, in un dialetto africano, significa “vivere a un ritmo accelerato”. È possibile quindi che se c’è un punto di contatto tra il sottoscritto e Daniele Sepe, questo sia la felicità del non percepire la musica come un tutto unitario se non nell’eventuale risultato finale – ovviamente disattendendo ogni aspettativa di chi confidava nelle premesse. Sostiene infatti Sepe: «Francamente non riesco a capire perché uno che fa musica dovrebbe fare sempre la stessa musica. Io vorrei veramente tentare prima o poi di fare un disco un poco più unitario, a volte mi ci metto e dico, ok, questa è la volta che faccio un disco – come ti devo dire – che suoni più normale, ma dopo cinque minuti mi son rotto già le palle… non c’è niente da fare!»
Qualcuno recentemente diceva che se vai sempre veloce non riescono a fotografarti. Credo che a Sepe accada la stessa cosa. Va troppo veloce per la capacità di analisi di qualunque critico. Ci sono solo due possibilità: o lo si va a vedere dal vivo e ci si abbandona a tutto ciò che, sempre diverso, accade sul palco, o si ascolta e riascolta pazientemente ciò che egli ha (suo malgrado!) fissato e registrato su cd.
Questo Nia Maro non fa eccezione e conferma ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che Sepe è uno dei musicisti di cui dovremmo andare orgogliosi in questo disgraziato Paese di analfabeti musicali.
Dissezione del disco: dieci brani, nessuno uguale all’altro. Come potrebbe dire qualcuno a corto di aggettivi, una sorta di carnevale di diciotto musicisti, Sepe compreso, alle prese con ventisei strumenti diversi, dalla darbuka alla cupa-cupa bassa ai sassofoni. Ceffoni e carezze per tutti, come al solito. Ascoltate la Tammurriata iniziale e più ancora le tre tarantelle successive, tanto per farla finita con la pseudo-filologia di altri napoletani come Eugenio Bennato. Se c’è una tradizione, se ancora la musica popolare non conosce differenze tra chi la fa e chi l’ascolta, e chi la fa la evolve sempre, allora nessuna sorpresa se dai saltarelli più classici affiorano i temi di Brancaleone alle crociate e Pane, amore e gelosia. Nia Maro, mare nostro in esperanto, è un invito a muoversi ed esplorare, senza mai cristallizzarsi, e con una sana attitudine a non prendersi troppo sul serio.
Persino dove tutto farebbe pensare a un’ortodossia, come nella struggente e tradizionalissima Mi votu e mi rivotu (un lamento siciliano a suo tempo sulle labbra di Rosa Balistreri) c’è in sottofondo una birichina chitarra portoghese a spiazzare tutto. In Lamma Bada, una sensualissima musica di inizio secolo dell’egiziano Selim Al-Masry (testi mai fissi e sempre diversi), Sepe prova – senza riuscirci – a improvvisare sul sax come improvviserebbe un nordafricano e finisce per suonare con l’anima e il tono di Gato Barbieri, aggiungendo se possibile ancora più cuore al tutto.
In Sciuscià ci si domanda quanto fado abbia ascoltato il nostro per suonarlo alla napoletana (o viceversa?) e ogni tanto affiora – in finale di frase – un brandello di Chi tene ‘o mare di Pino Daniele (speriamo nessuno dei due s’arrabbi).
La vera apoteosi viene raggiunta ne La guerra dei mondi, dove non c’è solo la voce di Orson Welles alla BBC che beffa i terrorizzati sudditi di sua maestà, quanto piuttosto un ripensamento globale sul modo stesso di fare musica. Un ripensamento che mostra di avere in pieno assimilato la lezione del Miles Davis di Bitches Brew, riletta alla maniera dei Napoli Centrale di James Senese e soci (anni ’70) coi suoni zawinuliani del Fender Rhodes e quelli shorteriani del sax (ah, dimenticavo, anche nella Tammurriata iniziale c’è qualcosa di simile).
Più ancora, c’è un piccolo e strafottente gioiello del compianto George Brassens, Les Amoreux des bancs publics, a marcare indelebilmente questo lavoro. Già testo e melodie originali ci raccontano un modo di vivere la vita tenendo caro ciò che più conta, l’amore in questo caso, senza curarsi delle contingenze di tempo e luogo, come le panchine pubbliche. Sepe prende l’attitudine brassensiana alla lettera: fin dall’introduzione echeggia spudoratamente i timbri di John Surman, e infila dentro, già al primo refrain, tutto il tema della Jazz Suite n. 2 di Shostakovich – con tanti ringraziamenti a Kubrick – per contraddirlo, non appena riprende la melodia, con un paio di perepè da festa di Fuorigrotta e intermezzi altrettanto sghembi. È da un pezzo che sostengo che quel tema ha un’aria tutt’altro che russa – salvo nella conclusione – e sa piuttosto di storie siciliane di mafia e cuori traditi. Ma il capolavoro si rivela alla quarta strofa, quando dallo stesso tema sinfonico di Shostakovich ne escono due note di sospensione (vedo la faccia di Sepe che si illumina, così come la vidi a Roma) e fuoriesce quasi timido il Tema di Lara da Il dottor Zivago – e così è servito anche Maurice Jarre.
Coerente come sempre, da quattordici anni Sepe infila un album dietro l’altro senza mai dimenticare né origini né presente. Da questo punto di vista, una citazione tratta dal sito del musicista (www.danielesepe.com) ci dà l’ultima soddisfazione: «Nia Maro, mare nostro, vol di’ che non è solo di D’Alema e la su’ barca, o di Previti e la su’ barca, ma soprattutto di quelli in gommone e di me in canoa… Forza Livorno!»
Daniele Sepe, Nia Maro, Manifesto, 2004

