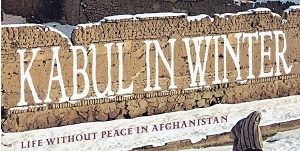Isabella Vaj
Afghanistan e Ong: la bella vita delle Organizzazioni non governative e le misere storie di vita quotidiana degli afghani per strada, in prigione e a scuola, in un Paese martoriato dai conflitti e nelle mani del vecchio potere dei Signori della guerra
Kabul in Winter. Life without Peace in Afghanistan è un libro che dice cose dure. Ann Jones, saggista newyorkese, collaboratrice del New York Times e di The Nation, in tre lunghi capitoli – Per strada, In prigione, A scuola – racconta storie di vita quotidiana nella Kabul dell’occupazione americana, fornendo dati cui dispiace credere, e spiega perché la guerra che l’Occidente sta combattendo in Afghanistan è destinata alla sconfitta. In questo libro – non tradotto in Italia – non si salva (quasi) nessuno.
L’autrice pone in esergo una citazione di Tacito: “Agricola era consapevole dell’indole dei provinciali, e faceva tesoro della lezione trasmessa dall’esperienza degli altri, che poco si otteneva se alla forza faceva seguito l’ingiustizia. Decise perciò di eliminare le cause della guerra. Iniziò da se stesso e dai suoi: mise in ordine la propria casa”. Gli Stati Uniti vogliono applicare il loro ordine al mondo, ma è la loro casa che necessita di essere messa in ordine, suggerisce l’autrice. A differenza di Agricola, però, gli americani non sembrano aver appreso la lezione dei trent’anni di guerra e di ingiustizia che hanno ridotto alla sfiducia in una possibile pace la grande maggioranza degli afghani. La Jones è americana, e fa i conti in casa propria. Occorre però ricordare che in Afghanistan non ci sono solo truppe, Ong e imprese statunitensi. Il saggio indaga le ragioni storiche e culturali che hanno impedito al territorio afghano di diventare uno Stato nazione e agli afghani di sentirsi un popolo, e riporta interessanti informazioni raramente presenti sulla stampa italiana.
Per strada
Ann Jones nel 2002 decide di partire per l’Afghanistan. È la sua risposta all’11 settembre, il suo contributo alla ricostruzione di quel Paese. Lavora come volontaria per Madar (Madre), un’organizzazione umanitaria fondata da un’americana per aiutare le vedove di Kabul, 40.000 nel 1994 dopo la guerra civile tra mujahidin, 98.000 in tutto il Paese all’apice del potere talebano. Kabul ha oltre due milioni di abitanti. L’inquinamento atmosferico è tale che d’inverno la città appare sempre avvolta in un’atmosfera grigia, sporca e polverosa. Gli autisti mettono in pratica una creatività di guida al cui confronto i napoletani dimostrano un’ubbidienza svizzera alle regole del traffico. Tre semafori in tutta la città, che nessuno prende sul serio e che spesso non funzionano per mancanza di elettricità. Ma a chi appartengono gli automezzi che intasano le strade?
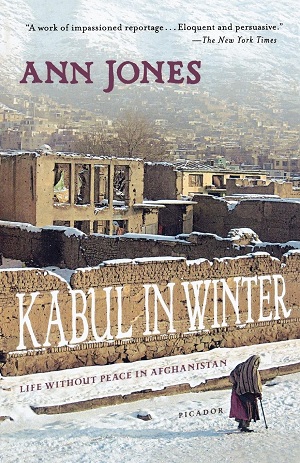
Nel 2002, dopo la (effimera) cacciata dei talebani, a Kabul avevano sede ottocento organizzazioni non governative: duecento internazionali, circa seicento afghane finanziate dalle Nazioni Unite o da governi stranieri. I direttori dei progetti, gli esperti, i tecnici e i consulenti costituiscono il popolo degli international. La presenza di migliaia di operatori delle Ong ha avuto un risvolto drammatico sulle condizioni della popolazione della capitale. Con i loro uffici e le loro abitazioni gli stranieri occupano le grandi case un tempo appartenute alla borghesia medio-alta di Kabul, nei quartieri residenziali di Share Nau (Città Nuova) e di Wazir Akbar Khan. Sono disposti a pagare affitti inauditi per assicurarsi condizioni di vita ‘occidentali’, con il risultato che i padroni di casa sfrattano i tradizionali inquilini afghani per i quali inizia una progressiva discesa lungo lo scivolo dell’edilizia abitativa. I più sfortunati finiscono nelle periferie tuttora distrutte se non addirittura sui marciapiedi assieme ai senzatetto. Impiegati dei ministeri o insegnanti sono spinti sempre più lontano dal posto di lavoro e costretti a ricorrere agli inaffidabili bus per raggiungere uffici e scuole. Il viaggio si fa più lungo man mano che la ricerca di una nuova casa li spinge sempre più lontano dal centro. È solo una questione di tempo: prima o poi abbandonano scuole, università e ministeri per trovare lavoro, magari come autisti, fattorini o traduttori, presso le Ong che pagano stipendi inimmaginabili, per gli standard afghani: un autista analfabeta guadagna più di un professore dell’università di Kabul.
Le agenzie internazionali usano automezzi propri, con relativi autisti assunti a tempo pieno: come possono gli operatori essere sicuri che un taxi sia veramente un taxi e non una macchina di sequestratori o di kamikaze? Ogni giorno migliaia di veicoli scendono nelle strade della capitale già pullulanti di biciclette, carri trainati da cavalli, carretti di frutta e verdura spinti a mano tra una folla di pedoni: cambia-valute, imbonitori di vario tipo, venditori di carte telefoniche, accattoni, donne mendicanti, ciechi, mutilati, ragazzini che vendono giornali o che, in cambio di una piccola mancia, affumicano i passanti con l’assafetida per tenere lontano la cattiva sorte. Agli incroci i pedoni invadono la sede stradale fermando gli automezzi che fanno del paesaggio sonoro della città un delirio di clacson. Le strade sono piene di buche, di mucchidi spazzatura e di macerie, scivolose dopo una nevicata; e terribilmente insicure, nonostante siano pattugliate da soldati afghani, soldati americani, soldati tedeschi, inglesi, olandesi e turchi della forza di sicurezza internazionale, riconoscibili dalle uniformi. Ma per le strade ci sono anche soldati in uniformi non identificabili: sono le milizie private dei signori della guerra che siedono nel governo Karzai.
Alle donne delle Ong non è permesso guidare, ma nessuno può impedire loro di assumere aitanti autisti. Gli uomini afghani hanno fama di essere “fieri, implacabili, spietati, selvaggi, traditori, in una parola: irresistibili”. Ann Jones racconta di una propria connazionale ossessionata dal suo bell’autista, sposato. Nel bilancio del progetto inserisce una voce di spesa esorbitante per automobile e autista, e quando riceve il denaro si compera l’uomo dei suoi sogni.
In prigione
Se c’è un aspetto che sembra immodificabile della società afghana è il rapporto uomo-donna. In questa società patriarcale le donne, sin dalla nascita, imparano a ubbidire agli uomini e a pensare che il maschio, solo in nome del genere, valga più della donna. Anzi, la donna ha valore unicamente come merce da vendere o da scambiare. Ann Jones riferisce che ancora nel 2005, a un convegno organizzato dal ministero della Giustizia afghano, studiosi coranici si sono posti il quesito, senza arrivare a una conclusione definitiva, se le principali religioni considerino la donna un essere pienamente umano e se perciò essa abbia il diritto di aspirare ai diritti umani. L’autrice scopre che questo giudizio di inferiorità ‘naturale’ è talmente interiorizzato che molte donne, anche istruite, non comprendono il concetto stesso di ‘diritto’. Anche il verbo ‘scegliere’ pone molte difficoltà di comprensione.
Il rifiuto della donna di ubbidire è vissuto dai maschi come un inaccettabile attacco all’ordine costituito, incompatibile con la morale della società e come tale meritevole di punizione. Il carcere femminile storico si trova nella Welayat, non lontano dal centro di Kabul.
La Jones visita la prigione nel 2003, come volontaria della Ong tedesca Frauen Die Helfen. Un salto nel Medioevo: un edificio fatiscente, niente riscaldamento, niente infermeria, niente elettricità, un buco lurido come toilette, guardie pagate venti dollari al mese, ma non tutti i mesi, e che per necessità si industriano a rubare quanto possono. Le carcerate appaiono alla Jones accovacciate sul pavimento umido e sporco come mucchi di stracci.
Le loro storie sono molto simili: vendute giovanissime al marito scelto dalla famiglia, che ha due, tre e persino quattro volte la loro età, sono violentate, picchiate, spesso costrette a prostituirsi. Alcune hanno provato a ribellarsi fuggendo, oppure tentando il suicidio con il veleno o con il fuoco. Le statistiche, per quello che possono valere in un Paese dove tutto è fluido, incerto, dicono che il 95 per cento delle donne ha subito violenza. Ma la loro vita è segnata, prima ancora che vengano stuprate, da una mancanza d’amore e di rispetto da parte dei genitori: questo ha detto Serena, una detenuta che ha attraversato l’esperienza della prostituzione. La nascita di una femmina è infatti vissuta come una disgrazia. Ann Jones riferisce le parole di un marito la cui moglie ha appena partorito una bambina: «Se mi fai ancora una cosa simile ti ammazzo».
La donna che ha il coraggio di denunciare alla polizia la violenza subita, in genere non è creduta, anzi, è ritenuta colpevole e incarcerata, per quello che da noi un tempo era chiamato ‘abbandono del tetto coniugale’. Se la donna denuncia di essere stata violentata, è accusata di zina, adulterio, sesso fuori dal matrimonio e perciò incarcerata. L’infrazione del codice d’onore della tribù, del clan, della famiglia, rende la reproba una ‘donna cattiva’ e il fatto che essa finisca in prigione lo dimostra. Di questo sono convinte anche le afghane alfabetizzate che lavorano con la Jones. Molto spesso l’accusa di zina è punita in famiglia: il padre o i fratelli uccidono la donna. Tale omicidio non è considerato un delitto: è un diritto dei maschi della famiglia ristabilire il proprio onore.
Il sistema giudiziario afghano è un marasma: esiste la Costituzione del 2004 che riconosce formalmente i diritti dell’uomo, ed esistono i codici, ma i giudici spesso li ignorano e condannano sulla base della loro interpretazione della sciaria, la legge coranica, o del diritto consuetudinario non scritto. La donna, abituata a non esercitare la propria volontà, a essere proprietà di un maschio, spesso non si capacita neppure dell’accusa. Persino l’avvocato difensore (anche se donna) ritiene legittimo costringere una ragazza a sposare l’uomo scelto per lei dalla famiglia, e lecito da parte del marito violentare e picchiare la moglie, perché queste sono pratiche tradizionali.
Il sistema giudiziario del governo centrale non ha alcuna autorità in gran parte del Paese, dove non esistono tribunali (né carceri) e dove sono la famiglia e i potenti locali, khan o mullah che siano, ad amministrare la giustizia. Persino a Kabul le cause contro le donne sono perlopiù risolte attraverso un accordo tra la famiglia dell’imputata e quella dell’accusatore, che accetta un compenso in denaro, o in animali. Non di rado il risarcimento avviene tramite giovani donne, spesso sotto i dieci anni, tenute a offrire servizi domestici e sessuali nella famiglia del maschio offeso. Questa consuetudine, benché formalmente condannata dal Codice penale, trova ampia applicazione, soprattutto nelle province.
In Afghanistan la giustizia è una lotteria “in genere in vendita almiglior offerente”. Tutti sanno che la maggior parte dei giudici è avida e che il loro tornaconto personale precede l’applicazione della legge. La corruzione è la sola norma puntualmente applicata. Se la corruzione non funziona non si esita a ricorrere alle minacce e alla violenza. Ann Jones presenta un quadro inquietante sull’operato delle Ong. Raramente gli operatori umanitari tengono conto delle esigenze reali dei destinatari dei loro progetti. Spesso il loro intervento si risolve in un grande spreco di denaro e lascia immutata la condizione dei beneficiari. L’esempio della Welayat è istruttivo. Una Ong internazionale aveva realizzato un corso di cucito di due mesi, dopo aver dotato il carcere di venti macchine per cucire cinesi. Le donne avrebbero voluto confezionare abiti sia per i loro bambini sia da poter vendere, ma le operatrici umanitarie avevano portato stoffa solo per fare vestitini per le bambole. Le detenute, che non avevano bambole, ben presto disertarono le lezioni di cucito. Il personale della Ong le giudicò delle ingrate prive d’iniziativa.
Nell’ambito della formazione di avvocati difensori promossa da una Ong internazionale, la Jones assiste a un’accesa discussione tra esperti di diritto. “Mi misi le mani nei capelli, pregando che nessun italiano intervenisse nella discussione. Gli italiani […] erano stati scelti per ricostruire il sistema giudiziario afghano. Gli italiani! (corsivo dell’autrice, n.d.a.) Molti funzionari delle Nazioni Unite e delle Ong internazionali ritengono che sarebbe opportuno affiancare qualcuno agli italiani. In privato fanno battute sul fatto che la giurisprudenza italiana è perfetta per il futuro stato afghano, dominato come sarà dalla mafia del narco-traffico”. Questa la fama che ci siamo guadagnati nel mondo, con lo sprezzo della giustizia esibito dal nostro governo (e dal Parlamento) in questi anni. Ma gli italiani, per fortuna, non sono solo questo: in Afghanistan lavora anche Emergency – e l’ospedale di Lashkar-gah ha riaperto il 29 luglio scorso con le scuse ufficiali del governo afghano, che ha riconosciuto la totale innocenza dei tre operatori volontari arrestati in aprile.
Come la costruzione di autostrade crea maggior traffico, così la creazione di nuove prigioni crea un maggior numero di donne che delinquono. In anni recenti il famigerato carcere di Pul-i Charkhi, costruito dal presidente Daud, fondatore della Repubblica afghana nel 1973, è stato aperto anche alle donne. Soprattutto prostitute. Nel 2005 si è calcolato che nei bordelli di Kabul lavorassero circa seimila donne (anche cinesi e filippine). E i bordelli sono frequentati esclusivamente da stranieri, soprattutto americani.
Così le Nazioni unite hanno devoluto 300.000 dollari per costruire un nuovo carcere femminile, mentre mancano case, scuole, ospedali e strutture che ospitino donne sole e bambini di strada, si indigna Ann Jones. Ma, precisa con amarezza, un nuovo carcere in cemento avrebbe dato agli operatori umanitari l’impressione di star davvero ricostruendo l’Afghanistan e soprattutto di contribuire a preservare la moralità della società. La cosa disperante per la Jones è che persino le carcerate sono d’accordo sulla necessità di tenere alto il livello morale della società. Il livello fissato dagli uomini.
A scuola
Secondo la Costituzione afghana del 1931, l’istruzione primaria è obbligatoria e gratuita. Ma in mancanza di edifici scolastici, di insegnanti preparati e di libri di testo adeguati (sono in uso ancora i testi ispirati ai mujahidin e ai talebani delle madrasa forniti dagli Stati Uniti nei decenni scorsi) la macchina scolastica non può funzionare. Nel 2002 l’Onu parlava del sistema scolastico afghano come “del peggiore al mondo”. In Afghanistan oltre il 90 per cento della popolazione è analfabeta. “L’insegnamento è una professione ottimistica che presuppone un futuro” scrive Ann Jones. Dal 2002 al 2005 l’autrice insegna inglese agli insegnanti d’inglese afghani, la cui conoscenza della lingua è molto meno che elementare. Il primo anno non ha fortuna: gli insegnanti non seguono il corso, perché con 40 dollari al mese di stipendio, preferiscono dedicarsi a un doppio lavoro invece di migliorare la propria professionalità. Ma negli anni successivi, ottenuti maggiori fondi, con grandissimi sforzi e frustrazioni iniziali le cose vanno meglio.
L’autrice impara a proprie spese come essere una ‘vera’ operatrice umanitaria, impara il linguaggio delle Ong (che mostra un evidente scollamento tra parole e cose), rinuncia ad avere collaboratori volontari e, per essere credibile, presenta ai ‘donatori’ budget gonfiati. Tuttavia la sua idea di promuovererisultati piccoli, ma sicuri – educare gli educatori perché imparino a educare – è respinta in nome di un progetto di alfabetizzazione a livello nazionale. Impara che gli aiuti umanitari rispondono alle contingenti esigenze politiche dei governi paganti, non ai bisogni reali degli afghani. Per gli Stati Uniti “lo scopo degli aiuti umanitari è rendere il mondo sicuro e aperto al mercato americano”. Due obiettivi che non sembrano poter percorrere le stesse strade.
La Jones indaga il modus operandi dei Paesi donatori nella ricostruzione e scopre come la stragrande maggioranza degli aiuti ritorni, attraverso vie non sempre trasparenti, agli imprenditori stranieri che si sono fatti garanti dei progetti presso il governo donatore. Un solo esempio: nonostante una compagnia internazionale si fosse candidata a ricostruire la superstrada Kabul-Kandahar per 250.000 dollari al chilometro, l’appalto venne affidato a un gruppo statunitense che aveva preventivato un costo di 700.000 dollari al chilometro. A distanza di qualche anno dalla sua costruzione, la strada sta già andando a pezzi. La voce ‘manutenzione’ non è mai stata prevista.
Anche per quanto riguarda le scuole i fondi fanno giri tortuosi. I programmi di alfabetizzazione in parte finanziati dagli USA “sono organizzati da direttori internazionali, che coordinano consulenti internazionali che formano e coordinano formatori afghani ad alto livello che formano e coordinano formatori afghani di medio livello che formano e coordinano formatori sul campo che formano e coordinano insegnanti afghani che si stanno formando per insegnare alfabetizzazione a ragazze, donne, ragazzi e uomini afghani analfabeti in diversi luoghi sparsi nelle province”. La Jones scopre che per ‘province’ si intende il territorio poco oltre la periferia di Kabul. Non solo. Imparare a scrivere e a leggere richiede almeno due anni, ma spesso i corsi durano pochi mesi, lasciando deluse soprattutto le afghane: avrebbero voluto arrivare a leggere il Corano per verificare cosa effettivamente ha detto il Profeta sulle donne.
I fondi sono distribuiti a cascata, ma nella caduta solo il 20-30 per cento, nell’ipotesi più ottimistica, finisce agli afghani; il resto ritorna in tasche americane. Quasi nessuno di questi programmi è portato a termine, né segue una valutazione rigorosa dei risultati. La conseguenza è che gli afghani coinvolti nei progetti perdono la faccia di fronte ai loro connazionali. Lo stesso vale per l’1,3 miliardi di dollari che gli USA hanno speso nella ricostruzione dell’Afghanistan, una cifra in gran parte mai arrivata a destinazione.
Gli operatori che fanno il proprio lavoro con abnegazione, inorridiscono di fronte agli sprechi, alle risorse fantasma, ai progetti confusi e inefficienti. Se nel 2002 gli stranieri erano stati accolti a braccia aperte, nel giro di tre anni gli afghani hanno radicalmente cambiato atteggiamento. All’ottimismo si sono sostituiti frustrazione, cinismo e rabbia di fronte alla persistente povertà e alla totale mancanza di sicurezza. Si è fatta persino strada una vaga nostalgia per il regime sovietico.
La realtà è sempre più complessa di come la si possa descrivere, partendo da uno specifico punto di vista. Il quadro pessimistico descritto da Ann Jones in Kabul in Winter è inevitabilmente parziale, e risale al 2006. Tuttavia ho avuto occasione di verificare che, come l’autrice sostiene, gli aiuti umanitari aiutano soprattutto coloro che se ne fanno portatori. Il 4 e 5 giugno scorsi si è svolto ad Aosta il convegno internazionale “Restituire la memoria. Modi e forme dei linguaggi museali”; il titolo dell’intervento “La memoria dell’Afghanistan tra passato e presente”, nonostante l’estrema vaghezza, mi ha spinto a presenziare. Su uno sfondo di immagini di repertorio, la voce dei due relatori ha accennato a un progetto urbanistico per Herat. Parole ne sono state dette tante, ma non una è stata spesa sulla natura e sui contenuti del progetto, su chi lo finanzia e come, su quali obiettivi e quale tempistica si pone, su chi lo realizza e con quali metodologie e soprattutto su quale ruolo vi svolgono gli afghani. Nessun intervento occidentale, politico o militare, potrà avere successo e modificare sostanzialmente la realtà afghana se ignorerà la questione culturale, se non presterà ascolto agli afghani stessi.
Kabul in Winter si chiude con una sorta di apologo. Ann Jones partecipa alla presentazione di abiti d’alta moda confezionati dalle vedove afghane di CARE, una Ong internazionale. Nel giardino dove si svolge la sfilata, alcuni americani insistono perché il cantante afghano ingaggiato per la serata canti per loro. Ma il cantante rifiuta. «Gli afghani non cantano in giardino» dice.
Kabul in Winter. Life without Peace in Afghanistan, Ann Jones
Metropolitan Books, New York, 2006