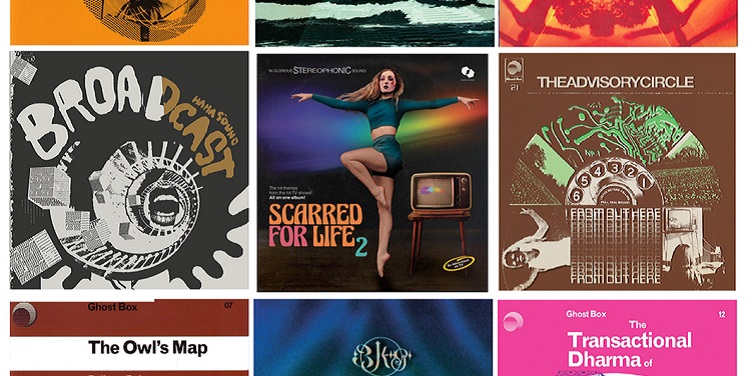Mark Fisher, il capitalismo, l’hauntologia e gli universi musicali paralleli che resistono
Ci sono tre autori decisamente cupi e in qualche modo veritieri che mi sono tornati per le mani ultimamente. Jameson e Žižek hanno commentato il libro del filosofo Mark Fisher Capitalist Realism: Is There No Alternative? (2009, Zero Books). I due hanno ampiamente ragione quando descrivono la vittoria del capitalismo come “la fine del futuro”. Una volta morte tutte le ideologie è facile per il capitalismo presentarsi come l’unica realtà ontologica possibile, neutrale e in qualche modo razionale. Le nuove generazioni, cresciute senza ideologia, si trovano di fronte a un dato di fatto che nessuno ha voglia di contestare. Il mondo è così perché è così, non si discute né si immagina qualcosa di diverso. Berlusconi è stato la prova generale di Trump. Non è solo il partito che viene gestito come un’azienda. È tutto l’orizzonte politico dello Stato che viene gestito come tale. Il mondo diventa una sorta di ontologia aziendale, in cui il ben apparire è il parametro della relazione umana e il numero di merci acquistabili e acquistate determina l’essere valutati come buoni cittadini in quanto buoni consumatori. Giustamente, da insegnante, Fisher ha il polso della situazione quando guarda i suoi allievi: “Gli studenti britannici oggi sembrano essere disimpegnati politicamente […] Ma questo, voglio argomentare, non è apatia, né cinismo, ma impotenza riflessiva. Sanno che le cose vanno male, ma più di questo, sanno che non possono fare nulla al riguardo. Ma quella ‘conoscenza’, quella riflessività, non è un’osservazione passiva di uno stato di cose già esistente. È una profezia che si autoavvera”. L’impotenza riflessiva descrive un fenomeno in cui le persone riconoscono la natura difettosa di un sistema come il capitalismo o il sistema educativo, ma credono che non ci siano mezzi per apportare cambiamenti; è un imperativo del realismo capitalista, il senso che non ci sia alternativa.
Fisher aggiunge che questa condizione di impotenza riflessiva “costituisce una visione del mondo non dichiarata tra i giovani britannici e ha la sua correlazione in patologie diffuse” che includono depressione, ansia o altri problemi di salute mentale. Il filosofo si concentra specificamente, tuttavia, su quella che ritiene essere una depressione edonistica, nella quale la costante distrazione e stimolazione (TV, PlayStation e marijuana) sono l’unica soluzione alla disperazione. E questo non riguarda solo gli studenti. Anche gli adulti trovano conforto nel consumismo o nella micro-stimolazione dei loro telefoni quando avvertono questo senso di disperata depressione, un desiderio per un’alternativa che non può essere immaginata.
La sinistra cerca di fare progressi. Il neoliberismo ci ha privato della possibilità di immaginare un futuro oltre il capitalismo, un’alternativa allo stato attuale delle cose. Sembra che il TINA di Margaret Thatcher (“There is no alternative”) abbia avuto un impatto molto maggiore di quanto si potesse pensare. Ovviamente avevano ragione i Sex Pistols nel 1977 cantando There’s no Future and England’s Dreaming, ma la cosa stupefacente è che tutto questo avveniva più di un decennio prima prima della caduta del Muro e della fine del cosiddetto comunismo reale. Profeti (involontari) in patria?
In Italia abbiamo avuto solo nel 1986 i CCCP con Io sto bene, che rappresentava un’intera generazione stesa a terra, annichilita, oppressa da una pura formalità: Non studio, non lavoro, non guardo la TV, non vado al cinema, non faccio sport […] È una questione di qualità, O una formalità, Non ricordo più bene, una formalità, come decidere di radersi i capelli, di eliminare il caffè e le sigarette, di farla finita con qualcuno o qualcosa, una formalità, una formalità, una formalità, o una questione di qualità o una formalità, non ricordo più bene, una formalità. Pochi anni dopo (1994) sarebbe arrivato il romanzo Tutti giù per terra di Giuseppe Culicchia e il film omonimo nel 1997, a ribadire gli stessi concetti.
Bifo ha approfondito il concetto parlando di cancellazione lenta del futuro. Fisher sostiene che essere nel XXI secolo significa avere la cultura del XX secolo su schermi ad alta risoluzione e distribuita tramite internet ad alta velocità. Ci troviamo in una sorta di malessere culturale in cui tutto sembra provenire da ere passate, ma nessuno se ne accorge. Più che altro direi che è progressivamente venuto meno l’insegnamento del senso della storia: prima di tutto a scuola; secondariamente, nei media. Ma dietro la cancellazione di questo insegnamento sta ancora una volta la cancellazione della curiosità, poiché tutto viene presentato come un dato di fatto che è inutile discutere. Infatti chi si chiede quali meccanismi abbiano portato a un certo risultato viene inevitabilmente etichettato come boomer, come vecchio e obsoleto. A me sembra evidente che chi rinuncia a chiedersi il perché le cose siano come sono non ha più nessuno strumento nei confronti del Potere.
Passiamo adesso alla musica. Fisher sostiene che nel Regno Unito, “lo stato sociale del dopoguerra e le borse di studio per l’istruzione superiore costituivano una fonte indiretta di finanziamento per la maggior parte degli esperimenti nella cultura popolare tra gli anni ‘60 e gli anni ‘80. L’attacco ideologico e pratico ai servizi pubblici ha significato che uno degli spazi in cui gli artisti potevano essere riparati dalle pressioni di produrre qualcosa di immediatamente di successo è stato drasticamente circoscritto. Con la mercificazione della radiodiffusione di servizio pubblico, c’è stata una tendenza crescente a produrre opere culturali che assomigliassero a ciò che era già di successo”.
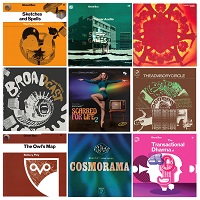
Noto che la stessa cosa accade anche oggi nell’industria libraria: gli autori di fiction vengono accreditati dagli agenti letterari nei confronti degli editori solo se il loro gradimento sui social è già consolidato oltre i 100.000 like. In altri termini questo significa che un autore deve svolgere da solo, a proprio rischio e a proprie spese, tutta la parte del marketing una volta di competenza dell’editore. Da una parte si elimina una grossa fetta di rischio industriale. Dall’altra si premia l’autore che è già considerato di successo ma, si noti bene, indipendentemente dal valore intrinseco dell’opera. Se hai 100.000 like di patrimonio, l’unica cosa che deve fare un editore è vendere una success story, anche se scrivi da schifo e le cose che scrivi non hanno senso. L’autore è la startup di se stesso. Le uniche iniziative editoriali che sfuggono a questo meccanismo sono finanziate dalle università o dai grossi centri di ricerca: esse si possono anche permettere di produrre in perdita, perché il contributo delle pubblicazioni non si misura nei termini delle copie vendute quanto nel prestigio dell’istituzione o – nel caso delle pubblicazioni scientifiche – nell’appartenere al reparto Ricerca e Sviluppo, che è già parte di un complesso produttivo. Noto di sfuggita che in Italia il settore R&S è considerato costantemente come una cenerentola aziendale, ed è possibilmente per questo che i nostri cervelli migliori fuggono all’estero dove contribuiscono sostanzialmente al progresso di istituti o di aziende all’avanguardia.
Per tornare alla musica, ma anche al cinema, devo osservare che la tendenza al revival non è qualcosa di nuovo. Nel cinema Hollywood è da sempre piuttosto asfittica nel produrre soggetti e sceneggiature nuove, radicalmente diverse: le storie sono sempre più e sempre più frequentemente rimasticature di storie già raccontate. Cambia solo la veste tecnologica in cui la storia viene presentata oppure il Paese di ambientazione. Alcuni esempi rapidi.
Absolute beginners di Julien Temple (1986) è nostalgia pura degli anni pre-boom dato che l’azione si svolge nel 1958, nel momento in cui la cultura pop a Londra si trasforma passando da quella jazz degli anni ‘50 a quella rock’n roll degli anni ‘60. Qui il revival è intrinseco alla narrazione.
Abbiamo poi il remake vero e proprio di cui campione indiscusso è un film italiano Perfetti sconosciuti (2015) di Paolo Genovese. Primo remake nel 2016, a firma di Thodoris Atheridis, cui è seguita la versione spagnola (Perfectos Desconoscidos), turca (Cebimdeki Yabanci, con produzione targata Ferzan Özpetek), indiana (Loundspeaker), francese (Le Jeu) e via di seguito. In cantiere ben altri otto riadattamenti, tra cui quello statunitense con il premio Oscar Charlize Theron. Qui il paradosso è che il remake avviene con frequenza pressoché annuale. A Hollywood la media era attorno ai trentacinque/quarant’anni (The big clock è del 1948, No way out del 1987; Scarface è del 1932 e il remake omonimo del 1983). Non che a Bollywood se la passino meglio, ma almeno lì si può argomentare che abbassandosi le maglie della censura è possibile portare sullo schermo soggetti e situazioni prima proibite, per cui abbondano le riproposizioni indiane di film americani.
L’entrata in scena di Derrida col libro Spettri di Marx complica le cose, perché questi si inventa (non c’è altra spiegazione) la categoria concettuale di hauntologia, traducibile grosso modo con fantasmologia o spettrologia. In buona sostanza ci sono due zone, subito prima e subito dopo un fatto, che sono piene rispettivamente dell’assenza di ciò che non c’è più e dell’assenza di ciò che deve ancora venire.
La prima assenza si riferisce a ciò che non è più, ma che rimane efficace come virtualità: Fisher lo individua nell’impulso a ripetere. Io posso condividere l’esistenza di questa categoria dicendo che in fondo si tratta di un trauma emozionale: l’emozione è così forte da stamparsi nella mente della persona irrigidendo i processi cognitivi e riflessivi. Tanto è vero che il comportamento coattivamente appreso o la memoria dolorosa, che paralizza ogni azione quando si manifesta, non hanno contenuto valoriale; sono fatti puri e semplici, sganciati da ogni ideologia o anche da ogni semplice scelta etica. In genere in sede terapeutica si tende a far riacquisire alla persona la fiducia in se stessa e nella propria capacità di autodeterminarsi diversamente.
La seconda assenza si riferisce a ciò che (in realtà) non è ancora accaduto, ma che è già efficace nel virtuale. È come dire che la stessa aspettativa di un fenomeno ancora al di là dal venire genera un comportamento attuale che ha effetti. Fisher scrive: “Lo ‘spettro del comunismo’ di cui Marx ed Engels avevano avvertito nelle prime righe del Manifesto comunista era proprio questo tipo di fantasma: una virtualità il cui imminente arrivo giocava già un ruolo nel minare lo stato attuale delle cose”. Ma, nel mondo del realismo capitalista o della fine della storia, ciò che ci tormenta non è tanto la ‘minaccia comunista’ esistente o la cultura modernista popolare, quanto “la scomparsa di queste cose e dei migliori futuri che promettevano e che non si sono mai materializzati”.
Ora, tutto questo discorso ha un immediato riflesso politico. Ma prima ancora ha un riflesso esistenziale: se io decido di farla finita con le mie scelte del passato e ho chiaro cosa voglio fare nel futuro, l’unica cosa che mi consente di vivere bene è agire nel presente con una ferrea determinazione, zero nostalgia del passato e zero proiezione nel futuro. Il potere del qui e ora è grande tanto quanto la mia decisione di chiudere una porta e di aprire un portone.
Fisher fa un ottimo esempio quando parla dell’intensa tristezza di divi dell’Hip Hop come Drake e Kanye West, “entrambi morbosamente fissati nell’esplorare l’assoluta vuotezza miserabile al cuore dell’edonismo super-affluente. Non più motivati dal desiderio dell’hip-hop di consumare in modo appariscente – hanno acquisito da tempo tutto ciò che avrebbero potuto desiderare – Drake e West invece ciclicamente si abbandonano ai piaceri facilmente accessibili, provando una combinazione di frustrazione, rabbia e disgusto verso se stessi, consapevoli che manca qualcosa, ma incerti su cosa esattamente sia”. Questa tristezza edonista – una tristezza diffusa quanto negata – è stata rappresentata in modo magistrale nel modo malinconico con cui Drake canta “abbiamo fatto una festa / sì, abbiamo fatto una festa” in Marvin’s Room di Take Care.“Le origini hip-hop del ventesimo secolo erano inerentemente rivoluzionarie poiché desideravano collettivamente futuri migliori e talvolta erano persino forme di protesta, ma il genere è lentamente stato spogliato del suo potenziale ed è diventato solo consumismo”. Mr. Fisher, e se il potenziale di cui lei parla non fosse mai esistito? Io ci vado sempre molto cauto quando qualcuno usa il termine ‘intrinseco’ – l’esperienza mi insegna che c’è nulla di più transiente delle cose definite ‘intrinseche’ –, oppure vogliamo censire i testi hip-hop per capire quanti hanno almeno una carica rivoluzionaria che vada al di là della semplice negazione del presente? Mi sa che Fisher avrà qualche delusione.
In queste canzoni c’è ovviamente il lutto per il passato, ma c’è anche una dimensione malinconica, un rifiuto di adattarsi alla realtà del nostro presente, un rifiuto a cedere. In Marvin’s Room, in particolare, c’è un desiderio per qualcosa di meglio del consumismo edonista, delle bevande e del sesso. La canzone sembra essere un grido per qualcosa di ‘migliore’ ma irraggiungibile, un desiderio per la possibilità di piacere al di là del consumismo edonista, o per un ‘migliore’ futuro perduto.
Non ci siamo. La trappola del consumismo scatta non a caso proprio quando questi artisti di colore vengono messi in grado di acquisire ciò che vogliono, confondendo ancora una volta la felicità con la quantità dei beni di consumo a disposizione. I tempi in cui l’ideologia rivoluzionaria veniva fatta propria sia dai politici di colore che dagli artisti, erano anche i tempi in cui non si discuteva affatto dell’abolizione del consumismo e del capitalismo e della loro sostituzione con modelli alternativi. Protestare contro la mancanza di visibilità dei soggetti afroamericani o asiatici, lottare per far diventare normale la presenza di un’artista di colore all’interno di una narrazione, è stato ed è ancora adesso estremamente importante. Ma allora come ora manca un progetto radicalmente alternativo a quello capitalistico. Non parlo neanche di mancanza di ideologia. Parlo di mancanza di una visione radicalmente diversa nei paradigmi del vivere. Sempre Fisher: “Una delle funzioni dell’hauntologia è continuare a insistere sul fatto che ci sono futuri oltre il tempo terminale della postmodernità. Quando il presente ha abbandonato il futuro, dobbiamo ascoltare le reliquie del futuro nei potenziali non attivati del passato”.
Cosa significa tutto questo applicato alla sfera politica? Al momento non è dato sapere. Francamente l’ennesima rifondazione di un partito rivoluzionario, di una struttura organizzativa e di un’ideologia mi sembrano veramente delle iatture da cui fuggire lontano.
Cosa significa tutto questo applicato alla sfera musicale? Tutti gli esempi che vengono fatti da Fischer testimoniano l’esistenza di una hauntologia che io chiamo ‘militante’, perlomeno nei fondatori di alcune etichette come Ghost Box: “Gli spettri nella hauntologia di Ghost Box sono i contesti perduti, che, immaginiamo, devono aver suscitato i suoni che stiamo sentendo: programmi dimenticati, serie non commissionate, episodi pilota che non sono mai stati seguiti. Belbury Poly, The Focus Group, Eric Zann – nomi di un alternative anni ‘70 che non è mai finito, un mondo ricostruito digitalmente in cui l’analogico regna per sempre, un vicino-passato moorcockiano scambiato nel tempo. Questo ritorno all’analogico tramite il digitale è uno dei modi in cui i dischi di Ghost Box non sono semplici simulazioni del passato […] Naturalmente, Ghost Box è stato accusato di nostalgia, e naturalmente questo gioca un ruolo nel suo fascino. Ma la sua estetica esibisce un impulso più paradossale: in una cultura dominata dalla retrospezione, ciò di cui sono nostalgici è nient’altro che il (popolare) modernismo stesso”.
Tutto ciò mi sembra estremamente cerebrale, detto francamente. E poi soprattutto mi mancano dei punti di riferimento paradigmatici. La domanda infatti è: di cosa parliamo quando parliamo di musica? E il suo corollario è: riusciamo a trovare un contesto musicale in cui ci sia veramente un punto di rottura con la cultura precedente? Le due domande sono estremamente importanti e non si può sfuggirle, perché pongono dei problemi di metodo. Fisher sembra avere a cuore solo e soltanto la cultura pop dell’Occidente: usa autori e composizioni pop per dimostrare le sue teorie. Ma oggigiorno nel mondo si producono tonnellate di musica in qualunque continente e a qualunque latitudine. Mi chiedo come Fisher valuterebbe lo steampunk e in generale tutta la cultura post-catastrofale (dai Mutoidi a Mad Max): la nostalgia formale del passato ‘solido’ accoppiata con una forma ideologica che non è solo forma del presente ma istanza morale? Vedi sotto Grande Rifiuto. In realtà bisognerebbe capire cosa è stata la musica pop e rock dagli anni ‘60 a oggi, e in cosa sia stata futuristica. Mettere l’accento sulla progressiva restrizione delle frasi musicali: la musica gabber e techno porta all’estremo la fibrillazione melodica, ci sono due, tre massimo quattro note. I campionamenti sono sullo stesso livello. La forma canzone continua a permanere nell’ambito pop ma è sempre più la copia di se stessa. Nei ‘70 il rock aveva colto l’aspetto sinfonico di una possibile musica futura con le rock-operas: da un lato un pugno di canzoni che raccontano una storia magari con dei temi portanti (Quadrophenia),dall’altro dei componimenti da un’intera facciata come Ummagumma oppure un intero concept album con una sola traccia articolata (Thick as a Brick dei Jehtro Tull). Tutto ciò scompare drasticamente verso la fine dei ‘70. La forma canzone permane rigorosamente ma l’articolazione melodica è sempre più asfittica: citazioni di citazioni di citazioni sino a veri e propri furti (da My Sweet Lord alla colonna sonoradi The Piano).
A me la critica di Fisher colpisce solo per l’aspetto antropologico, quello relativo all’afasia delle giovani generazioni, non certo per la critica musicale. Ripeto: l’esame di un fenomeno commerciale, che si fa apprezzare per le sue dimensioni macro come la musica pop, può facilmente far perdere di vista il quadro globale della produzione musicale. Quadro che ha confini liquidi e sicuramente internazionali anche se talvolta si regge su un mercato assolutamente locale (25 milioni di utenti tengono in vita il country statunitense spaventosamente uguale a se stesso). Bisognerebbe poi, ogni tanto, mettersi a fare la punta alle matite su generi e sottogeneri, ed è per questo che personalmente apprezzo, per esempio, il rap come poesia urbana – non certo come musica. Il suo uso costante del campionamento è funzionale al discorso che passa tramite le parole. I campionamenti fanno parte della nostalgia, già dai tempi di Back on the Block di Quincy Jones, che sicuramente è un baedeker fantastico per traghettare le nuove generazioni dal jazz al rap urbano, ma non è certo significativo come contenuti musicali. Detto questo, se solo Fisher avesse voluto/potuto mettere a confronto l’afasia musicale del pop occidentale nelle sue varie declinazioni tecnologiche (massimo 4 accordi e frasi musicali di sei/otto note, il testo percussioni elettroniche ossessive come nel jungle) con la cristallina semplicità/complessità di un artista africano contemporaneo, avrebbe scoperto che esistono e resistono universi musicali paralleli. Universi che per nostra salvezza producono tonnellate e tonnellate di ricchezza musicale oltre ogni immaginazione coloniale. Non c’è bisogno di ascoltare nostalgicamente l’eco del potenziale non realizzato e magari, in prospettiva, rivoluzionario: la rivoluzione è già in atto ed è cominciata quando i musicisti si sono impadroniti della tecnologia occidentale della produzione del suono piegandola alle proprie necessità. A Londra nel 1997 il progetto Asian Underground testimoniò ventisette anni fa l’emergenza di una nuova cultura musicale: “Una fusione sorprendentemente naturale di musica e strumenti indiani con drum’n’bass, breakbeat ed elettronica, diversa dalle altre registrazioni elettroniche influenzate dal worldbeat” (1). E qui eravamo soltanto alla superficie. Oggigiorno l’Africa, con personaggi come Anjelique Kidjò, si è reimpadronita delle elaborazioni elettronico-africane fatte da Eno e Byrne tra 1980 e 1981 in album come My life in the Bush of Ghosts e Remain in Light, e i suoi figli più immaginifici come Blick Bassy vanno costantemente al di là dell’orizzonte folklorico per costruire melodie, contrappunti, acrobazie d’ogni genere che lasciano sbalorditi per il loro essere davvero altro. “The revolution will be not televised” avvisava Gil Scott Heron nel 1970. Aveva ragione. L’hauntologia resta dove è giusto che resti, una proiezione mentale tutta occidentale; la rivoluzione è già in atto e bisogna solo ascoltarla.
1) https://www.allmusic.com/album/anokha-soundz-of-the-asian-underground-mw0000594301