Sabrina Campolongo
Recensione de Il re ne comanda una, Stelio Mattioni
Premessa necessaria: il lettore che volesse seguirmi in questo viaggio dovrà rassegnarsi ad acquistare il libro online, o armarsi di pazienza e cercarlo tra bancarelle e negozi di libri usati (o librerie antiquarie), o ancora usare la tessera della sua biblioteca, perché non troverà né questo, né probabilmente nessun altro titolo di Stelio Mattioni nelle librerie italiane (nemmeno a Trieste, per esperienza personale, per quanto la città abbia dedicato allo scrittore addirittura una biblioteca, nel 2007, e tenti timidamente di ricordarlo di quando in quando con convegni a lui dedicati, l’ultimo nel 2003, a che mi risulta).
Un autore così dimenticato e mal compreso colpisce, soprattutto considerando che il suo esordio avvenne nel ‘68 all’Einaudi, grazie alla folgorazione di Bobi Bazlen, che portò il suo ‘pupillo’ con sé alla sua neonata Adelphi e pubblicò il primo e i successivi quattro suoi romanzi.
Adelphi rimase l’editore di Mattioni anche dopo la morte di Bazlen, fino agli anni Ottanta, quando per ragioni di ‘dissintonia’ con la nuova linea editoriale di Roberto Calasso, lo scrittore cercò una nuova casa per i suoi scritti, trovandola presso Spirali (1).
“Misterioso sul serio. Senza nessuna compiacenza fumistica” scriveva di lui Calvino a Vittorini, presentando tre racconti di Mattioni per Menabò, forse così misterioso da risultare impenetrabile anche per chi aveva riconosciuto il suo genio bizzarro e garbato, non catalogabile, eppure godibilissimo, semplice, ironico, per nulla artificioso. Un “favolista irreprimibile” è scritto sul risvolto de Il re ne comanda una, primo romanzo pubblicato di Stelio Mattioni, e primo titolo per Adelphi, nel luglio del 1968 (precedentemente, per Einaudi era uscita una raccolta di racconti dal titolo Il sosia), una “favola non dichiarata” scrive ancora l’anonimo redattore (forse Bazlen stesso?) per definire questa storia solo all’apparenza comune, in cui ben presto “una forza comica scardina e deforma continuamente il contesto della narrazione, assumendovi il grottesco come normalità.”
Vero, senza dubbio. Dopo un breve attacco con i piedi piantati nel terreno della verosimiglianza, che ci mostra una donna che fugge dal marito beone e sfaccendato, portandosi dietro una valigia pesante e le sue figlie e cerca rifugio in casa di un estraneo creditore, ci si accorge che il suolo e le pareti della storia cominciano impercettibilmente a muoversi, a vacillare, a dilatarsi. Dal momento in cui Tina, la protagonista, dopo essere stata multata sul tram da un controllore impermeabile al suo dramma, approda nella residenza-fabbrica del misterioso Orlando, offrendo il proprio lavoro per saldare il debito contratto dal marito Franco, ma chiedendo al contempo protezione da quest’ultimo, le piccole stranezze si accumulano, i dialoghi diventano sempre più ambigui, tuttavia il filo non si rompe mai, la storia non deraglia mai nel fantastico compiaciuto o nella farsa.
Tutto si gioca sul filo di un’inquietudine sottile, che non viene mai meno: si ride, certo, dello strambo personaggio del cognato Massimo, che vive “alla macchia” nel giardino della residenza – quello che dovrebbe essere un fazzoletto di terra chiuso tra le quattro mura di un palazzotto signorile del centro di Trieste, ma appare come una giungla spaventosamente ‘viva’ per chi incautamente vi si avventura – però il fucile che egli brandisce è indubbiamente carico. Così come è tragico e non grottesco il fatto che Tina sfugga a una prigione per rinchiudersi (volontariamente?) in un’altra, che perda una figlia, Millina, la più piccola e ribelle, che riesce a prendere la via della fuga per tornare dal padre, e poi finisca per perdere, in modo più sottile, anche l’altra, l’adolescente Pupetta, molto più svelta di lei ad adeguarsi alle rigide regole della casa, o a individuare la via più facile per esserne alleggerita.
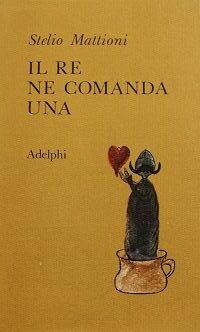
Il re ne comanda una, come la filastrocca da cui prende il titolo, storpiandone un verso, è allo stesso tempo una storia leggera e tragica (e anche una autentica Madamadorè farà la sua straordinaria comparsa, sul finale), può apparire una favola bizzarra, il parto di una mente incredibilmente fertile, di un autore dotato “di un mondo fantastico proprio e di grande forza” per dirla ancora con Calvino, ma è allo stesso tempo un ritratto potente e amaro della condizione femminile, frutto senz’altro di una riflessione profonda, probabilmente influenzata dal clima culturale, politico e sociale che una mente lucida e sensibile poteva respirare, persino nella remota e in qualche modo astratta Trieste, in un anno cruciale come il 1968 e più in generale sulla condizione umana.
Orlando, il monarca assoluto sempre a caccia di nuove ‘favorite’, è al tempo stesso Casanova e Barbablu, la sua ‘stanza segreta’ – in cui la moglie, rassegnata e precocemente invecchiata, non ha mai messo piede – non nasconde cadaveri di donne, ma di sicuro ne ospita i fantasmi, l’impronta di tutte quelle che sono passate sul grande letto antico che troneggia al suo interno. Il modo in cui la favorita di turno (prima dell’arrivo di Tina era Miranda, la direttrice dello stabilimento, ma si sa che ne sono passate diverse altre) manifesta il ‘privilegio’ della preferenza ha un crudo sapore medievale, nella sua teatralità: c’è una chiave, che, dopo cena, viene appesa a un gancio sul muro dallo stesso Orlando (ma solo quando ne ha voglia), sotto gli occhi di tutti (i figli, Divina e Attilio, la moglie Rosa, il tuttofare Pittsburg, e poi Tina e le sue figlie), e la donna che sa di averne il diritto deve avere il coraggio di esercitarlo pubblicamente, andandosela a prendere.
Tutti sanno cosa significa, tutti sanno dove sta andando e a fare cosa, e con chi, e quell’atto barbaro, “sozzo” e al tempo stesso eccitante, nella sua sfacciataggine, esercita un richiamo irresistibile anche su Tina, malgrado si sforzi di resistere. La chiave è per lei, ancor prima che Orlando glielo dica, è sua dal momento stesso in cui lei ha fatto il suo ingresso in quella casa, e la resistenza di Tina è solo di facciata, è legata al suo concetto di moralità, allo sguardo giudicante delle figlie (e non è un caso che sia proprio la più piccola e agguerrita, quella con lo sguardo più appuntito, a riuscire nella fuga), al suo orgoglio, ma non sorprende nessuno vederla impegnata, dopo nemmeno due giorni, a gareggiare con la concubina ufficiale, Miranda, sul terreno dell’avvenenza, misurandosi, nella sala da pranzo, sotto lo sguardo divertito, malizioso o infastidito degli altri occupanti della casa (salvo Orlando, che comunque lo verrà a sapere), la lunghezza delle gambe, con le gonne sollevate.
La sua capitolazione completa è solo questione di tempo, il fascino del sultano che decide di tutti e tutto, ma si mostra schiavo del proprio desiderio per lei, è decisamente irresistibile, e la competizione all’ultimo sangue con la favorita in carica non fa che rafforzare l’attrazione. Anche Pupetta, non più bambina e non ancora donna, è di riflesso, interessata alla chiave. “L’abbiamo finalmente avuta, eh mamma?”, esclama, la sera in cui se la ritrovano in camera, posata sul comodino, e Tina si spaventa, forse per l’uso di quel plurale – doloroso presagio – forse sentendo la forza del proprio desiderio di prendere quella chiave, farla sparire e usarla, così reagisce con violenza, schiaffeggia la figlia e resiste a Orlando, per quella notte.
Ma Orlando non si arrende. Così fan tutte, prima o poi, sembra essere la sua placida convinzione, e Tina non la smentisce. “Tanto sono sicuro che non sapresti che fartene, della libertà”, le dice, quando lei gli chiede, per la seconda volta, perché alle donne della casa non sia concesso di uscire; “In fondo dove andresti? È vero che non sai?” È vero, Tina è spaventosamente sola, messa con le spalle al muro da un marito parassita, minacciata dalla presenza di due fratelli dal coltello facile che non prenderebbero certo le sue difese, ma quelle dell’ordine costituito, della morale ufficiale; persino sua madre le nega la propria solidarietà, nemmeno le sue stesse figlie sembrano stare dalla sua parte, esattamente come le altre donne nella casa di Orlando.
L’universo femminile dipinto da Mattioni è una giungla popolata da leonesse tristi e solitarie, incapaci di fare branco ma occupate, per la maggior parte del proprio tempo, a cercare l’attenzione e la protezione di un maschio. Quest’ultimo, comunque, non fa migliore figura, condannato a interpretare costantemente il suo ruolo di guida e despota, pronto spesso a sopperire con la forza bruta alla sua carenza di motivazioni, ma schiavo al tempo stesso delle sue pulsioni, debole come un bambino di fronte alla morbidezza di un seno, perennemente bisognoso di novità nel suo letto.
La libertà è un concetto lontanissimo, tanto per le recluse quanto per il loro carceriere; le relazioni all’interno della casa-mondo sono così imbrigliate nella rigidità delle regole necessarie a mantenere quella pace velenosa, o quell’eterna belligeranza sterile, che nessuno, nemmeno il sedicente ribelle Massimo, è meno che prigioniero. Anche gli atti di ribellione si rivelano essere parte del percorso necessario a rafforzare lo status quo, il pesante portone che separa la casa (curiosamente connotata addirittura con un indirizzo preciso: via Valdirivo al 16, nel centro storico di Trieste) dal mondo esterno deve essere a volte spalancato, la libertà con tutte le sue insidie deve mostrarsi perché il ritorno sui propri passi, nella propria prigione, sia scelto.
La visione di Stelio Mattioni sulla possibilità di cambiamento dell’uomo appare decisamente pessimista, tragica anzi, quanto quella di Tomasi di Lampedusa, ma la sua leggerezza, l’umorismo, l’intelligenza lucidissima compongono un impasto unico, che non lo rende simile a nessuno. La libertà che si respira in ogni pagina è quella dell’arte, della grande letteratura che non si sottrae però dal confronto con il mondo. Se non fosse sufficiente il microcosmo-specchio della residenza di Valdirivo 16 (in cui, tra le altre cose, il rito dell’unica uscita settimanale per andare a messa è stato, a un certo punto sostituito, non a caso, con il rito della televisione serale), la connessione con la realtà e la Storia è esplicitata nel ‘laboratorio’ al centro della casa, in cui si producono barattolini pieni di una misteriosa sostanza definita ‘cosmetica’, ma legata in qualche maniera alla guerra, come si vanta uno strano personaggio (socio di Orlando o suo capo?) davanti a una spaventata Tina.
“[…] anche senza l’aiuto dell’America, noi non resteremo mai disoccupati. Dopo l’Europa i paesi latini, dopo i paesi latini il continente nero, e ora l’Asia. Poi, finita l’Asia, ti assicuro, riprenderemo il giro da capo. Sai come vanno sempre di moda i nostri barattolini?”. Tina sospetta che si tratti di esplosivo, ma rimane nel dubbio vedendo Orlando che, senza precauzioni, se ne spalma un generoso quantitativo sulle braccia. Il discorso di Orlando stesso, rispetto ai barattolini, realizzati con tante cautele e nel segreto, e loro funzione nel mondo è nebuloso, però offre qualche indizio.
“Chi avrebbe più amato il mondo, la sua bellezza, se il mondo non avesse avuto più ragioni di odiare?”, si chiede, preoccupandosi per il laboratorio, messo a rischio da zio Massimo – il quale però si affretta a fare dietro front e a salvarlo – e per i luoghi in cui i barattolini non sarebbero più arrivati.
Forse allora è proprio la discordia, la rivalità tra gli uomini, la guerra stessa a essere fabbricata, chiusa in barattoli e spedita in ogni parte del globo da quella casa, in cui tutti sono in guerra contro tutti e allo stesso tempo sono uniti dal più inscindibile dei legami, oppure si tratta davvero solo di cosmetici, dal significato originale dell’antico termine greco cosmos come ordine, così che cosmeticos si può intendere come ciò che serve a mantenere l’ordine.
E le catene.
Il re ne comanda una, Stelio Mattioni, Adelphi, 1968
1) Si veda l’interessante intervista di Annalisa Bizzarri a Maria Mattioni, moglie dello scrittore, http://www.oblique.it/images/interviste/mattioni_intervista_nov10.pdf


