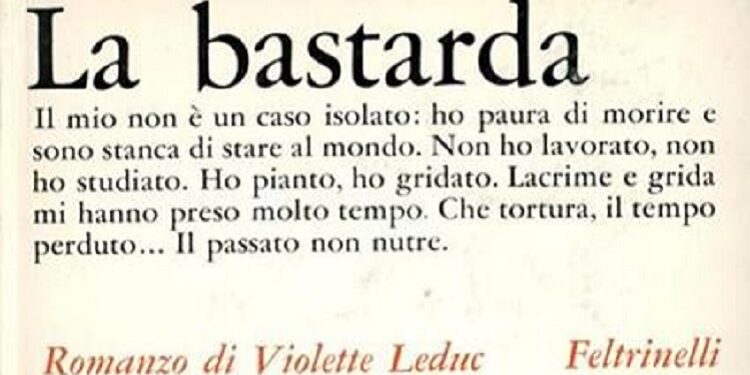Sabrina Campolongo
Recensione de La bastarda, Violette Leduc
Quasi impossibile parlare di Violette Leduc senza citare Simone de Beauvoir. Sulla loro relazione è stato realizzato anche un recentissimo film (Violette, di Martine Provost, uscito nelle sale francesi lo scorso novembre), ed è di De Beauvoir la prefazione de La bastarda (e a lei si deve, in gran parte, il fatto che il libro sia stato pubblicato da Gallimard nel 1964), ma sarebbe riduttivo quanto ingiusto relegare questa scrittrice al ruolo di ‘amica di Simone de Beauvoir’. Scorretto, anche, perché dalle biografie e dalla corrispondenza delle due donne l’impressione è che la De Beauvoir non la trovasse, in fondo, nemmeno simpatica.
Ne era affascinata, all’inizio, colpita dal suo talento e dalla sua singolare ‘voce’ letteraria, un’ammirazione che non venne mai meno fino alla fine, persino quando la chiamava la femme laide (la donna brutta) nelle sue lettere a Nelson Algren, colpita al punto da lottare per lei, perché gli scritti di quella donna così ingombrante e faticosa superassero la censura, perché la sua prosa così aggressivamente sincera fosse letta e compresa. Ma Violette Leduc era troppo per chiunque.
“Violette Leduc non fa niente per piacere: non piace e fa persino paura” (1), scrive Simone De Beauvoir nella prefazione de La Bastarda, probabilmente la sua opera più compiuta, sicuramente quella che ebbe maggior successo, all’epoca, quella che raccoglie e sviluppa tutti i temi già trattati nelle opere precedenti (dai titoli lapidari e rivelatori: L’asfissia, L’affamata, Ravages, che si può tradurre come Danni). Non svela se anche lei ne avesse paura, ma l’impressione è che questa donna spesso frivola, che si autodefinisce avara e attaccata al denaro, che si vanta dei suoi traffici nel mercato nero, che chiama i tedeschi nemici, ma solo per praticità, che si disinteressa di tutto ciò che non può sperimentare con il proprio corpo e i propri sensi, fosse molto lontana dall’etica della De Beauvoir. Eppure, la potenza della sua scrittura, il temperamento, la spietatezza della narrazione autobiografia (“[…] non attenua niente. […] rimane complice delle sua invidie, dei suoi rancori, delle sue meschinità” [2]) era tale da non potere essere ignorata, almeno fino al momento della sua morte, nel 1972. Poi, misteriosamente, o forse no (“anche la sfortuna ha le sue ragioni” [3]), Violette Leduc e la sua opera scandalosa, sfrontata, ‘cattiva’, è scivolata nel dimenticatoio, da cui forse la riscatterà un regista, affascinato dalla sua vita o, ancora, il fantasma dell’adorata, idolatrata Simone de Beauvoir, che non la ricambiò mai nel modo che Violette avrebbe voluto.
Concepita fuori da ogni sacro vincolo, come nei peggiori feuilleton, dal ventre di una giovane cameriera sedotta dal rampollo della famiglia altoborghese presso cui prestava servizio – sfregio da cui la madre non si riprenderà mai, coltivando e trasmettendo a sua figlia un totale disprezzo non tanto per gli uomini, bensì per la ‘debolezza’ del sesso femminile, che così facilmente si presta a venire imbrogliato e rovinato dagli uomini – Violette è una bastarda, in tutti i sensi che diamo al termine. Non ha un padre – ma ha una figura immaginata, da cui erediterà o crederà di ereditare l’amore per la musica, per le belle cose, per il lusso – non ha un’appartenenza – è di troppo come scrisse Sartre, sempre nel 1964, ne Le parole – e non ha nemmeno molti scrupoli quando si tratta di approfittarsi delle persone che si innamorano di lei.
Si lamenta della propria solitudine, ma rende infernale la vita di chi cerca di alleviarla, pretende l’impossibile, si lamenta in continuazione, non lascia dormire l’essere amato, come se addormentandosi si disinteressasse di lei (“Odio quelli che dormono”, scriverà in Ravages, “mi chino su di loro con le peggiori intenzioni”), cerca di soffocarli nelle spire della loro relazione esclusiva, ma allo stesso tempo si sente soffocare e fugge, si innamora di altri, si costruisce spazi immaginari o reali di evasione. Vuole tutto, non è disposta a sacrificare nulla e lo dice, lo afferma con semplicità disarmante, con una scrittura fulminante quanto raffinata, frasi brevi ma per nulla spoglie, immagini condensate in gemme luminose. “Com’è grandiosa e musicale la mia scorciatoia di erbe pazze. È fuoco che la solitudine posa sulla mia bocca”.
Innamorata dell’impossibile, Violette ama disperatamente, quanto caparbiamente cerca di non essere ricambiata, pretende la vicinanza mentre fa di tutto per allontanare, trascinando chi le si avvicina troppo nel gioco al massacro della sua insanabile bulimia emotiva; la moderna psichiatria le diagnosticherebbe con tutta probabilità un disturbo narcisistico della personalità. Eppure, il suo dolore non è reso meno reale dal suo incessante, petulante lamentarsi, la percezione costante di soffocare, il senso di inadeguatezza e la solitudine ci appaiono profondissimi, laceranti, quanto più il tono della narrazione è ironico, leggero. L’occhio della madre, giudicante e dolente, fragile e spietato, solo in parte addolcito dal grembiule azzurro e dalla dolcezza di Fidèline, la nonna precocemente perduta, la segue sempre. Quello che Violette definirà, in un’intervista “il calvario materno” è stato il freddo orizzonte della sua infanzia, persino quando la madre si è risposata, tradendo la loro stretta alleanza, distruggendo la sua parte fiduciosa.
L’egocentrismo sembra, allora, l’unica via per la ricerca di sé. Lasciata sola, in compagnia di uno specchio spietato – la sua bruttezza la torturerà sempre – Violette si cerca nello sguardo di altri, senza concedersi mai fino in fondo. Ama nell’assenza, nell’irraggiungibilità, si innamora di donne sfuggenti, di uomini dichiaratamente omosessuali, della Parigi lussuosa e inaccessibile delle riviste di moda, nella quale resterà sempre un’intrusa, ma allo stesso tempo vive, legge come un’invasata, macina chilometri tra le vie di Parigi. I suoi vagabondaggi, intellettuali e reali, sono i momenti in cui respira davvero la libertà, e in questi viaggi l’interno si fonde con l’esterno, sprofondandoci nella musica, nei colori, nella luce. La sua fame di tutto, di amore, di bellezza, di riscatto, ci contagia, oppure richiama la nostra, ci troviamo coinvolti e complici, quasi nostro malgrado, nell’esercizio, spesso spietato, della sua libertà.

Gli interni claustrofobici (la stanzetta del suo amore con Isabella, al collegio, il meublé della sua relazione con Hermine, il retro della bottega di fotografo del suo matrimonio con Gabriel) trovano il loro contraltare negli immensi cieli della Normandia, nella grandiosità di Place de la Concorde, nei palcoscenici dei teatri parigini, dove la messa in scena è così viva da beffare la morte, da ingannare la vita e infine nelle campagne del ritorno a casa. I polmoni si aprono, a tratti l’idea di una soddisfazione possibile, anche per l’eternamente scontenta Violette, sembra materializzarsi, un senso di attesa si condensa tra le righe. La risposta non sarà svelata in fretta, eppure c’è, nelle brevi frasi in cui l’autrice si rivolge direttamente a noi, al lettore, come per ricordarci che ci siamo, che stiamo vivendo un rapporto a due con lei, che siamo sprofondati fino ai gomiti nella sua vita, che annaspiamo con lei, per trovare una via.
Come i suoi precedenti amanti, anche noi non riusciamo a liberarci dalle sue braccia: ci avvinge, ci stritola, ci ubriaca di parole (Scrivi!, la implorerà un altro amato che non la ricambia, lo scandaloso Maurice Sachs, per farla tacere, per farla smettere di raccontargli la sua vita ancora e ancora), scrive prevalentemente d’amore, dei suoi amori, ma intanto scrive, spalancando per noi la sua esistenza al mondo. Le strade di Parigi si aprono sotto i nostri piedi, ci intrufoliamo nei camerini degli atelier più prestigiosi del Novecento, sentiamo sulla pelle la perfezione del taglio di un tailleur Schiaparelli color anguilla, o il vapore umido di una cucina piccolo borghese (“l’odore romantico del lesso”); la sua scrittura è materica (definizione abusata, ma in questo caso assolutamente calzante) senza risultare esasperata, perché il suo rapporto con le cose, con gli oggetti, sembra essere di comunione perfetta, di totale comprensione, al contrario di quanto le accade con gli esseri umani, dove il malinteso è costante.
È una scrittura barocca senza eccessi, poetica quanto precisa, la penna di Violette Leduc si muove su un filo sottilissimo con grazia mirabile, guidata da una sensibilità fuori dal comune, bizzarra, spesso irritante, molte volte illuminante. Non c’è mai autocompiacimento né ricerca, come nell’amico Jean Genet (l’ennesimo follemente amato che non la ricambia) di una nuova etica contrapposta a quella ufficiale; Violette Leduc sembra essere totalmente estranea a qualsiasi discorso morale, non si confronta con nessun modello, se non quelli proposti da Vogue, si muove con l’innocenza dei bambini o dei folli, seguendo soltanto la bussola dei propri desideri. In questo è un personaggio (perché lo è, pur trattandosi di letteratura autobiografica non si tratta, né lo vorremmo, di un diario, ma di un romanzo) di sorprendente modernità.
Afflitta da un vuoto congenito, da una colpa genetica di cui porta il peso ma non la responsabilità, Violette non crede in Dio più di quanto creda in se stessa, non ha precise idee politiche, passa attraverso due guerre come affronterebbe una tempesta annunciata, cercando di salvarsi e salvare le sue cose, senza interrogarsi sull’evento in sé, ma solo sulle sue ricadute sulla sua esistenza, è consapevole del vuoto che la affama, ma sembra non essere in grado di fare delle scelte, sembra accettare il proprio destino passivamente, aggrappandosi a chiunque sembri darle attenzione. Cerca di colmare il baratro attraverso il possesso di oggetti materiali, o la ricerca di omologazione in un ambiente che immagina scintillante, costringe la devota – bistrattata – amante a lavorare incessantemente per comprarle abiti e stivaletti, per permetterle di frequentare il parrucchiere dell’icona di stile Lady Abdy, ma tutto questo la getta in un’arsura ancora maggiore, invece di dissetarla, come la prosciugano le sue passioni univoche e ossessive.
La via esiste, però. Scriva, le ordina Maurice Sachs, in una pasticceria di Parigi, e poi, vedendola sbiancare: “«Non le piacerebbe scrivere? Non le piacerebbe vedere il suo nome stampato in testa, in calce a un testo?» […] Mi sentii sciogliere di felicità e tristezza. Lo desideravo, ma non osavo ammetterlo. Sì, era il mio desiderio che non aveva mai visto la luce”. Eppure, Violette ci gira attorno da anni, ha divorato voracemente libri su libri, quando si è trattato di cercare lavoro ha fatto domanda in una casa editrice, il suo ‘diario’ è costellato di nomi di scrittori, eppure si è mantenuta sempre sul bordo dell’abisso, scrivendo solo comunicati stampa, occupandosi di libri solo dal di fuori, censurando il suo desiderio più profondo, proprio lei che sembrava non riuscire a frenare alcun desiderio.
“Il lettore compie l’impossibile sintesi dell’assenza e della presenza”, scrive ancora Simone de Beauvoir nella sua prefazione. Il lettore è l’amante perfetto per il narcisista, è la consolazione del solitario, ma, nel caso di Violette Leduc, viene ripagato con il dono di un mondo vibrante, in cui le più piccole cose sono dotate di una vita straordinaria; un viaggio in cui ogni anfratto del cuore umano, e in modo particolari gli angoli più desolati, viene perlustrato con ironia e coraggio. Non c’è redenzione, ma ci sono sprazzi di puro splendore.
La sezione finale, il racconto della ‘carriera’ nella borsa nera durante la guerra, dei viaggi infiniti a piedi, battendo boschi e campagne alla ricerca di burro o carne, cercando di sfuggire a bombardamenti e posti di blocco, il ritratto di povera gente e bracconieri, è un romanzo nel romanzo, il racconto di un’altra vita possibile, forse di una possibile, impura, felicità.
A distanza di quasi cinquant’anni, le parole con le quali Simone de Beauvoir chiude la sua prefazione sono più attuali e urgenti che mai: “Vorrei esser riuscita a convincere il lettore a entrarci: vi troverà molto più di quanto io non gli abbia promesso”. Devo aggiungere, a malincuore, che non sarà facile reperire questo libro, ormai desolatamente fuori catalogo – le biblioteche in questi casi si rivelano provvidenziali – ma di certo ne vale la pena.
La bastarda, Violette Leduc, Feltrinelli, 1965 – Traduz. Valerio Riva
(1) Cit. dalla prefazione de La Bastarda, ed. Gallimard, 1964
(2) Ibidem
(3) Ibidem