| di Luciana Viarengo |
Recensione di Storia di un archivista, Travis Holland
Mettere in relazione la Russia e il freddo è un processo piuttosto scontato, ma nell’opera prima di Travis Holland non c’è neppure bisogno di soffermarsi sulle condizioni meteorologiche e sui paesaggi innevati: il gelo che dalle pagine di Storia di un archivista pervade il lettore è una sensazione interiore, sapientemente costruita dall’autore – tanto da far dimenticare che si tratta di un autore americano al suo romanzo d’esordio e non di un affermato scrittore sovietico – attraverso gli ambienti e i simboli tematici che costellano il romanzo; un rigore che si assorbe per osmosi, attraverso gli orrori solo intuiti della Lubjanka, la rovina dei palazzi, il degrado dei quartieri, gli appartamenti condivisi ma, soprattutto, attraverso l’aura venefica di diffamazione, delazioni, controllo esasperato, nel quale ogni cittadino è costretto a vivere, nel perenne terrore della NKVD (la polizia politica pre-KGB), la cui visita improvvisa equivale a una condanna senza appello.
Questa ricostruzione accurata del disastro materiale e umano della Russia stalinista affacciata sul baratro della guerra costituisce la cornice, e al contempo l’humus della vicenda narrata da Holland, il cui protagonista è un giovane ex professore di letteratura russa, Pavel Dubrov.
Caduto in disgrazia per non aver impedito a suo tempo la diffamazione di un collega da parte degli studenti, e costretto a lasciare l’insegnamento, Pavel aveva ricevuto ‘una proposta che non si può rifiutare’: un lavoro all’interno della Lubjanka.
Che cosa può esserci di peggio al mondo per un amante della letteratura che dover distruggere manoscritti? Perché questo è l’incarico assegnato a Pavel, negli archivi letterari della Quarta Sezione, “un’unica stanza appena sotto il livello stradale. Un tempo ripostiglio per scope, secchi e materiale d’ufficio in disuso”. La stanza è stata riempita di scaffali, e gli scaffali di scatole di cartone, e le scatole di cartone di cartelline verdi che arrivano fino al soffitto. In questo oceano di parole il nostro protagonista è costretto a un continuo catalogare fascicoli e scatole naufragati sulla sua scrivania, con il disgustoso contrappunto delle sortite – una discesa agli inferi aggravata dall’odore mefitico del petrolio – alla stanza dell’inceneritore, per rovesciarci dentro i fascicoli di volta in volta designati dal suo diretto superiore, il fanatico sottotenente Kutyrev, figura realmente esistita all’interno dell’archivio letterario del carcere.
A pensarci bene, considerata la qualità di tanti libri che oggi vengono pubblicati, in qualche occasione un simile lavoro potrebbe risultare ben accetto, ma non nel caso di Pavel, costretto a perpetrare, con la distruzione dei manoscritti, la morte simbolica degli intellettuali caduti in disgrazia agli occhi del regime e rinchiusi alla Lubjanka in attesa che, questa volta senza simbolismo.
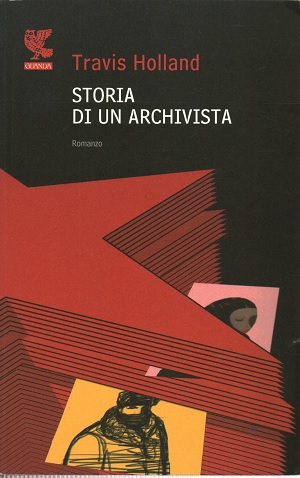
Tra questi il famoso Babel’– scrittore e drammaturgo ebreo russo, ucciso nel 1941, reale vittima illustre delle purghe staliniane – del quale, per ordine di Kutyrev, spetta a Pavel accertare la paternità in merito a un racconto sfuggito alla catalogazione del materiale probatorio.
Il romanzo si apre proprio sul loro incontro, in una disadorna e fredda stanzetta della Lubjanka, con Pavel suo malgrado investito del ruolo di persecutore di una vittima che rispetta e della quale ammira le opere, ora ridotta a un malconcio fantasma.
A sconvolgere Pavel non è tanto l‘aria dimessa o il vistoso livido che, appena sotto l’occhio, scende a coprire la guancia di Babel’, quanto la mancanza degli occhiali: un particolare che svela come allo scrittore sia stata negata la possibilità di leggere e di scrivere, in una estrema privazione di dignità. Una dignità che durante il colloquio Pavel tenta in ogni modo di preservare.
Da quest’occasione di incontro, maturerà in lui la decisione di sottrarre alla distruzione il racconto incompiuto, un gesto che basterebbe, una volta scoperto, a distruggere la sua vita, quella di sua madre e dei suoi amici.
Un bivio davanti al quale scegliere: la sottomissione totale alla tirannia nella illusoria speranza di una vita tranquilla da un lato, l’incoercibile riaffermazione del valore del pensiero umano e della letteratura dall’altro.
Impossibile, per chi abbia visto lo splendido film di Florian Henckel von Donnersmarck, Le vite degli altri, non collegare la figura di Pavel Dubrov a quella dell’agente della Stasi HGW XX/7, il capitano Gerd Wiesler, al quale un eccezionale Ulrich Mühe aveva saputo donare una stranita e dolente umanità; quella stessa umanità di cui è ricco anche l’archivista di Holland.
Facile anche immaginare che, come Wiesler/Mühe, Pavel lasci trasparire il proprio travaglio interiore solo attraverso impercettibili espressioni facciali, sguardi subito domati: un atteggiamento compassato che altro non è se non mimetismo conservativo.
Sotto la patina di autocontrollo di Pavel, infatti, corrono i nervi scoperti di una vita familiare segnata dalla morte della giovane moglie in un incidente ferroviario – perdita resa ancora più crudele da una burocrazia elefantiaca che non gli consente di rientrare in possesso delle ceneri – e dal declino della madre, afflitta da amnesie sempre più frequenti. Due aspetti dell’amore, quello per la propria compagna e quello filiale, che Holland tratta con dita leggere, senza indugiarvi, come un pittore al quale basti una pennellata perché l’occhio dello spettatore si focalizzi proprio su quel punto del quadro, indispensabile a comprenderne la totalità. La bravura di questo giovane scrittore americano è quella di farne simboli, entrambi, di una più universale dicotomia, quella del rapporto passato/presente, di un ‘prima’ luminoso e irrimediabilmente perduto, e di un ‘ora’ del quale pare essersi perso il senso e la necessaria progettualità di un ‘dopo’.
Questa assenza di futuro è ben rappresentata dal rapporto con Natal’ja, la giovane portinaia dello stabile in cui Pavel vive, con la quale ha una relazione difficile da definire, priva com’è sia del calore di un’amicizia sia della vampa di una passione erotica. Due vite senza futuro insieme, segnate dalla tragedia e casualmente approdate allo stesso letto, dove il sesso appare quasi algido.
Ma il veleno che si insinua nella vita quotidiana non permette altro, amici e conoscenti continuano a cadere nella rete di terrore e infamia che avviluppa la città. L’ignavia è un modo per sopravvivere.
Semën, anch’egli docente, figura paterna per Pavel e ben più di lui determinato a non piegarsi, decreta: «Di questi tempi, ovunque vada, mi sembra di incontrare fantasmi». E allo stesso Pavel, percorrendo le strade costellate di negozi e chioschi arrugginiti, di appartamenti disabitati – strade nelle quali l’iconografia propagandistica appare quasi una beffa oscena – sembra di scorgere il vero volto del proprio Paese, devastato, spogliato, divorato dal dolore.
Tuttavia, come già il film di Henckel von Donnersmarck, anche Storia di un archivista non è riducibile a una vicenda di denuncia dai risvolti demagogici, poiché Trevis Holland è in grado di rendere immediatamente palese il punto cardine del romanzo: proteggere la cultura opponendosi alla crudeltà e alla cecità di chi manovra la Storia. Provare, anche attraverso il coraggio di un atto individuale, a impedire che un’ ideologia votata al bene comune diventi un mostro in grado di cibarsi dei propri figli.
Restano, una volta terminata la lettura, gli interrogativi fondamentali: davvero l’atto di un singolo uomo può intervenire sul corso della Storia? E fino a che punto il genere umano è in grado di trasformare l’ideologia in vita quotidiana senza stravolgerla e piegarla a vantaggio dei pochi?
Vera, la moglie di Semën, insegna pianoforte e in uno scorcio sugli anni felici la si vede infilare, allegra, un famoso ragtime americano fra Schubert e Bach. A libro chiuso, più facile immaginarla con gli occhi rossi e asciutti, sulla struggente Sonata per uomini buoni.
Storia di un archivista, Travis Holland, Guanda, 2008


