28 settembre – 8 ottobre 2017
Titoli di coda
Ora che sono passati già due giorni dalla fine del Milano Film Festival è possibile fare qualche commento a freddo. Inizierò parlando dei vincitori. Per quanto riguarda i lungometraggi, è “Meteors” di Gürcan Keltek ad aggiudicarsi il premio della giuria come miglior film, mentre tra i corti esso va a “Long live Fran” (vincitore anche dello Staff Award) di Antoine Mocquet, dove un uomo con indosso una mina, intenzionato a fare esplodere una banca, viene abbracciato da una inconsapevole attivista in Place de la Républic a Parigi, che innesca così l’ordigno. A questo punto, se i due si separassero, provocherebbero una strage. Entrambi buoni lavori, avrei comunque preferito vedere premiato “Two Irenes” di Fabio Meira (vincitore, insieme al cortometraggio “489 years” di Hayoun Kwon, dell’Aprile Award, dedicato ai talenti da seguire) nella prima categoria e “Vibration” di Jo Bareun nella seconda. Ottengono una menzione speciale i corti “Pépé Le Morse” di Lucrèce Andreae, in cui viene affrontato il tema della perdita, e “Mon amour, mon ami” di Adriano Valerio, la storia a mio parere non riuscitissima del rapporto di amore e amicizia che lega un clandestino e una ex alcolista.
Dal punto di vista del pubblico, invece, il miglior lungometraggio è “Person to person” di Dustin Guy Defa, mentre il corto preferito è “State of emergency motherfucker” di Sebastian Petretti. Inoltre, nell’ambito del concorso Waterevolution, dedicato alla sostenibilità ambientale e sociale, nonché alla parità di diritti tra uomini e donne, vincono i lungometraggi “To the ends of the Heart” di David Lavallée, in cui vengono denunciate la pratica del fracking e drilling per estrarre gas e olio di scisto dal suolo canadese, e “Machines” di Raul Jain, una discesa agli inferi all’interno di un’industria tessile indiana; mentre i corti che meglio hanno affrontato tali tematiche sono “Tierra mojada” di Juan Sebastiàn Mesa e “Plantae” di Guilherme Gehr, dove viene messo sotto accusa il disboscamento della foresta amazzonica. Ottengono il premio alla miglior animazione ancora “Pépé Le Morse” e il lungometraggio “Have a nice day” di Liu Jian. Si chiude così un’altra edizione del Milano Film Festival, una finestra sul panorama del cinema indipendente internazionale. E, vista la qualità tecnica di molti lavori, nonché una diffusa attenzione alle problematiche sociali, si può dire che la situazione, tutto sommato, è buona. Speriamo continui su questa strada, sempre migliorando.
10 ottobre 2017
Resa dei corti, capitolo II
La ventiduesima edizione del Milano Film Festival è ormai giunta al termine. I vincitori sono stati annunciati, e lo staff sta già lavorando all’evento successivo. Più che mai avverto, dunque, l’urgenza di scrivere questo secondo e ultimo capitolo di “Resa dei corti”. Nel Gruppo D è da segnalare “Kiev Moscow” dell’ucraina Anna Lyubynetska, dove una ragazza di Kiev che lavora per un’agenzia pubblicitaria e il cui fratello è partito volontario insieme ai nazionalisti viene incarica di occuparsi di un attore russo. Un corto che non ha la pretesa di illustrare le ragioni geopolitiche del conflitto (del resto sarebbe difficile farlo in ventiquattro minuti), ma riesce a renderne perfettamente la tragedia sul piano umano. Una menzione va anche a “Onskedrommar” dello svedese Jonatan Etzler, in cui un’anziana signora esprime il desiderio che un presentatore televisivo (metafora dell’Eros) si trovi lì con lei per fare l’amore. Il miracolo avviene, e iniziano una serie di notti tanto focose per la donna quanto tormentate per il marito, costretto a dormire sul divano (anche se, tutto sommato, la prende fin da subito abbastanza sportivamente). Senonché a un tratto anche lui viene coinvolto in ciò che assume la connotazione di un menage a trois, determinando il riavvicinamento della coppia a livello erotico. Difficile scegliere tra i corti del Gruppo E, tutti davvero ben riusciti.
Ma, se proprio bisogna farlo, è “Route du soleil” dell’olandese Karsten De Vreugd a vincere la mia personalissima palma d’oro. Due amici ubriachi al pub discutono di immigrazione: uno è per accogliere i rifugiati, l’altro li rispedirebbe al mittente senza tanti complimenti. Fanno allora un patto: se il primo ospiterà un rifugiato a casa propria, il secondo ne riaccompagnerà personalmente uno alla frontiera. Quando quest’ultimo si risveglia in auto mentre l’altro sta guidando, scopre che c’è un terzo inquilino nell’abitacolo: un uomo di colore legato e apparentemente privo di sensi sui sedili posteriori. Ma si tratta solo di uno scherzo. Come spiega il paladino dei rifugiati al razzista durante una pausa in autogrill, egli è un amico col quale si stanno recando a Parigi. Senonché, nel frattempo, alcuni uomini di colore scoprono quest’ultimo ancora legato in auto e fraintendono la situazione. È l’inizio di un tafferuglio, in seguito al quale interviene la polizia. Peccato che quelle persone siano davvero rifugiati, senza documenti, dimodoché vengono arrestate. Ciò che era iniziato come uno scherzo si conclude con l’ingresso drammatico della realtà nella vita dei protagonisti.
Altro corto da segnalare in questa sezione è “Vergevaltigt wird hier keiner” della tedesca Alice Gruia. Girato tutto in un unico piano sequenza, descrive un momento di crisi nella vita di una coppia, che decide di sperimentare lo scambismo. Ma né lui né lei sembrano avere davvero voglia di farlo. Senonché ciò salta fuori, insieme a tutti i loro problemi, solo pochi secondi prima che arrivi l’altra coppia. Un buon lavoro sulla mancanza di comunicazione tra esseri umani. Veniamo dunque al Gruppo G, dove “Ratzinger vuole tornare” di Valerio Vestoso è quello che mi ha convinto di più. Come lo stesso titolo suggerisce, la trama vede il manager di Ratzinger, Pistacchio, organizzare il rilancio di quest’ultimo in Vaticano. Con un’ironia simile a quella di Corrado Guzzanti quando interpreta padre Pizzarro, Chiesa e media vengono demoliti a colpi di situazioni grottesche. Infine, “In a nutshell” dello svizzero Fabio Friedli è un gioiellino di appena cinque minuti in cui la storia del mondo viene illustrata attraverso ottomila oggetti.
9 ottobre 2017
Due pesi, due misure
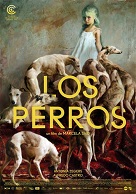
“Questo Paese è pieno di mostri”. È quanto afferma il poliziotto incaricato di indagare su Juan (Alfredo Castro), un ex colonnello, ora insegnante di equitazione, accusato di violazione dei diritti umani all’epoca della dittatura di Pinochet. Ciononostante l’attrazione che Mariana (Antonia Zagras) prova per lui non si sopisce, e i due diventano amanti. Una relazione che porta Mariana a conoscere la verità su suo padre, Francisco (Alejandro Sevieking), un ricco e potente uomo d’affari, degno rappresentante del capitalismo nella sua forma attuale. Anch’egli ai tempi di Pinochet era coinvolto nel regime, anche più di Juan. Ma Mariana è consapevole del fatto che, a differenza di quest’ultimo, suo padre non finirà mai in prigione in virtù del suo potere. Emblematica, da questo punto di vista, la causa per diffamazione vinta contro un giornale reo di aver rivelato che Francisco forniva camion all’esercito. Del resto Mariana non è nemmeno interessata a fare in modo che tale verità emerga. Ciò vorrebbe dire mettere in discussione tutta la sua vita e rinunciare, magari, a buona parte dei suoi privilegi. Ma, se si nega il passato, è impossibile anche solo ipotizzare un futuro migliore. Questo il significato simbolico della sterilità di Mariana o del cucciolo di cane ucciso alla fine. E non è un caso che il rifiuto della Storia avvenga da parte della borghesia, culla di ogni fascismo. Peccato che “Los perros” di Marcela Said non faccia nemmeno un accenno al ruolo centrale avuto dagli Stati Uniti nell’instaurazione del regime di Pinochet e, più in generale, di tutte le dittature sudamericane. Tale mancanza e alcuni difetti sul piano tecnico rendono questo film un lavoro monco.
8 ottobre 2017
Un coro di nevrosi

“Person to person” è una dichiarazione d’amore da parte del regista Dustin Guy Defa verso la propria città, New York. Film corale, i protagonisti sono un’adolescente misantropa, un collezionista di dischi, il coinquilino di quest’ultimo (un ragazzo di colore che in un momento di ‘turbamento emotivo’ ha caricato le foto della sua ragazza nuda su internet), un orologiaio poco loquace, una vedova assassina, un giornalista che è anche bassista di un gruppo metal e la stagista di cui dovrebbe essere mentore. Decisamente influenzato dalla poetica di Woody Allen (si pensi a “Manhattan”) e, più in generale, dal cinema intimista statunitense, “Person to person”, come ha dichiarato lo stesso regista (intervenuto venerdì 6 ottobre al Mudec in occasione del Milano Film Festival), vuole essere un film delicato, in cui la violenza, quando traspare, è sempre sullo sfondo e non riguarda mai direttamente i personaggi. La semplicità vista da vicino diventa complessità. Questo il cardine di ogni singolo episodio, collegato agli altri anche quando ciò non risulta evidente in quanto l’intento di Defa è proprio descrivere l’invisibile interconnessione che unisce tutti gli abitanti di New York. Nessuno si salva dalla nevrosi, ma tutti ci provano, chi con maggiore fortuna, chi meno. Non per niente i “Peanuts”, con Charlie Brown in testa, sono un altro riferimento del regista. Costellato di situazioni comiche (si pensi all’inseguimento in bicicletta da parte del collezionista verso il truffatore che gli ha venduto una copia falsa di un raro disco di Charlie Parker), “Person to person” non aggiunge nulla di nuovo al panorama cinematografico, ma è sicuramente una commedia ben riuscita. Più concentrato sulla psicologia del singolo (sempre appartenente alla classe media) e senza la pretesa di fare un’approfondita analisi della società americana, può essere consigliato a chi vuole prendersi un’ora e mezza di pausa dalle brutture del mondo.
7 ottobre 2017
Come una fenice

“Ouroboros”, il serpente che si morde la coda, è il titolo di questo film della palestinese Basma Alsharif. Un simbolo di morte e rinascita per rappresentare lo stato d’animo degli abitanti della striscia di Gaza, che ricostruiscono laddove Israele distrugge. E non è un caso che uno dei primi capitoli riguardi una casa, al cui interno si muove una donna, toccando gli oggetti sparsi nel suo percorso. Casa il cui significato abbraccia tutta la Palestina, minacciata da una potenza coloniale, ma anche l’individuo in senso stretto. Motivo per cui le riprese sono state fatte in varie parti del mondo così da sottolineare l’universalità di certe dinamiche. Concetto che si ripropone in diverse scene, come quella in cui alcune persone montano e smontano una tenda. Basma Alsharif sceglie un approccio sperimentale alla docufiction, realizzando un’elaborata sequenza di immagini in cui la ciclicità è il tema conduttore. Non per niente tutti gli attori sono anche artisti. Un modo di tracciare un parallelismo tra la creatività intellettuale e quella necessaria all’elaborazione di qualsiasi trauma. Da questo punto di vista, memoria e oblio sono due facce della stessa medaglia. La potenza delle immagini – alcune girate in pellicola, altre in digitale – è supportata dall’ipnotica colonna sonora di Yann Gourdon e Bunny People. Come ha dichiarato la stessa regista (intervenuta mercoledì 4 ottobre al Ducale nell’ambito del Milano Film Festival), “Ouroboros” nasce dall’urgenza morale e politica di sensibilizzare il pubblico sulla questione palestinese. Intento più che condivisibile, ma c’è da chiedersi se la forma scelta sia quella adatta. La complessità del lavoro, infatti, è tale da renderlo di difficile comprensione allo spettatore medio. Dimodoché la denuncia di Alsharif rischia di essere ascoltata solo da una ristretta nicchia di persone.
6 ottobre 2017
Resa dei corti, capitolo I
Sono ormai ventuno i corti da me visionati in questa edizione del Milano Film Festival, ed è giunto il momento di iniziare a parlarne. Come ha giustamente fatto notare uno degli organizzatori, questa forma d’arte può essere considerata un momento di incubazione di determinate tematiche. In alcuni casi il lavoro è riuscito, in altri meno. Nel Gruppo A, per esempio, “Crème de menthe” del canadese Jean Marc E. Roy è quello che mi ha convinto di più. Strutturato in sei capitoli, ognuno relativo a un giorno della settimana, la vicenda vede protagonista una ragazza che, in seguito alla morte del padre, viene incaricata dal proprietario di svuotare la casa e rimbiancare le pareti. Lavoro non semplice, visto che il defunto era un accumulatore compulsivo. Eppure, tra tutti quegli oggetti, nessuno riguarda la figlia. Almeno tale è la convinzione di quest’ultima, fino a che trova una cassetta su cui è registrato un concerto di quando era bambina. È questo il momento che segna il definitivo riavvicinamento col padre (già iniziato, in realtà, con la ‘riscoperta’ della tastiera), sottolineato, a livello simbolico, dal colore scelto per ridipingere le pareti: non bianco, ma verde acceso, come quello della crema di menta, liquore preferito dell’uomo. Non male in questa sezione anche “Tierra Mojada” del colombiano Juan Sebastiàn Mesa, in cui viene descritta la protesta attuata dalla popolazione locale contro un progetto idroelettrico che dovrebbe passare sopra le loro case nella giungla.
Nel Gruppo B è da segnalare “Pria” dell’indonesiano Yudho Aditya, che narra la scoperta della propria omosessualità da parte di un giovane uomo, con una coda di cavallo a simboleggiare il conflitto con le tradizioni della terra natale e un ragazzo americano, insegnante della scuola, a incarnare la fascinazione per l’Occidente. Inoltre, “Martien” dello svizzero Maxime Pillonel è la tanto esilarante quanto politicamente scorretta messa in scena di una rapina in un drugstore con un gruppo di ostaggi composto, tra gli altri, da un sordo, un monco e un bambino obeso che continua a ingozzarsi di patatine.
Nel Gruppo F troviamo “Min Borda” dello svedese Niki Lindroth Von Bahr, uno stralunato musical in cui, non senza ironia, un coro di pesci, scimmie e topi trasmette il senso di isolamento e alienazione dell’individuo postmoderno. Sempre scandinavo è “Katto” del finlandese Teppo Airaksinen, in cui lo stato d’animo di un uomo che sta divorziando viene rappresentato dall’abbassamento improvviso del soffitto nella sua casa di campagna. Nel Gruppo H ad aggiudicarsi il mio personalissimo premio come miglior cortometraggio della sezione (e forse di tutto il festival) è “Vibration” di Jo Bareun, dove un anziano, frugando tra le cose della moglie da poco defunta, trova un vibratore – una spassosa e, allo stesso tempo, commovente riflessione sul rapporto tra l’Io e l’Altro. Ma merita una menzione anche “State of emergency” del belga Sebastian Petretti, dove, mentre alcuni agenti arrestano e picchiano una coppia di arabi, questi ultimi continuano a parlare, come se niente fosse, di una storiella con una ragazza avuta da uno dei due. Un modo di affrontare con ironia un argomento drammatico come la violenza della polizia contro gli immigrati e le fasce più deboli in generale.
4 ottobre 2017
Quando la morte entra in casa…
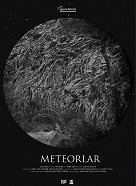
Ci sono film che per come sono costruiti possono essere paragonati a romanzi, altri a poesie. “Meteors” del turco Gürcan Keltek rientra decisamente in quest’ultima categoria. A cominciare dalla scelta del bianco e nero, in grado di donare una graffiante concretezza alle immagini, simile a quella di certe incisioni artistiche, si capisce subito come l’intento di questo lavoro sia trasmettere un ‘umore’, più che raccontare una storia in senso classico o documentaristico. Strutturato in sei capitoli, attraverso i quali lo spettatore viene trasportato su diversi piani dell’esperienza umana, il film si apre con una scena di caccia agli stambecchi, che echeggia un rapporto primordiale tra l’Uomo e la natura. Poco dopo gli obiettivi degli spari non sono più gli animali, ma le persone. Ci siamo spostati nella dimensione della guerra – e dunque della Storia – che ha interessato la regione curda a sud-est della Turchia a partire dal 14 settembre 2015. La telecamera di Keltek indugia su volti di donne, anziani e bambini sopravvissuti all’assedio di intere città per mano dell’esercito turco. Assedio che viene ricostruito in parte attraverso le immagini filmate dalle vittime con telefoni e altri supporti, in parte dalla voce di Ebru Ojen (attrice e scrittrice curda) in rappresentanza di tutta la regione. Una scelta quest’ultima che, come ha dichiarato lo stesso regista (intervenuto lunedì 2 ottobre al Ducale nell’ambito del Milano Film Festival), è stata determinata dalla volontà di dare un taglio femminile al film in contrasto col carattere prettamente maschile della guerra. “Quando la morte entra in casa, tutta la poesia è muta”. Sono parole della Ojen, la quale inizia a scrivere su un quaderno quelle che teme di dimenticare. La guerra mutila non solo i corpi, ma anche la psiche. Allora diventa essenziale ricordarsi che esiste altro oltre a essa. Altro che si concretizza nella pioggia di meteoriti avvenuta il 17 novembre 2015, visibile in tutta la regione. Evento in grado di fermare la guerra per una notte, con la popolazione curda che, incurante del coprifuoco imposto dalla legge marziale, si è riversata in strada per assistere allo spettacolo. Un messaggio di speranza in una terra martoriata.
3 ottobre 2017
Nello specchio

Davvero un bel film questo “Two Irenes” di Fabio Meira. Secondo lungometraggio brasiliano presentato al Milano Film Festival (l’altro è “Gabriel and the mountain” di Felipe Barbosa), narra la storia di una ragazzina tredicenne proveniente da una famiglia borghese, Irene (Priscila Bittencourt), che scopre l’esistenza di una sua omonima e coetanea di estrazione proletaria (Isabela Torres). Omonima che è anche la sua sorellastra in quanto figlia dello stesso padre, Tonico (Marco Ricca). Dimodoché viene presentato un ritratto del Brasile scisso a metà. Costellato di simboli (si pensi alla bellissima immagine dei due alberi con le chiome di diverse sfumature di verde intrecciate insieme, oppure alla massiccia presenza di specchi), il film di Meira può essere considerato alla stregua del Bildungsroman tedesco. Non per niente Solange (Maju Souza), la sorella maggiore di Irene, deve fare il suo ingresso in società col ballo delle debuttanti. Nel rapporto con l’Irene proletaria, l’Irene borghese cresce immensamente, sperimenta una femminilità fino a quel momento soffocata. E molto si potrebbe dire a questo proposito dell’ipocrisia dei privilegiati. Ipocrisia che fa della donna una vittima e carnefice di se stessa, come risulta evidente dal personaggio di Mirinha (Suzana Ribeiro), la madre di Irene. È proprio lei, infatti, a parlare della necessità di rasare i capelli alla figlia, nel caso dovesse prendere i pidocchi. Per non parlare del fastidio per i gatti – simbolo di libertà e indipendenza – sul tetto della casa, che vorrebbe avvelenare. La differenza tre le due Irene si nota soprattutto nel rapporto che hanno col proprio corpo: se una indossa le scarpe, l’altra gira a piedi nudi. Mentre l’Irene borghese è bloccata sessualmente, quella proletaria è un’esplosione di ormoni. Da questo punto di vista, la scelta delle attrici non è casuale: lineamenti delicati e seno non ancora formato la prima, tratti marcati e seno prosperoso la seconda. Il cinema è il luogo in cui avviene la scoperta dell’Eros – ed è bello pensare che si tratti di un omaggio del regista alla settima arte. Emblematico il bacio scambiato dall’Irene borghese con un altro ragazzino verso la fine del film, ma solo dopo avere avuto la stessa esperienza con l’Irene proletaria, che in questo senso è la sua mentore. Tuttavia, quest’ultima, a differenza dell’Irene borghese, non conosce la verità riguardo a suo padre. Solo quando Solange debutta in società la scopre. Ed è questo il momento – simbolico – in cui la consapevolezza del corpo e quella intellettuale trovano la loro sintesi.
2 ottobre 2017
Ali di gigante

Ammetto la mia abissale ignoranza sulla storia degli Smiths, che peraltro mi piacciono molto musicalmente, e di Steven Morrisey in particolare. Tuttavia, voci di corridoio mi suggeriscono che il film “England is mine” (titolo tratto dalla canzone “Still Ill”) ne presenta un ritratto molto fedele. E la cosa mi fa davvero piacere, perché con una sceneggiatura così accurata sarebbe stato un peccato che questo lavoro di Mark Gill presentasse difetti sul piano biografico. Ci troviamo nella Manchester degli anni Settanta, e Morrisey (Jack Lowden) è un ragazzo introverso, che sogna di fare lo scrittore. Per questo motivo spedisce mucchi di lettere di critica musicale a diversi giornali. Ma, nel frattempo, è costretto ad accettare un posto nell’ufficio tasse di Manchester. Qui si muove in maniera maldestra e vergognosa, come l’albatros baudelairiano: “esule in terra fra gli scherni, impediscono / che cammini le sue ali di gigante”. Infatti, riesce a “respirare” solo sul tetto del palazzo, dove si reca spesso – segretamente – a scrivere sul suo quaderno. Tuttavia, viene scoperto da Christine (Jodie Comer), una collega, che, in cambio del suo silenzio, gli impone di uscire con lei. Christine è l’opposto di Linder Sterling (Jessica Brown Findlay), l’artista con cui Morrisey si diverte a misurarsi a colpi di citazioni letterarie. Simbolicamente le due ragazze rappresentano la scelta esistenziale che Steven deve affrontare: cedere alle pressioni del mondo “reale” e rassegnarsi a quella routine da impiegato oppure restare fedele al proprio sogno. Scelta a cui viene concretamente sottoposto nel momento in cui il suo capo gli dice che non può continuare ad avere due vite. E non è un caso che in questa scena Steven venga inquadrato riflesso in uno specchio, simbolo del confronto con se stesso. Quando abbandona definitivamente il proprio ufficio, egli è convinto di avercela fatta. La sera precedente si era, infatti, esibito in un locale col suo primo gruppo, i Nosebleeds, ottenendo le attenzioni di un manager londinese. Tuttavia, non passa molto tempo che una telefonata di Billy (Adam Lawrence), il chitarrista, demolisce il suo entusiasmo: la casa discografica è interessata solo a lui, Steven e il resto della band non sono contemplati. Il colpo è tremendo, e Steven resta prigioniero per mesi di uno stato depressivo. A un certo punto, arriva addirittura a distruggere gran parte dei libri (tra cui non a caso spicca Oscar Wilde) e dischi che aveva accumulato in camera sua, un modo di segnare una cesura con le ambizioni passate. Infatti, accetta un posto da infermiere in un ospedale. Ma è proprio qui che avviene la sua “resurrezione”. Essere quotidianamente a contatto con la morte lo porta a comprendere l’importanza della vita, quanto sia necessario battersi affinché corrisponda al proprio ideale. Quando nel 1982 il chitarrista Johnny Marr (Laurie Kynaston) bussa alla sua porta, Steven è pronto a diventare il cantante degli Smiths.
1 ottobre 2017
Cambiare il cuore e l’anima
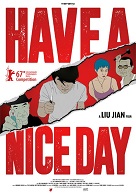
Unico lungometraggio di animazione presentato a questa edizione del Milano Film Festival, “Have a nice day” del cinese Liu Jian è una spietata critica del capitalismo. Al centro, una borsa colma di un milione di yuan, che passa di mano in mano a una serie di personaggi molto diversi tra loro, ma accomunati dal desiderio di accaparrarsi il bottino. C’è un gangster con la tendenza a filosofeggiare, iniziale proprietario della somma; una coppia che vive nel sogno hiltoniano di Shangri-La, una specie di paradiso perduto; un inventore in possesso di un paio di occhiali a raggi X, che vorrebbe fondare una start-up; e via di questo passo. Azzeccatissima l’intuizione del pittore a rappresentare l’arte ostaggio del mercato. Lo scenario è una città della Cina meridionale, che continua a espandersi in maniera incontrollata. Non per niente il film si apre con l’immagine di una ruspa in funzione all’interno di un cantiere, simbolo di un mondo in rapida trasformazione, che non riguarda solo il paesaggio, ma anche gli esseri umani. Viene in mente la citazione della Thatcher: “L’economia è il mezzo, l’obiettivo è cambiare il cuore e l’anima”. Inevitabile che il film di Jian incorresse nella censura in un Paese in cui di comunista è rimasta solo la bandiera. Emblematico, da questo punto di vista, il volto di Mao sulle banconote da cento yuan. Lungi dal possedere un sentimento di collettività, i personaggi di Jian sono individui parcellizzati in perenne competizione tra loro. L’unico a non pensare solo a se stesso è l’autista del cantiere – il primo a rubare la borsa – il quale vorrebbe utilizzare quei soldi per pagare un’operazione di chirurgia plastica alla propria ragazza, in modo da rimediare a una svolta precedentemente, che le ha deturpato il volto – simbolo dell’abbruttimento di cui è vittima l’Uomo nella società del profitto. Una società in cui Steve Jobs viene citato alla stregua di un profeta, la libertà coincide col consumismo, strutturandosi su tre livelli – mercato, supermercato e shopping online – e la tecnologia, al servizio del Capitale, non è più strumento di emancipazione, bensì di controllo, sfruttamento e sopraffazione. Dal punto di vista prettamente cinematografico, il lavoro di Jian si pone a metà tra il noir e la dark-comedy, diventando a tratti consapevolmente grottesco. L’ironia orientale – estremamente diversa dalla nostra – può lasciare, in alcuni casi, interdetto lo spettatore dell’Ovest. Ma, superato questo scoglio e un certo didascalismo nei dialoghi, “Have a nice day” resta un film più che godibile.
30 settembre 2017
Alla ricerca del vero

Il 28 settembre 2017 è una data importante per i cinefili. Segna, infatti, l’inizio della ventiduesima edizione del Milano Film Festival, che – nella cornice di BASE, MUDEC e Ducale – porta al pubblico otto lungometraggi e quarantuno corti provenienti da tutto il mondo. Un modo di esplorare il panorama del cinema indipendente internazionale. Partiamo con “Gabriel and the mountain” del brasiliano Felipe Gamarano Barbosa. Basato su una storia vera, narra il viaggio affrontato da Gabriel Buchman, un amico del regista, in Kenya, Tanzania, Zambia e Malawi. Viaggio che si conclude drammaticamente con la sua morte. Impossibile non pensare a “Into the wild” di Sean Penn. Anche Gabriel, come Christopher McCandelss, è alla ricerca di autenticità. Infatti, odia quelle che definisce “trappole per turisti”, mentre il suo desiderio è vivere a contatto con la gente del posto, essere uno di loro. Non a caso il film si apre con lui in Kenya che indossa un abito tipico e viene “battezzato” con un nome malawi: Lamayan, il più benedetto. Il suo obiettivo, giunto in Tanzania, è arrivare in cima al Kilimangiaro, un percorso che può anche essere letto in chiave simbolica, come volontà di conoscere. In questo senso, Gabriel è faustiano. Non per niente in diverse scene viene inquadrato mentre si allontana dal gruppo, come nel caso del safari organizzato insieme alla sua ragazza. Ed è proprio a causa della sua insofferenza agli itinerari prestabiliti che molto spesso litiga con lei. Il periodo che passano insieme in Africa è sicuramente fonte di felicità per Gabriel, ma è anche una parentesi rispetto all’esperienza “on the road” così come la intende lui. Questo aspetto del suo carattere – ossessionato dalla ricerca del vero – è probabilmente il motivo per cui Barbosa ha scelto la forma del docufilm, con tutte le risorse – ma anche i limiti – che questo comporta. I personaggi sono gli uomini e le donne reali che ha conosciuto Gabriel. Più che guardarlo, “Gabriel and the mountain” si tocca e si annusa. Ed è indubbio il fatto che si tratti di un lavoro estremamente sentito. Tuttavia, molte scene si sarebbero potute evitare o quantomeno riassumere. Penso, in particolare, alla sequenza finale di Gabriel perso sul monte Sapitwa, che nulla aggiunge a quanto lo spettatore già sa. Insomma, con quaranta minuti di meno sarebbe stato un ottimo film.
29 settembre 2017


