| di Luciana Viarengo |
Recensione de Il circo capovolto, Milena Magnani
Non ho mai letto, a proposito dei campi nomadi, descrizione più toccante e veritiera di quella pronunciata dal protagonista de Il circo capovolto: “Sempre l’ho sentito chiamare ‘campo baracche’, ma in realtà è soltanto un grumo. Un coagulo che il destino deve aver scartato dal flusso inarrestabile della corrente del benessere”.
Sullo sfondo una città solo suggerita, nella sagoma dei casamenti, nei fari e nei motori delle auto che corrono sul raccordo autostradale. Tutto intorno il fango, i rifiuti, le fogne a cielo aperto, i fantasmi sventrati di vecchie fabbriche che assediano le kasolle del campo nomadi.
È questo il porto al quale approda, durante l’inverno della grande pioggia, Branko Hrabal, alla guida di un camion carico di scatoloni, convinto di poter trovare uno spazio libero dove accamparsi. Non è così semplice, anche un campo nomadi è un crogiolo di realtà molteplici e poco compatibili, esattamente come la società che lo circonda, e come quest’ultima è un campo di potere, con regole e gerarchie alle quali sottostare, e nel quale prevalgono l’aggressività e l’esclusione – almeno iniziale – dell’altro. Un microcosmo nel quale è facile riconoscere la stessa emarginazione e lo stesso disagio che connotano la società esterna, quella dei ‘normali’.
L’orgoglio imporrebbe di risalire sul camion e riprendere il cammino, ma ci sono gli occhi dei bambini, la loro curiosità per il carico che lui ha dichiarato: un circo. E Branko rimane.
È lui, l’hungarez, l’io narrante che ci conduce nella realtà del campo e che ricostruisce per quei bambini e per noi la sua storia, col passo lieve di una fiaba e il peso insopportabile della tragedia.
Lo fa da morto, cioè dal momento in cui il suo cadavere giace accoltellato nel fango del campo fino a quando il coperchio della bara si chiude e viene calato nel ventre caldo e rassicurante della terra.
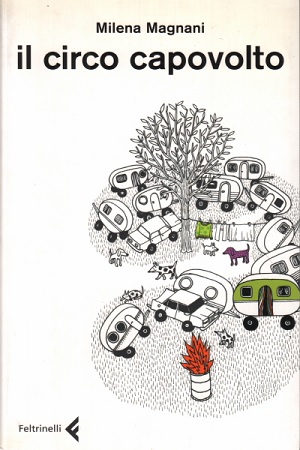
I bambini gli sono intorno da subito – dalla notte in cui la grande pioggia ha reso il campo una palude e l’ostile profugo croato Askan, capo indiscusso della piccola comunità, gli ha assegnato il punto peggiore del campo, a patto che faccia scomparire il suo merdume, i suoi scatoloni – in una babele di linguaggi e in un incantamento che andrà via via crescendo col procedere della narrazione e con la scoperta parallela del suo bagaglio, del quale i bambini non si stancano di chiedere.
“Voi avete fretta di capire queste scatole. Bene. Allora pensate un circo come lo conoscete voi e eliminate subito il tendone, poi le sedie e anche le panche delle tribune. Quindi eliminate gli animali, e alla fine le persone. Ecco, dopo aver eliminato queste cose, quello che rimane è un circo come il mio, che si può mettere dentro grandi contenitori e lasciare nel buio di un posto chiuso per anni. Értitek? Riuscite a capire come spiego le scatole?”
All’inizio i bambini sono delusi, la spiegazione di Branko si traduce per loro in modo molto semplice: “gli scarti di un circo abbandonato”. Ma Branko chiede a una di loro, una piccola profuga kosovara: «Perché fai la vita qua? Qual è stato il pensiero di portare la tua vita qua?» «Guarda che io vivo qua per non vivere là, perché là non è che si può vivere, dopo quello che hanno fatto a mio fratello, alla Mahala…» «Allora vedi che così è identico il circo mio, io ho provato di portarlo qua per fare che non sta più là, a Tokaj, in Ungheria, dopo quello che gli hanno fatto».
E la narrazione di che cosa è stato fatto al piccolo Kék Cirkusz di suo nonno Nap apó sarà, in realtà, la narrazione di ciò che è stato fatto alla sua genìa, cancellata nell’orrore di Birkenau ad eccezione di un solo bambino sopravvissuto: il padre di Branko, che una volta uscito dall’incubo rimuoverà ogni possibile riferimento alle sue origini e crescerà “come le persone ferme, che erano sempre vissute nelle case”, studiando e parlando l’ungherese dell’ufficialità, diventando un funzionario dell’ufficio delle tasse, insomma costruendosi “una vita in linea con tutte le persone regolari”.
Anche Branko nasce e cresce da ‘regolare’. Ma poiché un’irrequietezza di fondo gli impedisce di passare le ore sui libri, decide di andare a lavorare in una ditta di ponteggi sui quali scopre di sapersi muovere con la leggerezza e l’abilità di un trapezista. Una realtà che spingerà il padre a svelare, non senza sofferenza, le vere origini della loro famiglia e con esse l’esistenza del piccolo circo, sopravvissuto al naufragio ma legato a una storia di tradimento e di vendetta, che la scrittrice snoda per noi con la magia di una fiaba e il fascino di un noir.
Come non riscontrare nel piccolo circo, nella sua spoliazione, il simbolo di ciò che costituisce l’anima profonda di questi figli di un dio minore? Un simbolo tematico, il circo, che introdotto fin dalle prime pagine con riferimenti a malapena reperibili, cresce via via fino a diventare ragione di vita e speranza di riscatto.
La ricchezza de Il circo capovolto sta proprio nello sguardo privo di pietismo e di giudizio morale con il quale Milena Magnani parla di dislocazione e di diversità, rendendoli sì espressione di spaesamento e di dolore, ma anche possibilità di rinascita, testimonianza di nuove possibilità.
“Perché in fondo – dirà Branko – non siamo una tribù di parenti o consanguinei, veniamo da paesi incredibilmente distanti, però ci accomuna questo aver steso i panni sopra gli stessi fili, questo esserci accettati l’un l’altro in quanto cittadini senza più radici”.
Nonostante le etnie dei personaggi e le civiltà dalle quali provengono non possano apparire più lontane e diverse da quella di Macon Dead, la storia che Branko ricompone riporta per molti aspetti – quelli che danno forza alla vicenda – al personaggio creato da Toni Morrison, tragico eroe del Canto di Salomone. (1)
Anche qui, in un percorso a ritroso, la circolarità del tempo determina la continuità, il senso della storia e della Storia. Come Macon Dead, anche Branko va alla ricerca delle proprie radici, e con esse della propria identità, a dispetto di un padre che ha disperatamente cercato di negare entrambe. E come nel Canto della scrittrice americana, i bianchi dominanti sono una presenza intuita e minacciosa, esplicitata solo in sporadiche comparsate sempre caratterizzate negativamente. Anche qui l’elemento fiabesco-simbolico ha una parte importante, sia nella costruzione del mito – come quello di Solyom, che come già il Solomon del Canto, si libra in volo simbolo di libertà e di riscatto per le file eterne dei profughi – sia nella conquista identitaria del protagonista fino all’epilogo della sua vicenda.
Detto questo, la scrittura di Milena Magnani non ha nulla di morrisoniano, gode di una forza assolutamente personale, data da uno sviluppo narrativo solido e ben costruito al quale, sa donare la leggerezza “di una foglia galleggiante sul fiume” grazie alla magia di una lingua che Erri De Luca ha propriamente definito “sorella gemella della musica”.
La scrittrice sa creare un’atmosfera di assoluta lievità senza, tuttavia, fare sconti al tratto spietato della Storia e a quello altrettanto duro della società, la nostra, che circonda la realtà indefinita e composita dei nomadi. Una realtà esplicitata anche nell’incrocio dei differenti idiomi che compongono i dialoghi, neppure tradotti, forse a sottolineare che non è importante comprendere ogni singolo particolare di chi, diverso da noi, ci sta di fronte. Il messaggio, se si è disposti ad ascoltare, arriva comunque. E ciò che Branko chiede al lettore, in questo piccolo capolavoro di ‘realismo fantastico’, è di ascoltare, di permettergli di sistemare la sua storia prima di andarsene definitivamente, di seguirlo passo passo nel compimento del suo destino e di assistere al seme gettato, in attesa che germogli. “E poi la sensazione impalpabile, simile a un presentimento, di poter vivere nel campo in un modo diverso, in un modo che, forse, potrebbe mettere in salvo”.
Sfido chiunque legga il romanzo di Milena Magnani a mantenere inalterato il proprio sguardo sui nomadi che incontrerà, a non domandarsi quale storia stia dietro alle loro facce segnate e sporche, a giudicarli indistintamente esseri umani senza valore. Anche Branko se lo chiede: “Chissà se qualcosa di me è rimasto fuori a alitare per le strade. Sugli autobus. Sotto i rossi dei semafori. Chissà se qualche sconosciuto per caso un giorno si farà venire in mente il mio volto, magari mentre ricorda un’altra cosa, se ritroverà l’immagine di questo mezzo randagio che sono stato, seduto sul fondo. […] Chissà se qualcuno proverà sollievo non vedendomi salire alla fermata degli ipermercati, al pensiero che non dovrà, per quel giorno, abbassare immediatamente il finestrino. E infine chissà se, dopo tanto sollievo, qualcuno si domanderà dove sono finito. Così malandato. Così poco gradevole come qualsiasi altro baraccato”. Perché ciò che noi siamo, quello che ci sentiamo, dice ancora Branko, “alla fine è soltanto un pensiero”, perché così è fatta la vita di un uomo “è un’immagine che si crede di aver visto, inghiottita di colpo da un dolore senza preavviso”.
Consigliabile una distribuzione gratuita alle manifestazioni anti rom.
(1) vedi Il volo delle parole di Luciana Viarengo, Paginauno n° 1/2007
Il circo capovolto, Milena Magnani, Giangiacomo Feltrinelli Editore, 2008

