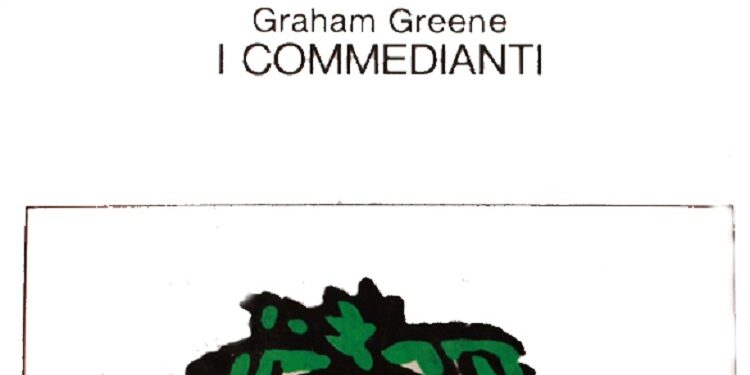| Sabrina Campolongo |
Recensione de I commedianti, Graham Greene
I commedianti vede la pubblicazione nel 1966, e appartiene a quello che Graham Green definirà il suo ‘ciclo politico’, per distinguerlo dal ‘ciclo cattolico’. Ambientato nella Haiti del dittatore François Papa Doc Duvalier, regime che Greene aveva conosciuto in prima persona, il romanzo ottenne come immediata conseguenza politica il divieto per lo scrittore e il suo romanzo di mettere piede sull’isola, oltre che un piccato pamphlet dello stesso Duvalier, nel quale l’epiteto più morbido riferito a Greene (anche quello che l’aveva sorpreso di più, a sua detta) era ‘torturatore’. C’è da dire che Greene non è stato per niente tenero con il regime haitiano, pur non avendo dimenticato, e non trascurando di narrarlo, che Duvalier, sedicente ultimo baluardo contro il comunismo era sponsorizzato e sostenuto dagli Stati Uniti, che avevano una responsabilità diretta sulla situazione dell’isola, occupata e sfruttata dal 1908 al 1934. Così come non mancano i riferimenti agli effetti perniciosi del colonialismo e della dominazione della razza bianca, dal Congo alla Birmania, al sud degli Stati Uniti, con i frequenti riferimenti alle sommosse di Nashville.
Nel caso di Haiti, sono i neri che detengono al momento il potere, dopo il colpo di Stato, ma la struttura sociale e i rapporti di forza sono rimasti quelli del lungo periodo del colonialismo, la stessa popolazione è figlia della colonizzazione, composta com’è da ex schiavi africani, coloni europei e americani e meticci, dal momento che gli originari abitanti dell’isola sono stati sterminati dai conquistatori spagnoli arrivati con Cristoforo Colombo e si considerano estinti dal 1540. I risultati parlano da soli. Haiti emerge come un surrogato di violenza, superstizione e miseria, disertata dai turisti, terrorizzata dalla feroce polizia segreta di Duvalier, i Tontons Macoute, gli uomini-spettro dagli onnipresenti occhiali scuri – eredi della Garde, la milizia creata e resa efficiente dagli americani – che si muovono con il buio per uccidere, rapire o torturare gli oppositori del regime.
Impossibile, scrive Greene stesso nella breve prefazione, rendere più tenebrosa una simile notte. Ma prima di sbarcare a Port-au-Prince e sprofondare nel suo buio, ci troviamo a bordo della Medea, una modesta nave da carico della Regia Società di Navigazione olandese salpata da New York, in compagnia di un eterogeneo e sparuto gruppo di passeggeri. Tre in particolare sono accomunati, oltre che da cognomi di rara banalità: Brown, Smith e Jones, di smaccata provenienza anglosassone, anche dalla tensione verso ciò che li aspetta ad Haiti, un ritorno con molte incognite nel caso di Brown, voce narrante del romanzo, che sull’isola ha lasciato un albergo e un’amante, una missione misteriosa per quanto riguarda gli Smith, una coppia di americani così unita da muoversi come un solo essere, e un’ancora più misteriosa avventura per l’enigmatico ‘maggiore’ Jones.
Nel corso della traversata, Brown fa conoscenza con i compagni di viaggio, scoprendo che il pingue signor Smith è stato candidato presidenziale contro Truman (assieme a molti altri americani i cui nomi restano sconosciuti ai più) e che il progetto (ma è più una missione, dichiara Smith con un misto di umiltà e orgoglio) che darà un senso alla ‘vacanza’ ad Haiti è quello di propagare e affermare la fede che lo lega a sua moglie: il vegetarianismo. Intanto Jones, inglese come Brown, intrattiene i passeggeri con le sue affascinanti storie di guerra, di quando comandava plotoni in Congo e in Birmania (anche se i dettagli dei suoi incarichi restano decisamente nebulosi), ignorando (o forse no) che un telegramma inviato al comandante della nave rivela che qualcuno è già sulle sue tracce.
L’arrivo di questo telegramma ci consente di intuire qualcosa di più sull’’osservatore’, piuttosto distaccato, Brown: davanti al ligio comandante, personificazione della correttezza e del rispetto delle regole, che domanda il suo aiuto per scoprire qualcosa di più sull’ambiguo Jones, Brown sembra schierarsi istintivamente sul fronte di quest’ultimo, sebbene sia il primo a nutrire più di un dubbio sul suo conto. Questo, e la breve conversazione con Jones che segue, ci permette di immaginare che, oltre alle origini, Brown e Jones abbiano altro in comune, che, per dirla con le parole di Jones, siano entrambi degli ‘svelti’. “I gentiluomini hanno un impiego fisso o un buon reddito. Hanno qualcosa su cui contare, come lei il suo albergo. Gli svelti… be’, noi ci guadagniamo da vivere qua e là… nei bar. Teniamo le orecchie aperte e altrettanto aperti gli occhi.”

Se Jones lo ha schierato di primo acchito – ma con riserva – tra i gentiluomini, Brown, prima di ereditare il Trianon da una madre appena ritrovata e quasi sconosciuta, e dopo aver lasciato il collegio gesuita nel principato di Monaco in cui lei l’aveva abbandonato, si è mantenuto grazie a una serie di attività precarie, cameriere in un bar a cui aveva fornito referenze false, venditore di croste spacciate per opere d’arte a ingenui arricchiti… Ogni azione della sua vita sembra essere stata determinata dai risvolti della fortuna, a cominciare da un gettone della roulette infilato imprudentemente nel sacchetto delle offerte in collegio, che aveva finito per rivelare le sue avventure segrete in città, per arrivare all’incontro, di nuovo al casinò, con la donna che in qualche modo lo tiene legato all’isola. Senza famiglia, senza una patria, né più una fede, dopo aver perso del tutto una precoce vocazione, Brown sembra incarnare l’archetipo dell’orfano, mentre torna verso l’unico luogo al mondo in cui possiede qualcosa, sebbene troppo debole per poterla considerare una radice: “[Un] vuoto albergo e una relazione amorosa ch’era quasi altrettanto vuota”.
All’opposto di Brown e Jones, gli Smith appaiono tanto solidi quanto ingenui. “È un idealista”dice la signora del marito, spiegando con una sola parola il motivo per cui non ha mai avuto alcuna chance di vincere le elezioni. Niente se non un candido idealismo potrebbe portare qualcuno su un’isola afflitta dalla più nera miseria a proporre la cultura dell’alimentazione vegana – rimedio, secondo gli Smith, contro tutti gli eccessi delle passioni, violenza compresa – ma all’arrivo sull’isola i due danno prova di un coraggio fuori dal comune, nonché di un autentico, sebbene pericolosissimo, senso di giustizia.
Con un’ironia sottile, velata del cinismo di Brown (dolorosamente consapevole però che “il cinismo vale poco… si può comprarlo in qualsiasi magazzino a prezzo unico… è incorporato in tutte le merci mediocri”), osserviamo gli Smith mentre regalano dollari ai mendicanti, senza preoccuparsi e senza nemmeno rendersi conto del fatto che questo esporrà i malcapitati destinatari della loro generosità alla violenza di chi vuole impadronirsi di quel denaro, con quell’atteggiamento caritatevole del ‘capitalismo buono’, tipicamente occidentale e post-coloniale.
Allo stesso modo, il governo americano finanzierà Papa Doc, distogliendo lo sguardo dalle violenze del regime e turandosi il naso davanti alla costante negazione di tutti i cosiddetti ‘valori occidentali’ che proprio il tiranno-stregone dovrebbe difendere contro la minaccia comunista di Cuba, distante poche miglia marine. Se gli Smith rappresentano l’innocenza americana, ai limiti della cecità, Jones è l’interprete di una scaltrezza e di una capacità di adattamento tipicamente britannici. Dapprima imprigionato, poi portato in palmo di mano dagli stessi Tontons Macoute che l’avevano malmenato, immeritatamente in entrambi i casi, e infine costretto a nascondersi, con l’aiuto di Brown, quando le sue false credenziali vengono scoperte, Jones svelerà il suo enigma solo alla fine, e in modo del tutto gratuito, come vedremo.
Quanto a Brown, il déraciné, egli sembra invidiare la solidità degli uni e il fascino dell’altro, mentre è incapace di schierarsi su un fronte qualsiasi, pubblico o privato. La sua storia d’amore con Martha Pineda, moglie dell’ambasciatore uruguaiano a cui ‘affiderà’ Jones in fuga, è segnata da un eccesso di lucidità, vedi un’insanabile sfiducia, che gli fa vedere inganno e doppiezza in ogni atteggiamento, dietro ogni frase. Non a caso, è il momento in cui i due sono stesi immobili, nascosti nella vegetazione, “come due salme alle quali venisse data comune sepoltura”, che verrà da lui ricordato a posteriori come il loro più felice momento insieme, a dire forse che è solo nella morte, la prima notte di quiete, per dirla con le parole di Valerio Zurlini (il quale raccontò di aver scelto per il titolo del suo film un verso di Goethe, del quale però non ho trovato traccia), che, sopiti i sogni e le passioni, si potrebbe sperimentare qualcosa che somigli alla felicità.
“Giacevamo tranquilli l’uno accanto all’altra nella nostra tomba, e io l’amavo più di quanto l’avessi amata sulla Peugeot e nella camera da letto sopra il negozio di Hamit.” La morte attraversa il romanzo, declinata nei suoi differenti aspetti. È la morte della tragedia e della farsa, è quella quasi spensierata della madre di Brown, che non rinuncia a una notte di passione con il suo amante nero, infischiandosene dei rischi, è la morte tragica di quest’ultimo, che si suicida dopo di lei, il risvolto fatale della passione.
È la morte eroica di due dei personaggi principali, come vedremo, e la morte silenziosa, ignorata, di un altro dei passeggeri della nave. È la morte della giustizia e dell’umanità, quando non è più possibile nemmeno piangere i propri morti perché lo Stato assassino ne reclama il cadavere, come accade letteralmente nell’episodio del funerale del ministro del Benessere, morto suicida (l’ironia percorre tutto il romanzo, anche nei frangenti più drammatici), quando, senza altra ragione se non la vendetta verso chi si è preso un diritto riservato al potere, i Tontons Macoute impediscono al corteo di procedere e si portano via la bara e il suo contenuto, che non verrà mai ritrovato (episodio che Greene definisce ‘desunto dalla realtà’). La morte dei nonmorti, infine, che la gente soggiogata da miseria e superstizione crede vivano nei sotterranei di Papa Doc (abile anche nell’utilizzare le credenze popolari e il voodoo per tenere in scacco il suo popolo), schiavi anche da morti.
Il romanzo stesso si apre con una morte annunciata: “Quando penso a tutti i grigi monumenti eretti a Londra a equestri generali, a eroi di antiche guerre coloniali e uomini politici in finanziera i quali sono dimenticati ancor più profondamente, non trovo alcun motivo per burlarmi della modesta lapide che commemora Jones alla lontana estremità della strada internazionale ch’egli non riuscì ad attraversare…” Jones, infatti, concluderà da eroe una vita da faccendiere, così come sembra essere scritto nel suo destino sin dalla sua apparizione.
“Se potessi disporre di cinquanta uomini delle truppe d’assalto […] farei piazza pulita del paese come un purgante”, afferma infatti a pag. 22, ed è con molto meno di cinquanta uomini, e molto meno addestrati delle truppe d’assalto, che si troverà alla fine a capo di una rivoluzione, messo lì da Brown, il quale però ha come unico fine quello squisitamente privato di toglierlo dalla casa di Martha, di cui è immotivatamente geloso. La forza d’animo con la quale Jones affronta quest’ultima avventura ha un che di straziante, tanto più che, avendo confessato a Brown le sue bugie (nel cimitero in cui trascorrono una notte nascosti, in attesa che i ribelli vengano a prendere il loro nuovo comandante), avrebbe facilmente potuto sottrarsi alla missione suicida. Invece, andrà verso una morte assurda, per una causa non sua, distinguendosi per generosità e coraggio, tenendo occupati gli inseguitori per favorire la fuga dei ribelli, guadagnandosi quella stima fino a quel momento millantata.
Da un personaggio da commedia – i commedianti del titolo, destinati a sgusciare tra le maglie del destino, facendola franca, come lo stesso Brown e la sua amante Martha, ma anche altre figure minori – Jones passa dalla parte degli eroi tragici, accanto al dottor Magiot, il personaggio che forse più di tutti rappresenta l’integrità etica. Nero, comunista e cattolico non praticante, il medico sembra riunire in sé il meglio delle due fedi: la comprensione profonda dell’umano, il senso di giustizia, la cultura e il coraggio. Sembra vedere più lontano di tutti gli altri, nei suoi pochi ma decisivi interventi pronuncia parole pesanti come pietre. Davanti all’ex ministro del Benessere, che si è appena suicidato nella piscina del Trianon, alla domanda se sia deceduto di morte naturale risponde: “Le morti violente sono morti naturali, qui. È morto del suo ambiente.”
Ma il cinismo non attecchisce in lui, che si spende fino alla fine per i miserabili bistrattati della sua isola, e che nella sua ultima lettera, mentre aspetta che i Tontons Macoute lo vengano a prendere, ha ancora un pensiero per Brown. “La imploro – un colpo alla porta può impedirmi di terminare questa frase – quindi la consideri l’ultimo desiderio di un moribondo – se ha abbandonato una fede, non abbandoni tutta la fede. C’è sempre un’alternativa alla fede che perdiamo. O forse si tratta della stessa fede con un’altra maschera?”
La maschera, che qui ritorna, è evidentemente il grande tema del romanzo. Dall’imperialismo mascherato da esportazione della democrazia, ai destini individuali dei personaggi, ognuno interpreta una parte. L’unico a conservare questa maschera fino in fondo però è Brown stesso, che dopo aver perso il suo albergo, a causa di un guasto meccanico, un altro evento fortuito, si ricicla impresario di pompe funebri a Santo Domingo, grazie a un’altra svolta del destino. È lui, l’unico personaggio che non cresce. Mentre gli Smith, pur continuando a professare la loro incrollabile fede nel vegetarianismo, hanno dovuto sbattere contro il muro delle loro illusioni, scoprendo il dolore e il marcio del mondo che il sistema in cui credono ha contribuito a creare, mentre Jones ha accettato consapevolmente di portare il proprio ruolo fino alle sue estreme conseguenze, diventando davvero la persona che aveva finto di essere e facendo propria la causa per la quale darà la vita, Brown continua a sfuggire il confronto con se stesso. Anche l’amore per Martha, che era parso così forte da fargli sacrificare la vita di un amico, non regge in tempo di pace, rivelandosi l’ennesima commedia, recitata solo per il tempo della messa in scena. Forse per questo l’autore si premura, nella prefazione del romanzo, di diffidare il lettore dalla facile sovrapposizione tra scrittore e narratore, a ribadire che “Brown non è Greene”, o forse Brown è un Greene come avrebbe potuto essere, se non avesse trovato una fede autentica, un uomo smarrito in un vuoto di senso.
“Avevo lasciato la dedizione alle spalle, ne ero sicuro […] l’avevo lasciata cadere come il gettone della roulette nel sacchetto delle offerte. Mi ero sentito non soltanto incapace di amore – molti ne sono incapaci – ma anche di colpa. Nel mio mondo non esistevano altezze né abissi… vedevo me stesso su una immensa pianura, a camminare e camminare su distese piatte e interminabili.”
I commedianti, Graham Greene, Club degli editori, 1967
(traduzione di Bruno Oddera)