Da leggere ascoltando il cd e rispettando comunque la tempistica (se possibile).
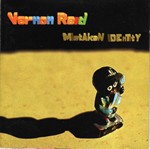
CD TIME
Tic, tac, tic, tac, riff di chitarra deciso e ripetuto ostinatamente, timbro hendrixiano della chitarra di Vernon Reid, tempo regolare di batteria.
Conosco gli orologi, ma ignoro il valore del Tempo. Cosicché mi affido per esempio al segnale orario della stazione radio della polizia, o di quello della radio. Del resto è storia comune a noi e a quelli al di là dell’oceano, gli americani: se guardate The aviator di Scorsese c’è una scena in cui il protagonista entra in una stanza per regolarsi l’orologio col segnale orario. Chi ci ha fatto caso avrà scoperto che il segnale è il cinguettio di un uccellino UGUALE in tutto e per tutto, IDENTICO a quello che la nostra radio nazionale ha mandato e manda in onda da anni.
Leon Gruenbaum, folle costruttore di altrettanto folle strumento denominato Samchillian tip tip tip cheeepeee, pigola e cinguetta metallicamente.
Santino O. era senza dubbio un tipo intraprendente. Era un povero carpentiere dell’Appennino marchigiano emigrato negli USA nel 1926 e per anni costruì grattacieli a Chicago mandando i soldi alla moglie rimasta a casa. Negli stessi anni un ragazzetto nero, nato nel profondo Texas, a Centerville, di nome Sam “Lightnin’” Hopkins, cominciava a suonare la chitarra sotto la guida del leggendario Blind Lemon Jefferson e di suo cugino Alger “Texas” Alexander. Nel 1946 Santino venne informato dalla moglie che il figlio era riuscito a iscriversi a Medicina mentre Sam venne notato da una talent scout della Aladdin Records e cominciò subito a incidere a Houston dove andò a risiedere.
Dj Logic, campione del mondo di turntables, comincia a scratchare un pigolio da uccellino. Subito dopo, scratcha la voce di Sam con scricchiolio incluso.
Il figlio maggiore di Santino, chiamato Ersilio, era a sua volta senza dubbio un tipo che potremmo definire quanto meno originale (perché non me ne viene una migliore, se no vedresti). Si laureò in medicina cum laude mentre il padre, come detto, lavorava e mandava soldi a lui e alla madre. Poco tempo dopo, nel 1953 o 1954, con la giovane moglie si trasferì negli States con le parole del padre che gli ronzavano nelle orecchie: “In Italia per il figlio di un carpentiere non c’è strada”. Quattordici anni dopo era primario di Patologia chirurgica e docente nella stessa materia alla Loyola University a Chicago. La moglie era una stimata gerontologa nello stesso ospedale.
Negli stessi anni Sam “Lightnin’” incise con una banda di rock psichedelico, i 13th Floor elevator, un brano intitolato Free from patterns (Libero dagli schemi). Ebbe un tot di figli suoi e almeno uno spirituale, ma di enorme importanza, chiamato Jimi Hendrix.
Toni lunghi dopo vertiginoso assolo e ripresa del riff ostinato – sempre hendrixiani. End MISTAKEN IDENTITY (errore di identità) guazzabuglio elettronico, scratch pigolanti e riff bluesistici tema narrativo vagamente wagneriano intervallato dal riff sospensione scratch voci campionate riff di nuovo pigolii simili a segnali radio di DJ Logic lo schema narrativo si ripete con inserti di voci non identificate. Il segnale radio si spegne con la chitarra.
Entrambi, Sam ed Ersilio, hanno dovuto affrontare più di una volta critiche e osservazioni anche solo maliziose ma pallosissime sul perché di alcune scelte. Dicevano che non si capiva perché un musicista blues e per giunta nero come il carbon girasse con dei fricchettoni bianchi zazzeromuniti che suonavano uno strano tipo di rock distorto da mal di pancia. Dicevano che non capivano perché un rispettabile chirurgo e professore bianco, che mi mostrava una bella villa in stile fiorentino con ogni comfort, due auto e il suo sancta sanctorum nella tavernetta, si fosse iscritto a un corso per corrispondenza per diventare direttore d’orchestra.
Ersilio aveva sistemato nella tavernetta un podio in legno lucido che odorava di formica, una bacchetta leggerissima di bosso con il manico bianco, un ragguardevole impianto stereo e una montagna di spartiti, a ognuno dei quali era associato un 33 giri. A ogni esecuzione famosa – intravidi la Nona di Beethoven diretta da Toscanini – il suo spartito. In un lato c’era una pila di videocassette. C’erano Von Karajan, Bernstein, di nuovo Toscanini. Ersilio saliva sul podio, avviava il 33 giri e il videoregistratore e dirigeva – beninteso dopo avere aperto lo spartito e sistemato uno specchio davanti al podio. Quando era sicuro che il modello fosse stato sufficientemente memorizzato, cambiava VHS. Cosicché – diremmo oggi – in modo interattivo, per un costo ragionevole e di sicuro molto democraticamente, Ersilio diventava letteralmente chi decideva di essere: se fossero stati disponibili Muti piuttosto che Sinopoli avrebbe studiato anche loro. Anche se non avesse conosciuto la musica, Ersilio o un altro qualunque John Doe dall’Alaska alla Florida passando per Chicago avrebbe comunque introiettato l’immagine di quello specifico direttore. Sino a diventare come lui. Identico sputato preciso – insomma: lungi dal pensare in termini di mito, il mito stesso diventava abbordabile. Ersilio diventava Von Karajan, Boehm, Furtwangler, Toscanini – e non avete idea di che cosa sia stato Toscanini per i nostri emigranti. Più di un idolo. L’immagine dell’Italia migliore che andava esule per causa dello schifoso antidemocratico Mussolini. Il direttore che portava l’opera – democraticamente, su di un treno con tutta la compagnia – anche nella sperduta provincia. Ersilio adorava Toscanini, naturalmente, ma lo trovava un poco rigido e troppo spiritato – troppo in trance per uno terragno come lui.
Ersilio era mio zio. Aveva sposato una sorella di mia madre e mi rivelò, in quell’estate dell’81 che trascorsi con gli zii e le cugine sul continente americano, la mia unica volta in quel paese, dettagli inediti sulla mia famiglia che mai avrei lontanamente immaginato. Soprattutto, nel corso di lunghissime chiacchierate mentre la Lincoln procedeva a 80 all’ora sulla lunghissima fettuccia ondulata che porta dritta da Chicago su, verso nord, nel Wisconsin, mi parlò della libertà, e di come fosse scarsa nel mio paese che era stato anche il suo. Ersilio aveva introiettato il meglio della cultura statunitense in termini di diritti civili ed era piuttosto liberal – sempre per gli standard USA – ma in Italia sarebbe stato un azzardo cercare di classificarlo in un qualunque partito, dei mille che già allora infestavano il Belpaese.
Ersilio era allergico alla burocrazia stupida, perché ammetteva che un poco di burocrazia era pur sempre necessaria. Era allergico alla burocrazia come i Padri fondatori che avevano buttato a mare le casse di tè degli inglesi a Boston, accendendo così la miccia della rivoluzione americana. Sostenne – amava i paradossi ma fino a un certo punto – che in realtà a scatenare tutto non erano state tanto le tasse doganali, quanto il fatto che gli inglesi avessero tentato di ingabbiare i giovani americani obbligandoli ad avere una carta d’identità: “Vorrai mica dirmi che IO devo provare a te, scimunito di un inglese, di un poliziotto, di un tonto con la divisa che IO sono IO? Non ho mica bisogno che TU mi dica chi sono IO. Lo so da solo. Non ti pare, nipote?”.
Eh, sì, ti capisco. In effetti è fastidioso dover ammettere che per colpa di un qualunque poliziotto o carabiniere, che sia tu, Ersilio, o io Augusto, si possa essere scambiati per qualcun altro. E passi finché siamo fermi, seduti sul sedile della nostra auto e “documenti per favore” (con la o ben aperta). Se per caso stessimo correndo perché ci siamo ricordati d’aver lasciato il gas aperto a casa e quello stesso poliziotto ci scambia per qualcun altro e ci spara?
A parte il mio e tuo misero e mortale corpo fisico, chi ci darà indietro l’identità che quello sparatore ci ha fregato mentre premeva il grilletto? E’ come mi fossi, per un attimo indeterminato, smaterializzato.
Di fatto di me, si potrebbe dire.
YOU SAY HE’S JUST A PSYCHIC FRIEND insomma potreste dire che sono solo un amico ridotto a pura psiche o che invece sono diventato un sensitivo al di là di tempo materia e spazio.
Voci da bollettini atmosferici e oscure previsioni da guerra atomica.
Altro riff inquietante, stavolta, all’unisono con un clarinetto (?).
Riff inverso sempre con clarinetto.
Riff iniziale again again and again.
Su un tappeto ritmico assolo di clarinetto. E’ Don Byron! Sembra entrato in scena per caso, senza riconoscere né il luogo né il tempo in cui si trova. Dissonante, apparentemente, mentre dietro riff ossessivo e tappeto di lamenti del Samchillian tip tip tip cheeepeee. Adesso Vernon gli va dietro e lui deborda sgocciolando in scale discendenti e ascendenti. Proprio non si trova. Qualcuno rappa. Cosa ci faccio qui? Cosa vengo a dire?
Con Ersilio mi divertivo, lo lasciavo parlare e a lui piaceva che stessi attento e rispondessi a tono. Forse in famiglia s’erano stufati di starlo a sentire. Ma in qual viaggio lo ascoltai ore e ore. Risposi stringatamente, un poco mollando e un poco stringendo. E quando stavamo in silenzio, continuavano a ronzarmi in testa quegli argomenti sull’identità, l’identificazione, la rivolta del tè, pardon delle carte d’identità. Pensavo alle cose che gli avevo detto: che in Italia dal 1975 c’era la Legge Reale e che aveva combinato disastri con l’uso legittimo delle armi, e ancora peggio che la legislazione d’emergenza sul terrorismo non era mai stata abrogata né nessuno pensava di abrogarla anche se manifestamente liberticida – figuriamoci, un anno appena dopo la strage alla stazione di Bologna – e infine che il mio era un paese a sovranità limitata, perché in nome della stessa libertà da lui amata, la CIA aveva tramato e ancora tramava contro il preteso pericolo comunista foraggiando l’estrema destra fascista e stragista. Ma più di tutti il tarlo della carta d’identità scavava, scavava. Pochissimo tempo dopo, avrei cominciato a domandarmi continuamente chi ero cosa facevo cosa volevo veramente dalla mia vita.
Avrei vestito corazze di flanella grigia impiegatizia in sostituzione dell’orrendo verde oliva della drop militare, oppure jeans sdruciti t-shirt e scarpe da tennis con annesso sacco a pelo in vacanza, giacca e cravatta in ufficio, infine avrei cambiato personaggio così come si cambia di camicia riuscendo persino a costruirmi un’identità ad ala variabile come gli arerei spia. A Milano quando ti conoscono per la prima volta ti chiedono dove abiti e che auto possiedi, a Roma che fai nella vita, a Bologna con chi esci. Così io, di conseguenza. Avrei addirittura sostenuto con successo e grandissima faccia di tolla di fronte a un messo del Tribunale, con gli occhi a fuoco incrociato, che quello che lui cercava non ero io. Lui cercava Bruno Augusti Quinto mentre io ero semplicemente Augusto Bruni – ce ne volle, ma dovette ammettere che la differenza anche se piccola c’era, e non era imputabile al fatto che in Cancelleria civile erano delle capre in italiano quanto al fatto che si trattava proprio di due persone diverse. Bastava chiedermi la carta d’identità, ma lui non lo fece. Si fidò in qualche modo della mia parola. E io ne approfittai biecamente usando le profetiche parole di mio zio Ersilio: lo saprò ben IO chi sono IO, me lo vuole insegnare lei chi sono IO? E poi il colpo di grazia: se non mi crede perché non guarda che cosa c’è scritto sul campanello?
Si ritirò in buon ordine, e credo si sia anche scusato. Una settimana dopo sparii da quell’appartamento, dalla sera alla mattina, e chi venne a cercarmi rimase con un palmo di naso. Se era lui credo ci sia rimasto anche male. Conservai sulla carta d’identità la residenza nello stesso appartamento da cui me n’ero andato. E, come si dice, ci marciai sopra alla grande, alla grandissima.
E adesso dimmi zio Ersilio, dimmelo in cuor tuo. Se ti avessi detto che le tue rivendicazioni di principio – giustissime e con cui potevo persino concordare – erano già sfumate ai tempi di Nixon e che comunque poche balle, nel tuo nuovo paese se ti volevano identificare i mezzi li avevano e come: patente, documenti dell’assistenza medica, licenza di pesca o caccia – una sfilza lunga da qui a Chicago: dimmi zio, avresti creduto possibile quello che decenni dopo è successo? Sempre in nome della libertà, beninteso. Perché vedi, zio, se voi giustamente ricordate che le prime vere carte d’identità, con tanto di foto sopra, le introdussero i nazisti già nel 1933 – e quelle degli ebrei avevano una “J” ben stampigliata sopra, e nel luglio del 1938 tutti gli ebrei sopra i 15 anni le dovettero avere – bene zio: che cosa ti stupisce di più, quei documenti o l’idea di marcare tutti i cittadini con un codice sottocutaneo leggibile come un codice a barre dal momento in cui nascono? Col rispetto della privacy, beninteso: tutti i tuoi dati antropometrici inseriti in meno di un centimetro: così in caso di incidente si saprà subito il tipo di sangue e, in caso di sfiguramento, l’identità sarà sicura. E in culo ai terroristi stranieri.
E poi non è neanche questo il punto vero, zio caro. Gli inglesi si ribellano perché gli altri europei vogliono obbligarli ad avere una carta d’identità. Dicono i giornali che gli ricorda troppo i nazisti. Ma non avevano voluto fare lo stesso con i giovani coloni americani? Sciovinismo o memoria corta? Forse tutte e due. Se è vero che a pensare male talvolta ci si azzecca, credo siano contrari perché devono PAGARE per avere una carta d’identità. Per loro è una cosa da marziani.
E poi, divagavo, la cosa più importante, zio.
WHO ARE YOU? (Mutation 1)
Chi è l’uomo fatto per distruggere? Egli si baserà sulla sua conoscenza
Hello, there. Who are you? How are you? Who are you?
Molteplici voci si sovrappongono in apparente caos radiofonico o di sciopero internazionale del centralino dell’Universo. DJ Logis scratcha a sedici mani (ne basterebbero quattro, ma abbondiamo, abbondiamo….).
Sono io ma non sono io mutazioni irreversibili esigono mutazione di paradigmi ma forse è troppo tardi (?1).
Che io sia un individuo e non una massa non te lo dice il fatto che non mi chiamo Legione. Troppo semplice, troppo biblico e autoreferenziale. Sono un individuo, secondo il mondo fisico a cui tu e io apparteniamo, e secondo il sistema di valori condivisi dai nostri paesi dell’Occidente, perché il numero a cui io sono apparentabile è 1 e non 2, non 10 o non 10.000. Questo è il primo passo. Il secondo è il fatto che io sono un individuo e ho di conseguenza una individualità. La quale è definita in linea generale in riferimento alle caratteristiche che mi distinguono dagli altri, sia dagli altri gruppi a cui non appartengo (e, in questo senso, ogni identificazione/inclusione implica una individuazione/esclusione), sia dagli altri membri del gruppo a cui appartengo, rispetto ai quali mi distinguo per le mie caratteristiche fisiche e morali e per una mia storia individuale (biografia) che è mia e di nessun altro. Di fatto, però, se si segue questa logica succede che subito dopo bisogna passare alla intrinseca unità fra il concetto di identità e quello di individuo, perché il mio corpo fornisce di per sé una adeguata e inappellabile definizione di identità – o perlomeno la fornirebbe. La regola fissata da antropologi, sociologi, politici e legislatori è infatti “un corpo, una identità”. Ma se io cambiassi sesso e colore di pelle, sarei sempre la stessa individualità con una identità diversa? Oppure sarei entrambe, individuo e identità nuove di sana pianta?
Se per accidente decidessi di assumere l’identità fittizia (se siamo in una chat in Internet) chiamata.
LIGHTININ’
Nessuno potrebbe dirmi nulla. Nel mondo virtuale di Internet io sono infatti composto di informazione e non di materia, sino a prova contraria. E sino a quando non vengo a casa tua, a casa di te che chatti con me fingendo di essere Monica Bellucci e scopro che ti chiami sì Monica Bellucci, ma sei una chiattona col neo coi peli e lavori al catasto, nulla quaestio.
Di nuovo serio:
su un riff blues ripetuto ossessivamente decido di essere Vernon Reid che suona come Jimi Hendrix che decide di suonare come Lightnin’ Hopkins. E fa anche assoli con note distorte che neanche Eric Manolenta Clapton riesce a tanto. Piuttosto, sembra Don Byron il clarinettista negli assoli di cui sopra, solo più blues. E tutto ciò pure in presenza di una base ritmica da hip-hop e non da rock.
Che cazzo sta suonando ‘sto nero del cazzo?
Becca su e porta a casa.
E se poi per un accidente qualsiasi io perdessi di colpo alcuni riferimenti essenziali per il mio Io, tipo se tutti quelli della mia religione venissero sterminati, se tutti quelli del popolo a cui sento di appartenere si volatilizzassero, se non ci fosse nessuno, ma proprio nessuno che sa conoscere e si riconosce nella cultura in cui sono cresciuto – se tutto questo scomparisse di colpo, ammetti zio che la mia identità ne verrebbe a soffrire non poco. Perché, caro zio, senza necessariamente diventare razzisti, nazionalisti o xenofobi, c’è un vizio nel manico che è sempre in agguato, sempre dietro l’angolo.
Il vizio sta nel fatto che io mi definisco sempre e solo in relazione a qualcosa di altro da me. ma non per questo la smetto di pensare di essere unico, assolutamente unico sulla faccia della terra, identico a me stesso attraverso le conferme che tutti questi bei salvagente mi danno.
La faccenda, peraltro, è cominciata sin dal mio primo vagito: ho dovuto avere subito chiaro che quello stesso vagito esce dalla mia bocca e non da quella dell’altro marmocchio che strilla nella culla vicina. Così simile a me. Tanto che gli hanno messo un bracciale con sopra il nome. Eh sì, perché il nome che la mamma mi sta ripetendo da giorni e giorni – non c’è verso di farle cambiare idea – appartiene a me e solo a me e io sono uguale a lui, nel senso che attraverso quel nome io sono identico a me stesso e posso riconoscermi quando qualcuno mi chiama. A meno che – adesso che sono più cresciutello – non ci sia nello stesso luogo qualcuno che si chiama esattamente come me – che buffo equivoco, ma se anche il cognome fosse uguale? E se per caso fosse uguale anche la data di nascita? E se per caso fossimo nati anche nella stessa città? Più che una curiosa coincidenza è un’immane rottura di coglioni, perché poni caso che l’altro sia un mafioso e io un cittadino rispettabile, o più semplicemente, io un bianco studente di liceo, incensurato e l’altro uno di pelle nera, naturalmente musicista, un po’ sfigato come provenienza, magari con qualche piccolo precedente per reati minori e il riformatorio alle spalle, sai che bella rottura.
Magari, sta’ a vedere che mi tocca cambiare nome per distinguermi.
Un nuovo progetto di vita vi attende nelle colonie extra mondo. Ma era il 1982, cazzo!
THE PROJECTS
Possibile che Vernon lanci un riff all’unisono con il bassista e che subito dopo Don Byron si accodi assolando assolando in bebop maniera. Ma è possibile fare un assolo jazz in bebop attitudine quando il chitarrista e il bassista hanno deciso che questo è un brano heavy very heavy rock ? Che stranezza. Adesso Vernon svisa in microtoni sempre più acuti.
Ri-presa del riff. Indubitabilmente un brano allucinato tra fantasmi dell’hard rock che immaginavano forse un mondo fatto a loro immagine e progetti di musicisti d’oggidì che nulla vedono se non il momento presente e che raccolgono i cocci di meteore di stelle che sono esplose.
Cascami di stelle. Alla deriva tra i quartieri alti di immaginarie città tutte eguali.
UPTOWN DRIFTER
E poi, per giunta, adesso che ho studiato, le cose si sono complicate. Eh sì, perché a parte quel Pirandello lì e i suoi nessuno e centomila, da un lato il vecchio Aristotele postula che A=A e dunque non ci piove: IO sono uguale a IO, maiala d’una maiala e la carta d’identità ve la scordate. Ma dall’altro c’è ‘sto sfigato di Alfred Korzybsky e il suo sistema Non-A, non aristotelico, dove ciascun ente o persona va sempre definito non in quanto tale, ma in quanto riferito allo specifico periodo di tempo in cui esiste.
Cosicché quell’altro tipo così identico a me, quel nero chitarrista con le treccine, se è stato messo in carcere per un reato commesso nel 1980 non dovrà essere più considerato identico a quello stesso individuo che nel 1990 sta ancora scontando la pena.
(Nel frattempo – è l’estate del 1995 in prima mondiale, Vernon e il suo gruppo, Masque, ovvero la maschera, si sono trasferiti al Festival Jazz di Saalfelden in Austria dove io in veste di inviato radiofonico li attendo per capire cosa ci fa un rockettaro degno erede di Hendrix, a capo di una delle migliori rock band mai esistite cioè i Living Colour, assieme a un gigante del jazz contemporaneo come il clarinettista Don Byron e al campione mondiale dei giramanopole, cioè DJ Logic. Un’ora dopo la domanda non ha più senso. Suonano musica avanti vent’anni rispetto a chiunque. Nel palco laterale riservato ai giornalisti, ci abbracciamo e quasi piangiamo dalla commozione. Jimi è di nuovo tra noi. Miles è di nuovo tra noi. Alla facciaccia di chi mette etichette e steccati. Alla faccia di chi concepisce il mondo solo in categorie etichette e classi, “ogni pampino suo ciardino”. Francamente me ne frego, come direbbe il Cele.
A proposito del titolo e del contenuto. Possibile, anche se nessuno ci crede, che un batterista in carne e ossa come Curtis Watts suoni a tempo senza scazzare come una macchina. E anche possibile che il bassista che gli va dietro potentemente a nome Hank Schroy non stanchi. Suonano uguale al disco, cioè maledettamente pieni di suono, atmosfera, sentimento e SENSO).
Si, zio, lo so che la tua obiezione ha un senso, ma ancora una volta è la solita obiezione pragmatica americana e come dicono i veneti “peso el tacon del buso”, peggio la pezza che il buco stesso. Perché? Perché se il DNA prova più di ogni altro sistema al mondo che io sono io e soltanto io, è anche vero che il mio DNA è l’ultimo pezzetto di privatezza che mi rimane. Una volta che l’avrò conferito a una banca dati cosa ne sarà di quei miseri, privatissimi dati che sono i mattoncini di cui sono costruito, almeno fisicamente?
Semplicemente, zio, non mi fido di nessun governo che abbia pretese di questo genere, e nessuna giustificazione di sicurezza e di garanzia dell’individualità e dell’identità dei cittadini potrà convincermi. Me lo ricordo cosa dicevano le camicie nere agli ebrei nel 1933: “Se non avete qualcosa da nascondere non avete nulla da temere”. Nel 1940 erano già tutti sapone o giù di lì. Una volta completata la banca dati degli europei o degli statunitensi con tutti i nostri DNA, basterà sostenere che alcuni indicatori di DNA sono attribuibili a individui di volta in volta ritenuti pericolosi o semplicemente indesiderabili, per espellerli o peggio.
Se deve essere così, molti potrebbero pensare che è meglio vivere come una cometa, esplodendo in miriadi colorate al contatto con l’atmosfera. Fuori non c’è aria. Dentro, l’aria brucia.
Tu esplodi quando la rabbia che hai dentro trova un alimento per venire fuori. E l’unica cosa che si imprime nella tua memoria e nel tuo continuum mentale è l’odore dello spirito di adolescenti in fiore, tra Humbert Humbert e Aqualung. Forse ti faranno santo. Già molti ti hanno santificato, Kurt.
SAINT COBAIN
In realtà più che di Kurt Cobain forse si parla della Saint Gobain, una fabbrica belga di vetri di vario genere, misura e utilizzo che pesa sulla coscienza del mondo per l’inquinamento che ha sparso in giro. Ma cosa importa se per quarant’anni ha dato da mangiare a migliaia di famiglie di operai. E cosa importa se Kurt è stato una meteora impazzita, capace di sintetizzare in tre accordi il profumo di una generazione persa o assente. Quarant’anni schiacciati in tre. Uno specchio non vale la personalità di chi comprime il rock in tre accordi e una voce da rantolo. Kurt si riconosce improvvisamente e anela alla libertà da se stesso o dall’immagine che gli specchi dell’industria gli propongono per riconoscersi al di là e comunque fuori da se. Fuori dall’etichetta chiamata “Grunge”.
Le voci africane campionate dal quell’inno che è “Free Nelson Mandela” di Johny Clegg rimandano sogni possibili, ma per te blindati, Kurt. Un altro IO identico a se stesso, nella misura in cui gli altri ti autorizzavano ad esserlo.
L’altra notte ho sognato. C’era Laurence Fishburne, quello che faceva la parte di Morpheus in Matrix, che parlava tenendo la lingua sul palato: il risultato era che sembrava un indiano dell’India che prova a parlare inglese. Per chi non ha idea del risultato provi a pensare a un lumbard o meglio un ticinese che parla l’inglese come se parlasse l’italiano con gli stessi accenti.
Fa piuttosto ridere, ve lo assicuro, ma lui diceva cose giuste e condivisibili parlando del Karma.
Mi dava – in realtà dava a tutti noi, indifferenziatamente, delle IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (importanti istruzioni di sicurezza)
determinando per ciò solo una Seconda Mutazione, melopee indiane insorgenti.
Per chi non lo sa, Karma significa legge di causa ed effetto. Nulla che non sia determinato da cause e condizioni esiste. Applicata alle persone, nella cultura hindu c’è una strettissima correlazione tra struttura sociale basata sulla divisione in caste e appartenenza per nascita a una di esse: non è possibile mutare di status da una rinascita all’altra né nel corso della propria vita. Il risultato è da un lato un incredibile senso di appartenenza e quindi d’identità, ma dall’altro uno scontro in prospettiva sempre più drammatico con l’individualismo del mondo industriale postmoderno, nel quale l’identità è per definizione mobile.
Buddha, il rivoluzionario, spezzò l’incantesimo delle caste e affermò che ognuno faceva gara a sé e che se l’anima trasmigrava ancora da un corpo a un altro. Nondimeno il karma si poteve trasformare sempre e comunque. Cazzi tuoi se il tuo conto in banca spirituale, i tuoi meriti, va sotto zero. Oggi alle stelle, ma se ti spendi tutti i crediti, prima o poi scenderai sotto la linea d’allarme e le conseguenze non potranno che essere negative. Ergo: agisci per il bene, ma fai attenzione. “Per ridurre i rischi, quando cerchi di cambiare il tuo Karma affidati solo a persone esperte, che possano guidarti per bene nel processo”. Così Laurence Fishburne, nel brano numero 9.
In questo mondo virtuale, che pervade sempre di più le nostre esistenze, tutto il concetto di individualità e di identità è diverso, perché esso è composto di informazione, invece che di materia grezza, per quanto organizzata in modo sofisticato e perfetto ogni dire. Dunque, caro zio, come minimo dovrei chiedermi
QUAL E’ IL MIO NOME?
E’ possibile indurre la sensazione delle sirene d’allarme che compongono un bello e dissonante concerto con insistenti riff di chitarra e basso all’unisono in cui si inframmezzano insistenti assoli di schizoidi clarinetti e miliardi di suoni metropolitani, schegge di suono e rumore inclusa una ciaramella di chissà quale pastore errante? Lei, da sola, fa la differenza, tra una parte e l’altra della (possibile e impressionistica) resa di un’anima in pena alla ricerca di un senso alla domanda
QUAL E’ IL MIO NOME?
C’è poco da fare: la seconda mutazione ha introdotto delle varianti irreversibili dentro di me.
Siamo nella primavera del 1982. Zio Ersilio e le lunghe strade tra Illinois e Wisconsin sono scomparsi, metabolizzati dalla caserma in cui stanno tentando di convincermi che la mia identità si possa rimodellare.
Prima considerazione: dopo venti giorni passati a guardare esseri tutti vestiti in verde, esco dalla mia camerata per la prima uscita in licenza e BANG! improvvisamente mi feriscono gli occhi i basici, semplici, elementari COLORI. Capisco, improvvisamente, cosa vuol dire UNIFORME. Non è un sostantivo riferito al vestito che porto, che in milleduecento portiamo. E ‘ un aggettivo, piuttosto, riferito come qualità allo stesso vestito. UNIFORME, cioè un solo unico colore sparso egualmente su milleduecento individui. Sempre uguale. Dannatamente uguale. Cioè dannatamente uguale a se stesso, ma attraverso la mediazione di milleduecento CORPI umani. Capisco immediatamente che è una mossa di una violenza terrificante, almeno per me, almeno per questo essere che da sempre proclama la sua individualità assolutamente non-apparentabile a nessun altro. Col cazzo che mi omologate, bastardi.
Seconda considerazione: sei mesi dopo. guardo di nascosto due sergenti carogna, di quelli che a noi fantaccini ci angariano giorno e notte mentre, in abiti civili, ascoltano col capo chino il direttore dell’ufficio anagrafe del comune. Il dirigente li strapazza perché non solo non gliene frega una cippa che loro sono sottufficiali dell’Esercito, ma anzi li strapazza il triplo perché proprio perché in quanto dipendenti di una Amministrazione dello Stato dovrebbero dare il buon esempio. E’ successo che i due hanno provato banalmente a saltare la fila per chiedere un certificato. Alla rampogne dei vecchietti bolognesi – rinco quanto si vuole, ma fermamente egualitari e sopravvissuti ai fascismo grazie al mito egualitario del Sol dell’Avvenire – hanno fatto il tragico errore di proclamare “Lei non sa chi sono io”.
E quando, all’esibizione del tesserino militare, la fila è esplosa in pernacchie berci lezzi cazzi e mazzi che c’era solo da sotterrarsi, i due hanno fatto l’errore ancora più tragico di richiedere l’intervento del direttore – ahi dura terra perché non t’apristi?
Morale: quando sei in caserma, l’indumento che porti serve a distinguerti dal resto della massa. Per questo si chiama ancora oggi “divisa”: perché ti divide – banalmente. Vale anche quando sei fuori. Con la differenza che, quando sei fuori, sei talmente visibile che qualunque cazzata tu faccia si vede lontano e intorno sei chilometri, mica sessanta metri come in caserma. Lo sanno bene i monaci.
Della serie: ecco perché ai carabinieri prima della libera uscita fanno la rivista delle tasche e vogliono accertare a campione che abbiano quantomeno un paio di fogli di carta igienica, il tesserino di riconoscimento e un gettone telefonico. Malelingue insistono che il tesserino è inutile perché un caramba si riconosce comunque, anche in borghese, che la carta igienica è inutile perché senza autorizzazione loro non la fanno (è poco virile farla fuori dagli spazi istituzionali) e infine che anche il gettone è inutile per chiamare la caserma in caso d’emergenza, perché il numero se lo sono scritto sulla carta igienica precedentemente usata. Scherzi a parte – questa è una SIGNED FICTITIOUS.
Cioè – alla grossa – una balla d’autore. Chiediamo scusa ai Carabbinieri Blues che sempre ci proteggono.
CALL WAITING TO EXHALE
Un siparietto di conversazione fittizia tra uno strafigo che tenta di imbonire la sua Angela al telefono e lei tonta che non ha capito che pur chiamandosi Angela non è la stessa Angela che lo strafigo cerca – risponde a tono!
Merita un’altra mutazione, ma di questa parleremo tra un attimo:
perché nel frattempo Vernon e compagni si sono scaldati e infilano un riff più complicato dell’altro e dietro all’altro. Don Byron giganteggia clarinettando e si ha quasi l’impressione che sostenga lui la baracca mentre Vernon si sacrifica a tenere su l’imponente macchina ritmica e tematica del gruppo.
A proposito, sarà bene ricordare che Vernon Reid – specie con il CD di cui vi sto parlando – ha fatto parecchio per minare alla base le aspettative stereotipate di ciò che un musicista di colore di solito suona o ci si aspetta dovrebbe suonare: il suo eclettismo fuori da schemi e lo ha portato a coinvolgersi a livelli di assoluta eccellenza con tutto ciò che la cultura afroamericana ha prodotto negli ultimi cent’anni: hard rock e punk, funk e rock’n roll, jazz d’avanguardia e assoli alla velocità della luce “Lightnin’” . Nel 1985, assieme al giornalista Greg Tate, ha fondato la Black Rock Coalition, un’organizzazione il cui obiettivo è quello di facilitare l’apertura delle porte del mercato della musica a musicisti di colore che non ne volevano mezza di essere egualmente confinati nei ruoli del cantante confidenziale o del rapper delinquente – due estremi in cui spesso e volentieri la cultura dominante dei bianchi ha ghettizzato chi voleva campare di musica. A suo tempo musicisti come Dizzy Gillespie e più ancora Miles Davis hanno ribaltato – in faccia a chi li aveva creati – gli stereotipi del musicista confidenziale, autore ed esecutore delicato di canzoni da seduzione a lume di candela, e del nero junkie, emarginato schiavo della sua immagine come della sua droga.
In questo album Vernon Reid ribalta ancora gli stereotipi. Tanto per cominciare, questo è un album senza canzoni, TUTTO STRUMENTALE. Nel senso che ci sono migliaia di voci, ma non ce n’è una che canti una canzone di senso e durata compiuti. Al contrario, ascoltate schegge vocali apparentemente impazzite – dovute perlopiù al genio di DJ Logic – perfettamente inserite nel contesto del brano che state ascoltando. Tanto basta per frustrare ogni aspettativa e ridurla in briciole come avviene in MY LAST NERVE dove l’ultima resistenza intellettiva cede il passo all’abbandono dell’ascolto privo di proiezioni, il mio ultimo nerbo si allenta e la musica fluisce, appunto, libera – risolvendosi nel meraviglioso brano successivo FRESHWATER COCONUT una fresca acqua di cocco in cui convivono miracolosamente lirismo wagneriano e incedere calypso alla Belafonte, incalzati da chitarre hard rock e una disgraziata rapper di periferia stonata e sgraziata – ma tant’è.
E’ l’illusione di un’integrità affermata, che vorrebbe farsi delle coccole – fresche come dolce acqua di cocco del tropico più confidenziale. Manco per niente.
Si rende necessario puntualizzare che – almeno dal punto di vista genetico – gli esseri umani sono tutti uguali per il 90%, e quello che fa la differenza sono le mutazioni:
“Ciascuno di noi presenta in molti dei suoi geni un certo numero di mutazioni che non hanno alcun effetto sulla salute, ma che concorrono a determinare l’individualità del corpo e, in parte, della psiche. Senza mutazioni saremmo tutti identici, con troppe mutazioni saremmo tutti morti, ciascuno in modo diverso. Ogni specie, inclusa la nostra, si mantiene in bilico sul confine tra queste due alternative” (E. Boncinelli).
E’ questo il MYSTERIOUS POWER (un blues abbastanza allegro, dopo tutto, di nuovo con mirabilmente semplici unisoni tematici di chitarra acustica e clarinetto, però ritmati anche da tabla, il che è inconsueto come al solito) il misterioso potere che fa sì che ognuno di noi sia un Universo unico e irripetibile e che grazie non si sa bene a chi – alcuni lo chiamano Dio altri spirito di provvidenza della forza dell’evoluzione umana altri in altri modi – tutti risultiamo essere fratelli per grossissima parte, ma almeno per un 10% siamo individui. Meno male. Mi rassicura il fatto che dopo avere condiviso tanto, partendo dal biologico per arrivare all’intellettuale, potrò salvare una fettina di torta dell’esistenza per me e per me solo.
(Voce fuori campo: ne sei proprio sicuro?)
Flash. E’ il marzo 1997. Il 30 marzo festeggerei volentieri il mio compleanno senza pensieri, ma la pecora Dolly, spaventosa fotocopia genetica identica a se stessa, riesce a farmi dormire sonni tremendi in cui abbraccio un me non-nato.
UNBORNE EMBRACE.
Lirico quanto vi pare, ma è un Io che non vorrei mai e poi mai vedere.
Ho già qualche problemino a vedere e ad abbracciare tutto me stesso, riacchiappando al volo dei lembi che ogni tanto se ne scappano per aria come queste note stupende e sospese che Vernon lancia al vento come aquiloni di saggezza perduta.
Figuriamoci se mi fanno lo scherzo di regalarmi per compleanno un IO clonato copia carbone da mandare al lavoro a faticare per me, a fare la fila per me per pagare le bollette, a presentarsi a un cocktail party e fare vita di società, da mia suocera a discutere delle ferie ….. un momento, potrebbe anche essere comodo…fatemi pensare…
È qui la festa? Ma chi ti ha invitato, a te? Ma chi sei? (traccia fantasma, ma vale – oh quanto vale…)
– Consiglio d’Europa: Raccomandazioni sull’ingegneria genetica n.934 (1982),n.1046 (1986)e n.1100 (1989)
– il diritto alla vita e alla dignità dell’uomo “implicano il diritto di ereditare caratteri genetici che non abbiano subito alcuna manipolazione”.
– bisogna evitare che qualcuno determini le caratteristiche genetiche di qualcun altro, senza la sua volontà e per motivi non degni di tutela.
– vietare “la creazione di esseri umani identici mediante clonazione o con altri mezzi, a fini di selezione della razza o per altri fini, e la creazione di gemelli identici”.
– Comitato Nazionale per la Bioetica: i documenti su Le tecniche di procreazione assistita (1994) e su Identità e statuto dell’embrione umano (1996), raccomandano che la clonazione umana sia vietata.
– Ministro della sanità – con due ordinanze del 5 marzo (GU 7/3/97) vieta tutto: il commercio di ovuli e di spermatozoi e “qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana e animale”.
– Parlamento europeo (12 marzo) chiede “un’esplicita messa al bando, a livello mondiale, della clonazione di esseri umani”;
– OMS (18 marzo): Dichiarazione sulla clonazione, di tono cauto;
– Legge italiana n.40/2004
– Articolo 12: Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un’unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione…
– Articolo 13: Sono, comunque, vietati … interventi di clonazionemediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell’embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca…
– Convenzione di Oviedo
– Articolo 1. Oggetto e finalità: Le parti firmatarie della presente Convenzione proteggono la dignità e l’identità di tutti gli esseri umani e garantiscono a ogni persona, senza discriminazioni, il rispetto della sua integrità e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.
Protocollo aggiuntivo (12 gennaio 1998) on the Prohibition of Cloning Human Beings: “ogni intervento teso a creare un essere umano geneticamente identico a un altro essere umano, sia vivo che morto, è vietato”.
Carta di Nizza (2000): “divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani”
Articolo 3. Diritto all’integrità della persona: Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica, sono gli elementi della identità dell’essere umano e quindi della sua personalità
UNESCO – Draft International Declaration On Human Genetic Data – 2003 Article 3. Person’s identity: Each individual has a characteristic genetic make-up. Nevertheless, a person’s identity should not be reduced to genetic characteristics.
Vernon Reid & Masque, Mistaken Identity, Epic, 1996
