Sabrina Campolongo
Recensione di “Crepe”, Luigi Bernardi e “La misura del danno”, Andrea Pomella
Dopo le reiterate e meritate accuse agli scrittori italiani contemporanei di avere smesso di cercare di raccontare il presente per raccogliersi nella contemplazione del proprio ombelico, si accolgono con sollievo le segnalazioni di qualcuno che, persino in Italia, abbia fatto lo sforzo di scrivere un romanzo in cui la terza dimensione non sia limitata a uno sfondo dipinto, alla foto di un tinello o alla rappresentazione di un qualche luogo metafisico o così remoto e fuori dal tempo da poter essere indifferentemente la Svezia di Larsson, il Maine di Stephen King, o la più anonima provincia veneta.
Con velata speranza ho scelto di leggere due romanzi che, almeno nelle premesse, si prospettavano come appartenenti a un filone ‘sociale’: l’opera prima del quarantenne romano Andrea Pomella, blogger molto attivo e giornalista, La misura del danno edito da Fernandel, e l’ultimo romanzo dello scrittore, sceneggiatore ed editore Luigi Bernardi, dal titolo Crepe, uscito per Il Maestrale.

La misura del danno narra dell’ascesa e della caduta di un novello Mephisto italiano, un attore belloccio portato alla ribalta da fotoromanzi e pubblicità di dentifrici, il quale, miracolato da una parte in un film impegnato nonché dal matrimonio con la figlia di un ricco professore ex simpatizzante anarchico e ora schierato nella sinistra più ‘giusta’ e progressista, finisce per mettere a rischio tutto quanto per togliersi lo sfizio di portarsi a letto una ragazzina minorenne, amica della figlia. Il misfatto viene naturalmente scoperto, e il peccatore esposto alla gogna mediatica, nonché cacciato dal suo esangue paradiso familiare, composto da una moglie freddina e da una figlia adolescente afflitta dalla nascita da un disturbo clinico che va sotto il nome di acufene, ossia un suono che la perseguita costantemente, a volte a livello di un ronzio di sottofondo, a volte come un fischio doloroso e assordante.
Naturale, vista la tematica, pensare a Lolita, come riferimento letterario, ma Alessandro Mantovani non ha di Humbert Humbert né la smodata intelligenza né l’humour sulfureo né la tenerezza, niente “midollo, sangue o mosche bellissime d’un verde brillante” restano attaccati alla narrazione della sua avventura con la sciapa ninfetta Beatrice Belfiore – che prima lo corteggia sfacciatamente, poi si chiude in un mutismo da agnello sacrificale al momento di mettere in atto le sue fantasie – che viene consumata, si direbbe, più per attestare l’esistenza in vita, o per non farsi mancare il più rischioso degli status symbol, che per la forza incontrovertibile del desiderio, con una consapevolezza dell’estraneità dell’altro più snervante che eccitante.
Naturale pensare anche ai riferimenti di cronaca, dal Rubygate (ah, la fantasia dei titolisti!) allo scandalo Strauss-Kahn, entrambi citati nel romanzo, alla vecchia vicenda di Roman Polanski, riemersa con il suo arresto in Svizzera nel 2009 per dividere così appassionatamente l’opinione pubblica europea da domandarsi come mai se ne disinteressasse dal 1978.
Il meccanismo della formazione degli schieramenti d’opinione è in effetti uno degli snodi cruciali del romanzo di Pomella. La narrazione non si conclude infatti con la condanna del protagonista, ma continua a seguirlo nel suo esilio nella casa paterna, un modesto appartamento in una borgata romana che Mantovani ha cercato di dimenticare per tutta la vita (salvo ricordarsi delle origini proletarie nei casi in cui ciò poteva aggiungere spessore al proprio personaggio), mostrandocelo mentre, in una quasi totale passività, assiste alla sua parziale riabilitazione da parte della parte più progressista dell’intellighenzia di sinistra, alla raccolta di firme in suo favore, ai dibattiti televisivi in cui si discute del suo caso, finché, quando forse comincia ad apparire la luce della convalescenza in fondo al tunnel, il sempre devoto e silenzioso padre gli spara un colpo, interpretando la propria esasperazione quanto quella del lettore, seppur mancando, sfortunatamente, i centri vitali.
L’epilogo ci mostra il Nostro di nuovo in piedi, seppur claudicante, ospite di una tribuna elettorale-salotto tv in qualità di candidato del centrosinistra, purgato e pienamente reintegrato nel seno della società civile e mediatica. “Gli eredi del ’68 erano arrivati alla conclusione che lui fosse la sintesi perfetta dell’italiano del terzo millennio, l’uomo capace di incarnare la condizione materiale della società e dello spirito della nazione”. Mantovani, più che un’incarnazione, è la maschera perfetta di questa società, così come l’avaro Pantalone lo era del mercante veneziano del Cinquecento.
Pur mancando i toni grotteschi e cupi del Mephisto, e in un contesto storico e politico molto differente, il romanzo di Pomella mira senza dubbio, come il capolavoro di Klaus Mann, a denunciare il vuoto che genera mostri, quel vuoto, solo adornato di ideologie scarnificate e ridotte a un guscio di preconcetti, che consente a un personaggio senz’altra qualità che un naturale mimetismo di emergere e restare sulla cresta dell’onda, un vuoto che Pomella ben cristallizza nei suoceri di Mantovani, i Sangallo.
Si può di certo applicare alla famiglia Sangallo la splendida definizione che Milan Kundera ha coniato per i Clevis, nel racconto Il confine: “Avrebbe potuto essere utilizzata come una sorta di livella a bolla intellettuale. Appoggiata su un’idea qualsiasi, essa avrebbe indicato con esattezza se si trattava o no della miglior idea progressista possibile”, tanto che lo stesso Mantovani si dichiara certo che, se non fosse stato coinvolto così da vicino, il suocero – dal suo trono dorato – sarebbe stato tra i primi a firmare la petizione per la sua liberazione.
Nella inconcludente lucidità seguita alla scossa adrenalinica della sua caduta, Mantovani deve realizzare che quest’ultima non è più inspiegabile della sua ascesa, durante la quale la fioca voce della sua modestissima etica non ha mai cessato di farlo sentire un intruso nella sua stessa vita. Questa stessa voce viene incarnata dalla figura del padre, ex operaio comunista e cassaintegrato dell’Autovox, da sempre diffidente verso le scelte del figlio e la sua nuova ‘appartenenza’ alla classe privilegiata, ma anche metaforicamente dal fischio che perseguita la figlia Martina, e dall’immagine di una “crepa invisibile e sottovalutata che negli ultimi vent’anni aveva continuato ad avanzare in maniera inesorabile lungo il muro maestro della sua vita raggiante e fortunata”. Una crepa che è forse l’unica verità di Alessandro Mantovani, come della società in cui è così bene integrato, in cui nemmeno i desideri più carnali appaiono autentici e scevri da condizionamenti culturali.
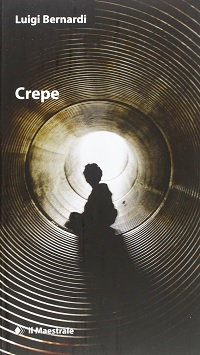
Non saprei dire se sia solo un caso bizzarro, che ancora una crepa, o più crepe, per essere precisi, siano il soggetto, metaforico e reale, del romanzo dell’altro contemporaneo, Luigi Bernardi. Crepe, nei muri del vecchio stabile bolognese destabilizzato dai lavori sotterranei per il cantiere dell’Alta Velocità, crepe nelle vite dei cinque protagonisti che in quello stesso condominio risiedono, crepe, ancor più in astratto, nella percezione della realtà che emerge dal romanzo.
Un baratro di pessimismo, una disillusione totale, un’assenza desolante di progettualità e di idee caratterizzano tanto i protagonisti del romanzo di Pomella fin qui analizzato, tanto quelli dell’opera di Bernardi, nella quale seguiamo in parallelo le esistenze di un anatomopatologo che vive in un mondo di fantasia che difende strenuamente, disinteressandosi totalmente della portata etica e delle ricadute dei suoi atti nel mondo reale, di un’anziana signora che abita i ricordi di un passato così idilliaco da lasciarci il dubbio che non siano più reali di quelli dell’anatomopatologo, di un farmacista separato vittima della propria irresolutezza, della giornalista rampante di cui forse si è innamorato, e del figlio psicopatico, unico personaggio ad avere un progetto e un’idea, per quanto disturbata, di ciò che vuole. Il cantiere dell’Alta Velocità e le sue implicazioni sia a livello pratico – inquietanti crepe nei muri, porte e finestre che non si chiudono o non si aprono, nauseanti fanghi che invadono le cantine – sia a livello simbolico, come lotta tra un passato visto da alcuni come morto e imbalsamato, da altri come vibrante e accogliente, e un futuro a velocità raddoppiata che sembra prendersi da solo lo spazio di cui ha bisogno, è più sfondo e pretesto che reale oggetto di indagine narrativa. Le talpe, i giganteschi macchinari ciechi che scavano nelle viscere delle città come mostri metafisici, sembrano avere più che altro la funzione di tranciare le radici dei protagonisti, precipitando il cambiamento anche nelle loro esistenze, in accordo con un mondo che inesorabilmente “va avanti”.
Così la vecchia signora Armida si vede portar via la propria autonomia e dignità dalle sue stesse figlie, con il pretesto di pensare al suo bene, condannandola a una casa di riposo; la bella giornalista, spinta come un treno in corsa dalla propria ambizione, trova l’ostacolo scontato e imprevisto di una morte violenta, di quelle che fanno la gioia dei cronisti di nera locale, il debole farmacista si vede sottrarre l’oggetto del suo amore proprio quando, dopo sfinenti ripensamenti, si era deciso a fare il grande passo dichiarandosi, l’anatomopatologo stralunato è costretto a cambiare aria, per proteggere la sua vita segreta, mentre il giovane sociopatico killer si trova la via spianata da un inatteso colpo di fortuna, che probabilmente nasconderà i suoi misfatti e gli aprirà la strada verso una criminale rispettabilità.
Negli ultimi brevi capitoli il treno corre sicuro sui nuovissimi binari, tra montagne con fondamenta ‘rifatte’ con il cemento, ospitando i residenti che sono ‘andati avanti’ (il giovane assassino e l’anatomopatologo nella sua bolla di realtà parallela) e lasciando dietro di sé chi non ha saputo o potuto adattarsi, chi sottoterra o in una casa di riposo, chi ancora nel palazzo che forse tra qualche anno ricadrà su se stesso come un brutto castello di carte, riaccendendo solo per un lampo le polemiche o fornendo materiale estemporaneo per nuove campagne elettorali, delle quali possiamo immaginare protagonista l’ex attore di Pomella o qualcuno che gli somiglia molto.
Volendo fare proprio ciò che Nabokov esecrava nella critica, ostinandosi a cercare un senso, un “che cosa ci voleva dire l’autore”, in questi due romanzi contemporanei, non si può che concludere che la visione è, pur nella diversità di tematiche e approccio, sostanzialmente simile nella negazione della possibilità di cambiamento, se non, se fosse possibile, verso il peggio, nella dimostrazione della sterilità di ogni azione ‘contro’ lo status quo, nell’abbandono a un flusso apparentemente inarrestabile della storia, che premia e punisce a caso.
Se il romanzo morale è morto con Dostoevskij e al romanziere non si chiede più di indicare una via né di possedere una visione, trovo che manchi, in ogni caso, in due opere comunque interessanti, un ulteriore sforzo verso la verità, un movimento più deciso nello scoperchiare le costruzioni del reale e dare al lettore almeno la visione fugace di ciò che si cela al di sotto di una superficie così ben riflessa.
La misura del danno, Andrea Pomella, Fernandel, 2013
Crepe, Luigi Bernardi, Il Maestrale, 2013


