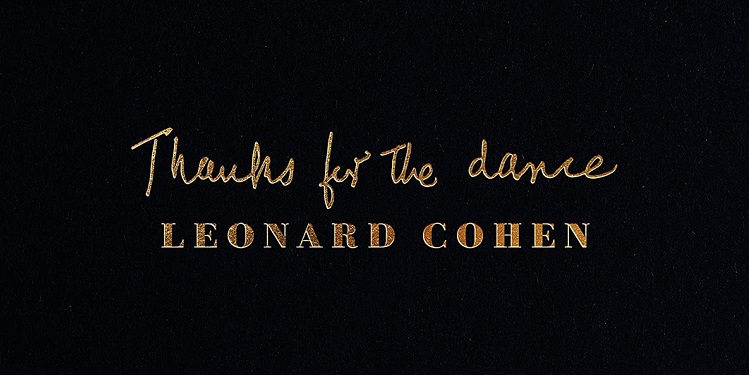Non è vero che sono sempre i migliori che se ne vanno. Tutti ce ne andiamo, prima o poi. Semplicemente, a tutti prende lo scoramento quando è un padre a seppellire il figlio, e non viceversa. Oppure quando un mascalzone continua imperterrito le sue malefatte e i giusti e gli onesti continuano a soffrire. E non è di nessun conforto pensare che prima o poi la corrente del fiume porterà davanti a noi il cadavere del nemico, o del cattivo di turno. Molto più semplicemente, rimaniamo tutti un po’ orfani inconsolabili quando ad andarsene è qualcuno che avremmo voluto tenere sempre con noi. Leonard Cohen era uno di questi.
Qualcuno ha già sicuramente scritto il coccodrillo per la morte di Berlusconi o quella di Trump: si sa, i giornalisti si attrezzano per tempo nei confronti di qualcuno famoso. E quindi sicuramente qualcuno aveva già scritto una bella eulogia funebre in memoria di Cohen. Io, per conto mio, so che questa è una scomparsa pesante perché Cohen ha dato vagonate di poesia al mondo. Dovevano darlo a lui il Nobel per la letteratura, non a Dylan. Tutti i testi di Cohen meritano di stare in cornice, nessuno escluso. Le melodie sono sempre state solo un grazioso, non memorabile, supporto alle sue canzoni. Mi azzarderei quasi a dire che Cohen ha privilegiato di proposito la parola rispetto alla musica, e che questa è stata sempre ridotta all’essenziale, scarnificata, quasi evanescente. Ho sempre identificato Cohen con una malinconia che ha del sublime. Ma poiché ho verificato che la malinconia non è nel mio DNA, anche se ho vissuto e vivo ahimè tuttora in luoghi malinconici per circostanze contingenti, l’ho semplicemente messa da parte. Quando ne ho voglia la tiro fuori in tutta la sua bellezza, talvolta raggelante, la contemplo e poi la ripiego e la metto via. In questo senso ho vissuto Cohen come un fiume carsico che ogni tanto riaffiora, e mi piaceva stupirmi pensando che fosse ancora lì e che non perdesse un colpo, che fosse uno.
L’ultima volta è stato con Natural Born Killer/Assassini nati di Oliver Stone, in cui compaiono due brani come The Future e Waiting for a Miracle. Unbrivido assoluto, pensando alla verità tutta USA di una vita che è uccisione perenne di ogni pace e di ogni bellezza: Ridammi indietro la mia notte sfrenata / la mia stanza con gli specchi / la mia vita segreta / mi sento solo qui / non è rimasto nessuno da torturare. / Dammi il controllo assoluto / su ogni anima vivente/ e stenditi accanto a me, piccola / è un ordine! / Dammi crack e sesso anale / prendi l’unico albero rimasto in piedi / e mettilo nel buco della tua cultura. / Ridammi indietro il muro di Berlino / dammi Stalin e San Paolo / Ho visto il futuro, fratello / È un massacro. Ho avuto diversi sogni agitati dopo aver visto quel film e ancora adesso non riesco a dissociare i brani dalle sequenze filmiche. Non sono solo azzeccati, sono verità evidenti, quasi auto esplicative. Ai tempi accusarono Oliver Stone e anche Cohen di avere composto quasi una Vangelo per violenti, senza rendersi conto del distacco emozionale (che diventa contemplazione estetica) di ognuno dei due autori nei confronti di ciò che rappresentavano e cantavano.
A Cohen hanno rimproverato di tutto, gli statunitensi: di essere ebreo, di essere canadese, di essere buddhista Zen, di passare troppo tempo in Grecia, di avere troppe donne, di essere troppo malinconico, di essere ricco e viziato, di essere anche un po’ contraddittorio, di assomigliare troppo a Dustin Hoffman o ad Al Pacino o di essere troppo un misto tra i due – mi sono sempre chiesto dove stesse il ‘troppo’, e ovviamente non l’ho mai trovato. E adesso che Leonard non c’è più è legittimo chiedersi se dovremo assistere a una macabra consumazione del rito chiamato ‘postumo’. Quel rito in cui case discografiche o manager furbi o tutti e due fanno sgocciolare ogni tanto dei brandelli di poesia o di musica composti dall’artista scomparso, inserendo due minuti di ‘inedito’ in una compilation di brani già editi. È già successo e continua a succedere col povero Nick Drake, cannibalizzato oltre ogni decenza, e continuerà a succedere con tutti i colossi del jazz, da Coltrane a Davis.

È per questo che ho accolto con grande commozione l’uscita di questo album breve e postumo di Cohen. Il figlio Adam Cohen ha affermato categoricamente: “Non ci saranno altri album dopo Thanks for the Dance, questo è tutto. Quando un grande artista muore si cerca ogni minimo frammento, scarabocchio da svendere al pubblico, non in questo caso, non ci sarà nient’altro”. Fatto sta che il materiale che compone quest’album proviene dalle sessioni di You Want It Darker (2016), che a mio avviso era già un testamento d’artista, visto anche che Cohen non riuscì a completarlo per l’insorgenza dei problemi di salute che lo avrebbero portato alla morte.
L’album viene completato dal figlio e questo Thanks for the Dance per molti ascolti ha continuato a fornirmi la sensazione, quasi fisica, di un’opera composta da un ectoplasma. Poi un giorno i tasselli sono andati al loro posto: adesso vivo il disco come un’ultima eco dell’anima quando il corpo è già quasi completamente altrove. La prova è il fatto che tutti gli abbozzi, composti ma non realizzati da Cohen padre, sono diventati canzoni complete perché Cohen figlio li ha presi in braccio e li ha traghettati sulla sponda della vita. Per colmo di fortuna dentro questi abbozzi c’erano dei collaboratori di lusso come Beck, Daniel Lanois, Damien Rice, Leslie Feist, Bryce Dessner dei The National e Richard Reed Perry degli Arcade Fire, che hanno fornito un apporto decisamente minimalista, come se fossero rimasti sulla soglia di una camera funebre, lasciando a padre e figlio il conforto di un’ultima conversazione.
Che comincia con una sorta di memorabile confessione (Happens to the Heart) piena di umiltà: Ho sempre lavorato in modo costante / ma non l’ho mai chiamato arte – sono le parole di un uomo che non ha mai ceduto alla canonizzazione di se stesso e che, semmai, è sempre stato più in confidenza con il Diluvio che con una qualsiasi Arca, consapevole che valeva di più il conquistarsi una fine degna piuttosto che il diritto di non essere d’accordo. Vanitas Vanitatum. I versi sono recitati, più che cantati, come avverrà in tutto il disco, e la base musicale è quasi un contrappunto cameristico minimalistico, quasi un manifesto. Il brano seguente Moving On, è quasi lo specchio del primo, perché è il ricordo della propria musa, l’amata Marianne, regina del lillà e del blu, in cui Cohen uomo riconosce la propria capacità di gettarsi dietro qualunque importanza mondana per gettarsi tra le braccia dell’amore. Se mai, di mondano, sopravvive un lampo quasi malizioso nel ricordo degli umori di lei, che erano una minaccia quotidiana, e la cui bellezza dominava il poeta più per una questione ormonale che estetica (your beauty ruled me / though I knew t’was more hormonal than the view). Anche qui, quasi solo un mandolino e dei lievissimi colpi di spazzola su un piatto. Sufficiente.
Segue: The Night of Santiago è costruita tutta attorno a un’incessante battito di mani in stile flamenco e il ritmico basso di una chitarra hispanica, arricchiti da qualche pennellata di chitarra, quasi un episodico battito d’ali. Fa pensare a un amore passionale sul topos di lui e lei che si spogliano rispettivamente di pistola e cinturone e della propria verginità con lui che la porta al fiume come farebbe ogni uomo. Il brano successivo Thanks for the Dance, io, francamente, l’avrei messo prima della fine: è un valzer romanticissimo, con una sola evanescente chitarra in primo piano, che mi fa pensare a due spettri che ballano sulla superficie di un lago, al chiaro di luna. Ed è un ricordo di cose serie che diventano leggerissime e persino una crisi diventa leggera come una piuma, the crisis was light as a feather. La distanza e la leggerezza può raggiungerle solo chi si è già distaccato, senza malinconia né rimpianti, ma con il gusto indicibile di potersi fermare anche solo per un’ultima e unica volta alla superficie delle cose. È per questo che diventa possibile l’invito ad alzare la musica e a versare il vino, tutte cose molto terrene, perché io e te ci siamo fermati alla superficie e non abbiamo bisogno di andare più a fondo. L’avrei messa alla fine perché è seguito dell’episodio probabilmente più cupo di tutto il disco, It’s Torn, che è intriso della consapevolezza della dissoluzione di tutte le cose, disperse e buttate in ogni dove. E anche se si prova a raccoglierle il risultato è nullo poiché c’è menzogna in ciò che è sacro e c’è luce in ciò che non è più, la storia è già stata scritta, la lettera sigillata, tu mi hai dato un giglio che però ora è un campo.
È la stessa percezione che mi segue nel brano successivo, questo sì che è il vero testamento di un trapassato, The Goal. Il testo è stato scritto nel 2006, ed è contenuto in Book of Longing, una sorta di diario molto intimo di 167 poesie basate sulla riflessione del senso del desiderio. Cohen lo scrisse durante il suo soggiorno presso il monastero Zen di Mount Baldy, in California, dove visse tra il 1994 e il 1999 e i suoi viaggi in India durante la seconda parte degli anni ‘90. Philip Glass nel 2007 trasse 23 poesie dal libro e le pubblicò in un doppio CD Book of Longing. Song Cycle Based on the Poetry and Artwork of Leonard Cohen. Se c’è una spiegazione che possa accumunare i due è solo e soltanto la comune pratica buddhista e la meditazione sul senso ultimo del desiderio: Non posso fermare la pioggia / Non posso fermare la neve / siedo nella mia sedia / guardo la strada / il vicino mi ritorna il mio sorriso di sconfitta / mi muovo con le foglie / splendo con lo splendore / sono quasi vivo / sono quasi a casa / nessuno da seguire / e nessuno a cui insegnare / eccetto il fatto che la meta / si trova poco dopo il raggiungimento.
Ispirazione che ritorna vanitas vanitatum anche nel brano successivo, Puppets, dove nei confronti di vita e morte tutte le cose e le persone, persino nelle relazioni più drammatiche come tra ebrei e tedeschi, non sono altro che un gioco di marionette. Tutti siamo marionette, io te: la notte delle marionette scende giù a recitare il post-atto della recita delle marionette. Cori angelici, percussioni con l’eco.
A un passo dalla fine The Hills è il film di tutta una vita, dove tutto è già dietro le spalle, ed è del tutto inutile lamentarsi o rivendicare: non mi è consentito / nemmeno il segno di un rimpianto / perché qualcuno userà / le cose che non sono potuto essere / il mio cuore sarà ferito / impersonalmente. Anche qui angelici cori gospel in un ritmo quasi di marcia funebre. Siamo alla fine.
In Listen to the Hummingbird c’è un invito all’ascolto profondo della vita, che è come il ronzio basso e impercettibile (hum) del battito d’ali dei colibrì, che non possiamo vedere, ed è effimera come la farfalla che vive solo tre giorni. Qui la musica è un’eco lontanissima di piano appena sfiorato, come sfilacci di nuvole mosse dal vento.
So long, Leonard.