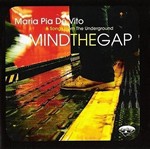
Se ci sono degli scrittori a cui mi piacerebbe assomigliare? Come no? Bene: (dopo attento rimuginare) vorrei essere un condensato tra Gadda, Borges, Manganelli e Beniamino Placido. Non sto a spiegarvi in dettaglio il perché e il percome, ma sappiate che c’è una cosa in cui (ancora) non riesco e che loro invece sapevano fare meravigliosamente: interrogarsi in modo straordinario su fatti e fatterelli della vita così come su destini cosmici prendendo assolutamente tutto sul serio e assolutamente tutto nel suo contrario.
A mo’ di tentativo potrei partire da una storiella di (fine) umorismo bolognese: da quelle parti, come appresi, l’umorismo spesso eccelle nella medietas, nella virtù cioè di mettersi nel mezzo ed eliminare gli estremi – dopo averli accettati – solo per il fatto che se ne fa malamente uso, meno spesso per semplice cattivo gusto (di una donna bruttissima si dice per esempio: va bene essere brutta, ma lei lì se ne approfitta).
La storiella in questione racconta dunque di un uomo divenuto prematuramente vedovo causa un colpo al cuore patito da sua moglie. Mentre i necrofori portano via la bara ancora scoperchiata giù per le scale (presumo strette e malagevoli, di una vecchia casa del centro), durante una giravolta uno di essi scivola e la bara prende un gran colpo contro lo spigolo del muro. La moglie si tira su dalla bara: un caso di morte apparente, come si dice, un caso di quelli da scuola. Il marito rischia l’infarto, la moglie invece stavolta l’infarto ce l’ha davvero, all’intendere in pochi secondi quel che le è successo. I necrofori (una volta si chiamavano becchini, adesso ci sono le specializzazioni e il politically correct) ricompongono la donna nella bara sudando freddo. Il marito, con uno sguardo pieno di sottintesi, si rivolge al necroforo che è precedentemente scivolato e dice: «Occ ai spiegul» (occhio agli spigoli).
Ora, ecco l’interrogativo: il marito cerca educatamente di mettere in guardia contro la possibilità che il fatto si ripeta, in modo da evitare di prendersi un colpo (magari fatale) per la seconda volta? Oppure dobbiamo supporre che non vi fosse buon sangue con la defunta, e quindi il marito vuole sottilmente e ambiguamente evitare, con l’avvertimento di cui sopra, di tornare a essere regolarmente sposato, una volta che il fato l’aveva (finalmente) liberato della moglie?
Nel primo caso la medietas a cui accennavo sortirebbe l’effetto comico (ancorché sottile e venato di melanconia tutta padana, invero) con le modalità esatte con cui l’avevo descritta. Nel secondo l’ambiguità interpretativa non sarebbe del tutto da scartare, dovendo supporre che in nome della medesima medietas il fresco vedovo eviti – perlomeno sino a interramento compiuto! – di far festa.
Sono anni che mi hanno raccontato la storiella, e ancora non so decidermi per una delle due soluzioni. È pur vero che, come ha detto una volta Lucio Dalla, i bolognesi sono dei deliziosi figli di p… quando vogliono; ma è d’altra parte vero che sino a prova contraria e definitiva condanna si è innocenti, in questo Paese (non so ancora per quanto, ma insomma). Resta il fatto che in questa vita gli spigoli sono ancora la regola, specie per chi prende la vita ‘di petto’ o ‘di punta’, e non l’eccezione, e che gli spigoli arrotondati, semmai si (ri)trovano solo nei vecchi ospedali psichiatrici in funzione preventiva.
Ancora peggio va se parliamo dei gradini. Oltre alle case e alle scale, vecchie e pieni dei suddetti, ci sono luoghi fisici, ma soprattutto psichici, dove la loro presenza è congenita.
Guardate la differenza semantica, non da ridere: noi parliamo di gradini riferendoci al tardo latino curiale gradale o graduale, che indicava la scalinata che saliva progressivamente all’altar maggiore, a un tempo sintomo e simbolo di un’ascesi dell’anima, ma anche termine traslato per indicare il messale; gli inglesi o gli anglofoni se la cavano parlando di gap, ovvero, letteralmente, un dislivello o, ancora, più scientificamente, una differenza tra piani sfalsati.
Non c’è dubbio che il secondo termine sia più incisivo del primo, e non tanto perché qui da noi s’è oramai da tempo dimenticato l’etimo, quanto per il fatto che gap indica proprio tutte le situazioni della vita in cui è all’opera una differenza: modi di sentire (un ‘io’ del dover essere staccato da quello dell’essere), sentimenti (due ex fidanzati oramai tra loro incomunicanti) o anche posizioni nel mondo, e via discorrendo sino alle semplici quantità numeriche, per quanto dotate di rilevanza sociale: tra me che rubo una mela e rischio il massimo della pena, specie se extracomunitario, e un capitano d’industria che falsifica il bilancio e va esente da pena, specie se ha mosso ingenti capitali, c’è evidentemente un gap. Non solo perché la seconda azione incide su più persone mentre la prima coinvolge solo me, misero mariuolo, ma anche perché sempre più la mente dei legislatori mostra un gap devastante con il buonsenso: la maggior pena dovuta fino a poco tempo fa al capitano d’industria si giustificava col maggior allarme sociale delle sue azioni truffaldine; ora, invece, chi fa girare soldi, è guardato con maggior favore – o maggiore indulgenza – di chi non solo soldi non ne fa girare, ma proprio non può farne girare, essendo sprovvisto dei suddetti soldi in assoluto.
Dunque la vita è piena di gap, ecco la conclusione, e quindi per forza di cose bisogna essere continuamente mindful, cioè consapevoli e attenti, almeno per evitare distorsioni alle caviglie, come avverte una metallica voce sulle banchine della metropolitana londinese prima dell’arresto del treno: Mind the gap, mind the gap, mind the gap…. Solo allora affiora una dimensione dell’essere finalmente coerente con se stessa, e forse una pace interiore…
Detto questo, e per le stesse ragioni, mi faccio e vi propongo di farvi un regalo. Mind the gap di Maria Pia De Vito, proclamato recentemente miglior disco jazz italiano del 2009, merita ascolti ben più che attenti. Al di là della soddisfazione di essere una volta tanto d’accordo con i critici nazionali, potrete infatti regalarvi il puro e semplice piacere di ascoltare un disco sicuramente e finalmente allineato con le migliori produzioni internazionali.
È il disco della maturità artistica completa per la deliziosa cantante napoletana. Completo, in questo caso, significa che stavolta c’è dentro assolutamente tutto quello che potreste pretendere da una grande interprete e da un grande disco jazz contemporanei.
Innanzitutto un plauso al coraggio di assumere suoni elettronici non come puro rumore o colore, ma come parte integrante della frase musicale (tutt’altro che scontato in un disco di jazz). In secondo luogo la scelta dei brani: composizioni originali della De Vito, che dimostra ancora una volta di più scienza, gusto e originalità nella scrittura, specie nei testi (I invented you); omaggi al grande rock (If six was nine) – a dimostrazione che nessuno, ma proprio nessun musicista che voglia dirsi tale, può esimersi dal confronto con Hendrix, specie se lo si rilegge dal lato jazzistico, grazie al comune linguaggio del blues (e quando scoprite che l’assolo di quella che pensate sia una chitarra è in realtà il sassofono di Francesco Bearzatti opportunamente elettronizzato, capite che cosa voglio dire); ancora: omaggi alla grande canzone pop-rock d’autore da un lato con un capolavoro di Tim Buckley (Song to the siren, anche se purtroppo la associo ancora a una voce maschile) e dall’altro con un geniale ‘scongelamento’ di Bjork tramite cori africani à la Zap Mama sovrapposti a elettronica fredda (Hidden place): tra l’altro il brano è quasi del tutto improvvisato, mai provato in precedenza e dal vivo – a dimostrazione del potenziale ancora tutto da scoprire dei giovani membri del gruppo di accompagnamento della De Vito (Songs from the underground, in specie l’ottimo Claudio Filippini al piano). Abbiamo ancora dimostrazioni della capacità di un uso spregiudicato ed efficacissimo dell’elettronica in chiave rumoristico-percussiva mentre la voce disegna eleganti linee jazzy declamate e cantate (Opening doors), e più ancora elettronica in chiave pressoché jazz-acrobaticocubista di Eccesso (forse memore della grande lezione di Monk da un lato e del Frisell di Unspeakable dall’altro). Il resto è pura lirica, tra gli spaesamenti di I invented you, qualche nevrosi (Opening doors) un profumo di Tom Waits (I think it’s going to rain today), un’introspezione dedicata a Betty Carter (Mind the gap), una dovuta ad Anders Jormin (In winds) e un’ultima ad Annie Lennox (No more ‘I love you’s’ via J. Hughes e D. Freeman).
Insomma, una bella lezione per quanti associano ancora il jazz a una formula prestabilita e immobile. Da anni sostengo che il jazz è un’attitudine prima ancora che un linguaggio, e che quest’ultimo a sua volta è (forse) l’unica chiave rimasta ai musicisti occidentali per espandere i propri orizzonti, che si tratti di rileggere le più banali canzoni pop o di risolvere inusitate improvvisazioni radicali sull’onda dell’atonalità assoluta…
Ecco qua: il modo di risolvere ogni gap dei miei amati Gadda, Borges, Manganelli e Placido me lo ritrovo pari pari in questo Mind the gap: l’ho sempre detto che è la musica che mi salva la vita, prima d’ogni altra cosa…
Maria Pia De Vito & Songs From The Underground
Mind the gap, EmArcy, 2009
