| di Luciana Viarengo |
Recensione de Il Rapporto, Philippe Claudel
Brodeck non è uno scrittore. Semplicemente stila rapporti sull’ecosistema montano delle sue valli per una non meglio precisata Amministrazione. Come capita a molti scrittori, però, se da un lato gli riesce difficile e doloroso portare alla luce i pensieri profondi attraverso la parola detta, quando scrive gli sembra che le parole divengano docili e gli mangino in mano come uccellini. Inoltre Brodeck possiede una vecchia macchina per scrivere.
Sono queste le due condizioni che, ufficialmente, faranno di lui il prescelto, colui che verrà, suo malgrado, investito dell’onere di redigere il rapporto. Di tale documento noi lettori non leggeremo neppure una singola parola poiché Brodeck, insieme al compito che ha dovuto accettare, scrive parallelamente una versione segreta e personale dell’Ereigniës – ovvero “la cosa che è successa”. In questo vocabolo arcano e pieno di nebbia, come in tutte le altre parole espresse nel patois locale dalle forti assonanze tedesche, si concentra l’ombra scura, di minaccia annunciata, che si allunga fin dalla prima pagina su tutta la narrazione.
È questa la versione che Brodeck nasconde ai sospettosi compaesani ma condivide con noi. E questa lunga ricostruzione, anziché un documento asettico e formale come quello richiestogli, diviene un’affabulazione immaginifica di ingannevole semplicità e di grande forza evocativa, che ci afferra le spalle e ci spinge, rapiti, verso quell’orrore il cui alito guasto abbiamo percepito fin dalla prima pagina, un orrore che siamo ormai abituati a elaborare come ‘esterno’, ma che ci diviene insopportabile se costretti a riconoscerlo come peculiare, come un tratto dell’umano al quale nessuno di noi può sottrarsi. Proprio questo ci obbliga a fare Brodeck, a prendere atto di come nessuno sia immune da questa tara: dalla ferocia e dalla vigliaccheria istintive che l’uomo riserva a tutto quanto si frapponga fra lui e la sua sopravvivenza; dal male che per quanto frenato e occultato dalle regole del vivere civile cova dentro di noi, pronto ad esplodere ogni qualvolta ci sentiamo, a torto o a ragione, minacciati.
Ecco perché la memoria è spesso un onere difficile da sopportare e va rielaborata, rivestita di retorica, disinnescata del suo potenziale distruttivo, perché si possa continuare a sopravviverle. La comunità non è altro che un crogiolo nel quale i liquami individuali convogliano e potenziano le loro capacità corrosive, corrompendo ulteriormente la coscienza dei singoli qualora sorgano eventi esterni a causarne il cortocircuito. La folla come moltiplicatore del male. Non è un caso che il curato di questo piccolo villaggio incastonato tra le montagne sia costretto a ubriacarsi, per dimenticare quanto gli viene riversato nelle orecchie sotto il segreto della confessione. Il tutto nel silenzio assordante di un Dio che non c’è.
Sembra proprio non esserci spazio per la grazia e la bellezza in questo potente romanzo di Philippe Claudel – Il Rapporto, appunto, edito da Ponte alle Grazie – così come non sembra esserci redenzione per un’umanità vittima e carnefice, che tenta di sanare le proprie ferite infliggendone altre.
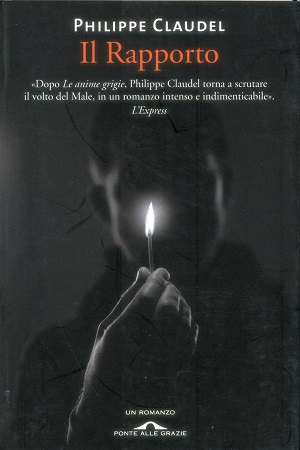
In una narrazione che volteggia intorno ai fatti più atroci con la potente leggerezza delle immagini, persino il paesaggio in taluni momenti capace di “dolcezza e tinte bionde”, pulsante di erba nuova, di bocche di leone e nuvole frettolose spinte dal vento – si fa più aspro, complementare all’umanità dura e difficile che raccoglie, coi suoi boschi assediati dalla nebbia e chiusi tra i picchi altissimi delle montagne, flagellato da eventi meteorologici estremi come nevicate epocali o estati di fornace in cui anche la comunità diviene un’enorme bestia sfinita dall’afa e dalla sete di sangue.
Si è da poco spento il rombo dei cannoni e l’umanità cerca disperatamente di rivivere dimenticando l’incubo e le atrocità, quando nella piccola collettività montana giunge l’Anderer – l’altro – del quale non si saprà mai il nome, perché nessuno gliel’ha mai chiesto a parte il sindaco, una volta, senza ottenere risposta. Non si sa da dove arrivi, questo ricco uomo bizzarro e riccioluto, dal volto di biacca e dagli occhi bistrati da teatrante, che è giunto al villaggio non per caso, ma proprio cercando quel luogo, e vi approda in un tardo pomeriggio di primavera, accompagnato da un mulo e un cavallo la cui docilità e il cui sguardo umano solleciteranno brividi superstiziosi.
Il compito di Brodeck è farci sapere che è arrivato e che, alla fine, ha pagato il suo crimine, quello di essere diverso, silenzioso, carismatico.
Non fa nulla l’Anderer, se non passeggiare silenzioso e sorridente per il paese, con un calepino nel quale annotare frasi, appuntarsi particolari e abbozzare schizzi; azzimato e cortese in un contesto assediato dalla brutalità e dall’ottusità che cementano come malta dura la vita montana.
Non ha colpe l’Anderer, se non quella di restituire, più e meglio di uno specchio, la vera personalità di chi gli sta davanti. E gli specchi, si sa, finiscono per rompersi.
Governare la scrittura o possedere la vecchia macchina per scrivere, sempre pronta a grippare e coi tasti rotti, non sono le sole ragioni per le quali Brodeck viene chiamato a narrare l’accaduto. Dal suo racconto spiraliforme, scopriremo che lui stesso è un ‘altro’, diverso reso reietto dalla Storia, capace quindi di guardare agli eventi con la prospettiva di chi è estraneo al gruppo, di chi ne ha già subito il danno. Ha imparato a camminare rasente ai muri, rendendosi invisibile agli occhi degli altri. Non è fiero di questo, Brodeck, anzi, prova molto spesso un senso assai simile al disprezzo per questa sua acquiescenza, ma non vede alternative: il desiderio di sopravvivere sempre e comunque lo ha portato ad accettare situazioni altrimenti inaccettabili.
Anche lui, come l’Anderer, è sensibile e possiede una ricchezza interiore che agli altri risulta molesta. I suoi silenzi, esattamente come quelli dell’Anderer, sono oscuri e minacciosi per una comunità che vuole solo dimenticare e riprendere a vivere, seppellendo definitivamente le colpe. Sarà proprio questa necessità a ‘giustificare’ il crimine collettivo.
Da questo fatto di orrore, locale e circoscritto, che gli è imposto di narrare “affinché colui che leggerà il Rapporto capisca e perdoni”, Brodeck con un andirivieni continuo tra ricordi remoti, presente e passato appena concluso, con un incedere caratterizzato da partenze morbide e inversioni altrettanto delicate, riconduce il lettore a un ‘prima’, all’orrore mondiale della guerra e dei campi di concentramento. Ma dimenticate il già letto, la retorica e la letteratura sull’Olocausto: in questo romanzo i fatti hanno assunto una dimensione universale e senza tempo, nella quale nulla viene etichettato con nomi consueti o proposto come una porzione di cibo precotto scodellata dalla mensa ideologica. La scrittura di Philippe Claudel, capace di appagare profondamente il lettore perché così pacata e dolce, così musicale ed evocativa anche quando dipinge l’atroce, compone un ritratto della bassezza umana, netto e scarnificato come un teschio, e completamente slegato da qualunque tipo di appartenenza, sia essa geografica, politica o religiosa.
Con un magistrale gioco prospettico, quanto più si amplia lo scorcio sulla Storia, tanto più ci si addentra nella storia personale del narratore e si fa via via più distinta la percezione di quanto l’abisso non sia solo quello nel quale il mondo è precipitato, ma anche quello che Brodeck – e con lui ogni essere umano – si porta dentro, vittima e carnefice insieme.
Non mancano, nel romanzo, figure che inizialmente sembrano sfuggire a questo paradigma, incarnando un’anomalia positiva della terribile umanità che le circonda – e sono più spesso figure femminili – come la figlia di Brodeck, la piccola Poupchette, figura archetipica di grazia innocente; Emélia, la bellezza e l’amore, depositaria di un futuro di speranza; Fédorine, surrogato di madre e radice aerea di Brodeck, che lo ha raccolto bambino dalle macerie fumanti di un altro conflitto e che rappresenta il nume tutelare della sua casa. Ma chi lotta per non soggiacere allo stigma di vigliaccheria e di crudeltà che segna l’essere umano paga sempre un prezzo molto alto.
Nel momento cruciale della decisione, Brodeck guarda le sue donne: “Una dormiva come se non fosse ancora nata, la seconda cantava con aria assente, la terza mi parlava come se non ci fosse già più”. È la prima, Poupchette, più ancora che la dolce Emélia sopraffatta da un peso impossibile da sopportare e la vecchia Fédorine ormai logorata dalla vita, a rappresentare, testimone ignara, le ferite inferte dalla Storia, e a dimostrare che se è possibile evitare di divenire carnefici, non si può invece sfuggire al proprio destino di vittime.
In una sorta di metascrittura legata alla stesura del rapporto, e nel destino che a quelle pagine verrà riservato, è possibile ravvisare una riflessione sul ruolo della scrittura nei confronti della Storia, proprio in quella figura di narratore che non sceglie spontaneamente di raccontare ma che è obbligato a farlo, e che diviene consapevole strada facendo dell’importanza del suo racconto – non a caso ritroviamo un citazione di Primo Levi: “raccontare è una medicina sicura”.
La memoria è un pericolo, la rimozione è la chiave di pacificazione che molti scelgono, ma al termine della sua narrazione, in un epilogo struggente, Brodeck sostiene che la macchina per scrivere non gli serve più. Adesso scrive nel suo cervello. Non c’è libro più intimo e non dovrà più nasconderlo. Perché Brodeck, a differenza degli altri, non vuole dimenticare. E se c’è un cenno di speranza in questo romanzo di cuori neri è proprio nella decisione finale di Brodeck, nel desiderio di non rimuovere e di riuscire, dopo aver fissato le tenebre, a intravedere la luce e riprendere il cammino.
Il Rapporto, Philippe Claudel, Ponte alle Grazie, 2008


