Jazz ad alte latitudini
Sembra quasi scontato dire che ‘un giorno’ qualcuno scriverà la storia di questa pandemia. Utilizzeranno gli strumenti della ricerca sociologica, storica, medica. È sicuro. Meno sicuro il fatto che qualcuno potrà scrivere la storia musicale della pandemia. Per conto mio, già parlando con amici vicini e lontani, mi sono reso conto che l’enormità di tempo a disposizione delle persone ha portato moltissimi di noi a frugare nel proprio archivio e a ri-ascoltare materiali che forse si erano dimenticati. Che poi qualcuno se ne venga fuori con una compilation degli album pubblicati a fatica durante il lockdown, a me interessa poco. Mi interessa di più ascoltare le storie personali e capire, semmai, che valore aveva l’ascolto.
Non è la prima volta che da queste colonne predico contro l’eccesso della civilizzazione visiva in cui siamo immersi. Ultimamente qualcuno pare accorgersi che i nostri figli e nipoti sono un po’ troppo esposti (leggi: li abbiamo lasciati esposti) a un bombardamento visivo inusitato. Per bilanciarlo, a mio modestissimo avviso, bisogna operare su due fronti. Il primo è quello della cultura fisica; appropriarsi cioè nuovamente di una percezione diffusa del proprio corpo. Non mi interessa la tecnologia, né l’arte che si va a praticare. L’importante è muoversi con consapevolezza. Il secondo fronte è quello dell’ascolto. Non mi stancherò mai di ripetere che, avessimo anche solo un flash di intuizione di quanto sia magico ascoltare un qualunque suono, non saremmo mai sazi di porgere l’orecchio. Ma si sa, l’educazione scientifica in questo Paese è carente. Per cui, se si prova a spiegare a qualcuno in cosa consista scientificamente un suono, il meglio che vi possa capitare è un moto d’impazienza e una scrollata di spalle. E se chiedete a qualcuno perché gli piaccia la musica, qualunque sia, alla fine gratta gratta viene fuori la solita risposta: perché mi intrattiene.
Nelle grandi città il silenzio è qualcosa da respingere quasi con orrore. Eppure i metropolitani sono costantemente bombardati da un numero spaventoso di rumori, suoni sconnessi, discorsi, con la musica che talvolta fatica a farsi strada. Eppure, i due metropolitani milanesi che avevo incontrato anni fa a Stromboli e che avevo cortesemente accompagnato a guardare il sorgere della luna in una spiaggetta deserta, non erano scappati il giorno dopo perché avessero qualcosa di più importante da fare. No, erano scappati perché c’era troppo silenzio. La cosa mi aveva fatto ridere ma a distanza di tempo mi aveva lasciato la bocca amara. Per cui mi sono convinto che senza passare da un estremo all’altro (nessun suono vs troppo suono) l’educazione all’ascolto sia parte fondamentale della nostra esistenza.
Ovviamente, non parlo solo della capacità di ascoltare e godere un brano musicale. Qualcuno, non ricordo più chi, ha detto che Casanova era un grande seduttore perché sapeva ascoltare le donne. Ma anche senza voler sedurre a tutti i costi, rimane il fatto che ascoltare veramente chi ci sta davanti consente di eliminare un sacco di problemi alla radice, oltre che preparare il terreno per una bellissima esperienza di condivisione.
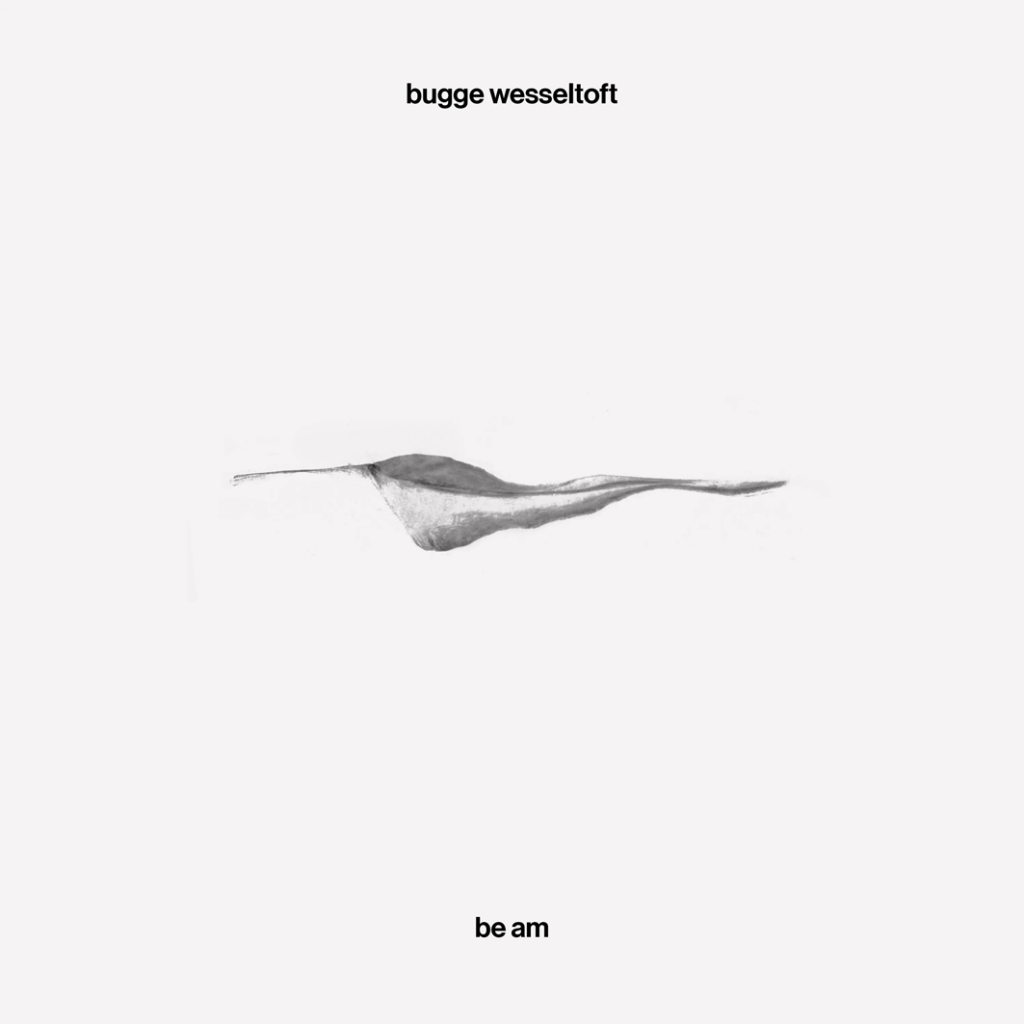
Ho premesso tutto questo perché c’è un album, che ho ascoltato più e più volte durante la pandemia (specie verso la fine della stessa) che mi ha costretto ad ascoltarlo per apprezzarne in pieno l’intento e il sapore. L’autore è un singolare musicista norvegese a nome Bugge Wesseltoft, classe 1964. L’album si chiama Be Am. Non posso fare meno, quando lo ascolto,di percepire costantemente l’effetto di un fuoco sotto il ghiaccio; ed è una cosa che mi succede spesso con i musicisti jazz scandinavi, norvegesi e svedesi in testa. Per il rock e l’elettronica bastano e avanzanoBjork e i Sigur Ros. Per il jazz invece bisogna stare attentissimi, perché il numero di musicisti di alta classe sfornati negli ultimi trent’anni a quelle latitudini è stupefacente, a dir poco. Non so se sia una sorta di effetto traino degli album della benemerita ECM registrati a Oslo, specie quelli con musicisti locali: dalla star internazionale Jan Garbarek ad Aril Andersen, ai compagni di Miles Davis nell’European Quartet come il già citato Garbarek, Palle Danielsson e Jon Christensen, da Terje Ripdal, il trio di Esbjörn Svensson, a Eivind Aarset e Nils Petter Molvaer. Ho sentito qualcuno, e mi sembra poco tacciarlo di sterile sciovinismo, dire che questi scandinavi mancano del cuore mediterraneo o che non riusciranno mai a suonare del jazz perché non sono neri e non capiranno mai il blues. Una volta mi incazzavo di brutto, adesso al massimo gli dico di andare dall’otorino. Se proprio voglio tagliare di netto, replico che il mio interlocutore dovrebbe imparare ad ascoltare col cuore, visto che l’ha tirato in ballo lui, e non attraverso paraocchi intellettuali. Balle. Troppe.
Accendo lo stereo, sprofondo sul divano e apro le mie due finestre laterali. Arrivata la pandemia del 2020, Wesseltoft è stato coinvolto in un clima di paura molto diffuso, in cui era lui a doversi prendere carico della sicurezza dei suoi cari a tutti i costi. Se il contesto intorno è quello dell’ansia, i corvi che girano sono le teorie del complotto. Mi pare normale che, per un musicista sensibile, la musica diventi più che un semplice rifugio: piuttosto, un tonico dell’anima. Ho visto molti musicisti comporre ed eseguire brani a distanza con i membri del proprio gruppo, cuffie in testa e tecnico del suono a fare i salti mortali. Bugge ha scelto una strada molto nordica, quella dell’introspezione.
La prima cosa che salta fuori è che c’è una differenza palpabile tra una pace naturale e diffusa, dentro e fuori di noi, e una pace imposta dall’alto. Ancora peggio se questa pace dobbiamo imporcela per non impazzire. Vado di sghimbescio, dopo il buio iniziale di Resonate e mi trovo fortemente ispirato da Life, un interplay di risonanze tra piano e kalimba che ha il potere di trasportarmi in un bosco, dove la luce entra di taglio. La kalimba di solito ha un suono tipicamente acquatico, ma stavolta è di acqua cristallina ed esegue una serie di note in moto circolare, mentre il piano, passettino dopo passettino, esita a trovare una sua strada: non è un’elegia ma nemmeno un canto triste. La mente si avvita dietro un pensiero creativo ma ancora avvolto su se stesso, mentre il cuore spalma una mestizia trattenuta. Qui ho trovato il cuore dell’intero album, perché Bugge ha assimilato completamente, digerito ed evoluto la lezione di due elegiaci per eccellenza come il Keith Jarrett del Köln Concert e l’Abdullah Ibrahim dei brani più solenni come il celebre The Wedding.
Se assumiamo questo brano come il baricentro di tutto l’album potremo muoverci avanti e indietro, raggruppando i brani tra quelli più meditativi e sognanti come Tide, dove una stupenda melodia torna e torna continuamente con piccole variazioni, proprio come una marea, e i brani che assomigliano a un’oscura meditazione notturna, realizzata da accordi discendenti e più profondi, ma che non vanno da nessuna parte come in Deeper. Sono due brani che prendono direzioni completamente diverse e trascinano con sé due trend di stati d’animo conseguenti. Al primo gruppo appartiene State che è jarrettiana che più non si può, ma averne sempre così ispirati di brani! Eppure è un pezzo che lascia percepire una sorta di oscura agitazione, appena dissonante.
E che dire di Roads, che è rimpianto sognante di percorsi possibili, strade perse nella nebbia, da collina a collina, con il dolce controcanto ispirato del sax del bravo complice Hakon Kornstad. Vorrei avessero continuato per un’altra mezz’ora! Stessa categoria per Messenger, persino ovvia, quasi didascalica nel far seguire alla premessa una fotografia dei tempi presenti. Si vede, si sa che c’è la luce in fondo al tunnel. E se il percorso è ancora pieno di inciampi il cuore vuole, fortemente, arrivare in fondo e progressioni tonali così idilliache inciampano a loro volta, per arrestarsi bruscamente. C’è ancora strada da fare. Gli spigoli armonici di Emerging, pur dentro un magico piano elettrico, son lì a testimoniarlo.
Green registra altre progressioni, prima timide poi più decise, e Be Am è piena di ombre musicali; c’è persino una specie di elevarsi verso un gospel per poi tornare a una sorta di pozza stagnante. Gonna Be Ok è anch’essa quasi didascalica (e jarrettiana), un volersi dar coraggio allargando le braccia e le mani a cercare solidarietà, anche se si sa che non c’è nessuna mano da stringere. Sunbeams Through Leaves Softly Rustling ci fa tornare di nuovo al bosco e alla sua luce di taglio, ma stavolta c’è una piccola radura: è la semplice e bellissima melodia che sa di Eric Satie e che improvvisamente mi lascia a mezz’aria come in una piazza di De Chirico. Solo che qui ci sono alberi e rocce, laghetti e sabbia.
“La musica di Be Am porta fantasmi di incertezza, sussurri di rassegnazione e deboli echi di frustrazione. Ma dappertutto ci sono raggi di speranza, una calda luce chiara di pace e tranquillità, e fiamme crescenti di un fuoco inestinguibile di determinazione. È musica di e per l’anima umana” (dal sito https://www.buggewesseltoft.com/be-am-2022).


