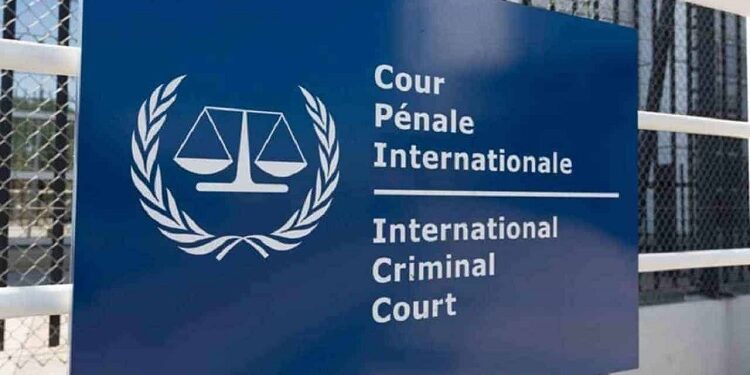Crimini di guerra in Ucraina: le richieste degli Stati Uniti, le risposte della Russia. Il funzionamento della Corte penale internazionale e il suo rapporto con il Consiglio di Sicurezza dell’ONU: come e perché non può dirsi indipendente
“In base alle informazioni attualmente disponibili, oggi posso annunciare che il governo degli Stati Uniti ritiene che i membri delle forze armate russe abbiano commesso crimini di guerra in Ucraina.” Antony Blinken, Segretario di Stato americano, il 23 marzo 2022 rilascia un comunicato con cui chiarisce che il Dipartimento di Stato si dice disponibile a supportare ogni iniziativa internazionale finalizzata a ottenere giustizia. “Come con ogni presunto crimine”, continua Blinken, “la responsabilità di accertare la colpevolezza in casi specifici è competenza di un tribunale che ne abbia giurisdizione. Il governo degli Stati Uniti continuerà a raccogliere segnalazioni di crimini di guerra e a condividere opportunamente le informazioni con gli alleati, i partner e le istituzioni e organizzazioni internazionali. Ci impegniamo ad accertare ogni responsabilità usando ogni mezzo disponibile, procedimenti penali inclusi” (1). Alle dichiarazioni di Blinken fanno eco, pochi giorni dopo, quelle del presidente Biden: definisce Putin un “criminale di guerra” e ribadisce la necessità di raccogliere informazioni “per poter istituire un processo per crimini di guerra” nei confronti delle forze armate russe (2).
I crimini di guerra – insieme a genocidio, crimini contro l’umanità e atto di aggressione – rientrano sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale (CPI), tribunale permanente in sede all’Aja in funzione dal 2002 che proprio gli Stati Uniti – ma non sono i soli – non riconoscono: dopo aver firmato lo Statuto di Roma che l’ha istituita, infatti, appena la Corte è entrata in pieni poteri gli USA hanno ufficializzato la decisione di non ratificare l’adesione. Una decisione che resiste tutt’oggi, e ha quindi del paradossale la presa di posizione dell’Amministrazione Biden nei confronti dei presunti crimini commessi dalla Russia di Putin in Ucraina. Non solo. La posizione espressa dai rappresentanti del Senato statunitense è ancora più esplicita. Con una risoluzione presentata il 2 marzo dal repubblicano Lindsey Graham – e approvata all’unanimità il 15 dello stesso mese – il Senato “incoraggia gli Stati membri a chiedere alla Corte penale internazionale o altri tribunali internazionali idonei di adottare ogni misura possibile per indagare crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi dalle forze armate russe […] ai comandi del presidente Vladimir Putin” (3). Gli Stati Uniti dunque chiamano direttamente in causa la CPI.
Pochi giorni prima, il 28 febbraio, il Procuratore della Corte dell’Aja, Karim Khan, aveva annunciato di voler aprire un’indagine in Ucraina “il più velocemente possibile” a causa dell’intensificarsi del conflitto, specificando di poter “accelerare ulteriormente le cose” se uno Stato membro gli avesse garantito il mandato per investigare (4). Il 2 marzo, lo stesso giorno della risoluzione del Senato USA, rende noto che 39 Stati membri – tra cui l’Italia – hanno segnalato al suo Ufficio la situazione in Ucraina (5), Paese che non ha mai ratificato lo Statuto ma che nell’aprile 2014 – dopo il referendum del marzo 2014 che ha sancito l’annessione della Crimea alla Russia – ha riconosciuto la giurisdizione della Corte per investigare su presunti crimini commessi dal 21 novembre 2013 (6). Ben 39 Stati, quindi, hanno prontamente risposto ai solleciti del Congresso statunitense e del Procuratore. Khan decide dunque di aprire un’indagine a partire dal 2013. Una scelta ben vista dagli Stati Uniti, che per voce del Dipartimento di Stato si dicono disposti persino a valutare una cooperazione con la CPI: “Accogliamo favorevolmente la decisione. […] Stiamo considerando tutte le possibili opzioni per accertare le responsabilità dei crimini” (7).
Tuttavia, è proprio la necessità di cooperazione da parte dei Paesi a costituire uno dei limiti all’azione della Corte. Se è vero che la posizione dei governi nazionali riesce a influire sulla sua autonomia, questi limiti non sono imputabili solamente agli interessi politici dei diversi Stati. È il medesimo Statuto, vedremo, a fare della CPI uno strumento di diritto internazionale sostanzialmente incompiuto.
Corte penale internazionale
Conferenza di Roma, 1998: dopo anni di confronti, una serie di incontri diplomatici all’ONU e la creazione di una commissione ad hoc, 120 Paesi votano a favore dell’adozione dello Statuto di Roma, trattato che istituisce la Corte penale internazionale entrato in vigore il 1° luglio 2002 e ratificato, a oggi, dai 123 Paesi che costituiscono l’Assemblea degli Stati membri.
Determinata “a porre fine all’impunità” e “contribuire alla prevenzione” dei crimini (8), la CPI è una Corte di ultima istanza – interviene solo quando gli Stati membri non abbiano la volontà o la capacità di procedere – che indaga e processa gli individui accusati di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità e, dal 2018, crimine di aggressione. È un organismo indipendente ed esercita la propria giurisdizione sugli atti commessi da un cittadino di uno Stato membro e/o perpetrati sul territorio di uno Stato membro, anche a opera di individui con nazionalità di un Paese non aderente alla CPI; oppure commessi da un cittadino o sul territorio di uno Stato che non ha ratificato lo Statuto ma ha accettato la giurisdizione della Corte – come è il caso dell’Ucraina.
Per condurre le indagini si avvale di un Procuratore – assistito da uno staff di circa 380 persone – che esamina le situazioni in cui si ha il sospetto che siano stati commessi reati di competenza della Corte: il suo intervento può essere richiesto da uno Stato membro o dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC, United Nations Security Council), con cui la CPI mantiene un accordo di cooperazione. Se il Procuratore ritiene che ci sia una base ragionevole per avviare un’indagine, è tenuto a darne notifica allo Stato che ha giurisdizione su quei crimini, che può chiedere di condurre le indagini in autonomia: in caso contrario, o se valuta che non sussistano le condizioni perché il Paese porti avanti l’iter processuale genuinamente e nel pieno delle sue capacità, il Procuratore procede. Può inoltre avviare inchieste proprio motu, con l’apertura di un’indagine su iniziativa autonoma, previa autorizzazione dei giudici della sezione preliminare – che insieme ai componenti della sezione processuale costituiscono il comparto giudiziario della Corte.
Una volta raccolte prove sufficienti per procedere all’incriminazione, il Procuratore chiede ai medesimi giudici della sezione preliminare di emettere un mandato di comparizione o di arresto (se lo ritiene necessario) nei confronti del sospettato, e conduce infine l’accusa durante il dibattimento. Ed è questo il punto fondamentale. Non potendosi svolgere in absentia – come prescrive l’articolo 63 dello Statuto di Roma – per avviare il processo è richiesta necessariamente la presenza dell’imputato: a questo scopo la CPI si rimette all’obbligo di cooperazione che investe gli Stati membri, non beneficiando di una forza di polizia propria. Paradossalmente, però, sono le stesse disposizioni contenute all’interno dello Statuto che pongono i maggiori limiti alla piena realizzazione di questo fondamentale obbligo.
I limiti degli articoli 98 e 63
L’articolo 98 dello Statuto stabilisce che la CPI non può chiedere a uno Stato membro la consegna di un individuo di un Paese terzo se ciò lo porta a violare l’immunità personale e diplomatica di quel cittadino, riconosciuta dal diritto internazionale a capi di Stato o di governo, diplomatici o funzionari in missione all’estero (primo comma); oppure ad agire in maniera discordante rispetto agli obblighi stabiliti dagli accordi internazionali siglati con uno Stato terzo, in base ai quali il consenso di quest’ultimo è necessario per procedere alla consegna di un suo cittadino alla Corte (secondo comma). In termini generali: se il cittadino di un Paese che non riconosce la Corte dell’Aja viene imputato di aver commesso crimini sul territorio di uno Stato membro, che in quanto tale ha l’obbligo di cooperare con la CPI, l’articolo 98 offre la possibilità a quest’ultimo di non dare seguito all’obbligo. Entriamo nel dettaglio.
Innanzitutto, per quanto riguarda il secondo comma, il testo non restringe il campo a un tipo specifico di accordo internazionale – lasciando di fatto ogni eventualità sul tavolo – e non delimita il periodo temporale di applicazione – aprendo alla possibilità di influenzare l’azione della Corte anche con trattati successivi all’entrata in vigore dello Statuto.
Non è un dettaglio da poco. Per esempio gli Stati Uniti – che, ricordiamo, non riconoscono la Corte dell’Aja – a partire dal 2002 hanno siglato 93 accordi bilaterali (con altrettanti Paesi) con i quali precludono alle nazioni firmatarie la possibilità di consegnare personale militare, governativo o cittadini statunitensi alla CPI.
In virtù di trattati di questo tipo, che sotto l’aspetto del diritto internazionale sono pienamente legittimati dallo Statuto di Roma, e in ragione dell’articolo 63 che impone la presenza dell’imputato affinché il processo possa tenersi, è evidente come gli Stati membri possano venire meno all’impegno di “porre fine all’impunità” per “contribuire alla prevenzione dei crimini” dichiarato nello Statuto stesso, oltre all’obbligo di rispettarne obiettivo e scopo come invece previsto dall’articolo 18 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
Il veto del Consiglio di Sicurezza dell’ONU
Non è tutto. La possibilità per la Corte di mantenere fede al proprio obiettivo viene fortemente influenzata anche dalle decisioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, che è un organismo politico. È previsto infatti che l’UNSC possa riferire una situazione alla CPI e richiederne l’intervento, con una risoluzione in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite (minacce alla pace, violazioni della pace e atti di aggressione), anche nell’eventualità che il caso segnalato riguardi il territorio e i cittadini di uno Stato non membro. Così facendo garantisce piena giurisdizione internazionale alla Corte dell’Aja, rendendo anche possibile bypassare il limite posto dall’immunità personale e diplomatica stabilito nell’articolo 98 (primo comma): l’intervento del Consiglio di Sicurezza equipara infatti uno Stato terzo a uno Stato membro, i cui cittadini – come stabilito dall’articolo 27 dello Statuto di Roma – non possono appellarsi a tale immunità (9). Il suo potere di intervento, tuttavia, è limitato dal diritto di veto in capo ai cinque membri permanenti – Cina, Francia, Russia, Regno Unito, Stati Uniti – che possono bloccare qualsiasi risoluzione. Tenendo anche conto che Stati Uniti, Russia e Cina non riconoscono la Corte, il potere che lo Statuto della CPI attribuisce al Consiglio di Sicurezza risulta spesso solo formale, perché inevitabilmente soggetto a interessi geopolitici nazionali.
Un caso di questo tipo si verifica nel 2014: guidati dalla Francia, 13 dei 15 membri del Consiglio votano a favore di una risoluzione che permetta alla Corte di indagare su possibili crimini di guerra e/o crimini contro l’umanità commessi nel contesto della guerra in Siria (Stato che non riconosce la CPI), ma Russia e Cina si oppongono, facendo valere il diritto di veto. La risoluzione non passa e la CPI ha le mani legate.
Nella fattispecie del crimine di aggressione, l’articolo 15 dello Statuto allarga ulteriormente il potere di intervento del Consiglio di Sicurezza: prima di poter aprire un’indagine il Procuratore deve notificarlo all’UNSC, che ha tempo sei mesi per decidere se lo Stato in questione ha commesso un atto di aggressione o meno. Se decide affermativamente, il Procuratore può procedere con le indagini; non dovesse arrivare alcuna delibera entro i termini, invece, può farlo solamente previa autorizzazione della sezione preliminare e solo se non interviene l’articolo 16. Il Consiglio di Sicurezza può infatti richiedere alla CPI di sospendere qualunque nuova indagine o processo in corso per dodici mesi, rinnovabili indefinitamente, nel caso in cui ritenga che interferiscano con il suo mandato di tutelare la pace e la sicurezza internazionale. Una richiesta che vuole il voto favorevole di tutti i cinque membri permanenti e che può non essere accolta dalla Corte dell’Aja, rendendo più difficile, per lo meno in questo specifico caso, intaccare la sua autonomia.
È dunque chiaro che, se da un parte il Consiglio di Sicurezza dell’ONU permette alla CPI di applicare la propria giurisdizione anche sui cittadini e sui Paesi non membri, dall’altra la sua capacità d’azione è posta strettamente sotto il controllo dei principali attori geopolitici mondiali. Se a ciò si aggiungono i limiti posti dall’articolo 98, in tandem con l’articolo 63, ne risulta un quadro in cui rapporti di forza tra Stati assumono il ruolo di primo piano. La CPI quindi si presenta come istituzione sovranazionale, ma di fatto il suo potere è fortemente limitato dagli interessi nazionali.
Stati Uniti e CPI
“Gli Stati Uniti”, si legge in una nota del Dipartimento di Stato del 1998, “supportano fermamente l’istituzione di una Corte penale internazionale giusta, efficace e regolarmente costituita” (10). Eppure il rapporto tra le due realtà non è affatto sereno.
A partire dal 1995, gli USA diventano attori principali negli incontri diplomatici delle Nazioni Unite tenutisi nel corso della Conferenza di Roma, partecipano alla stesura della versione finale dello Statuto e ai lavori preparatori all’istituzione della CPI. Danno tuttavia il proprio voto contrario all’adozione dello Statuto (11), e nel 1999 il Congresso USA approva il Foreign Relations Authorization Act (12), che contiene disposizioni che proibiscono il supporto finanziario alla CPI e l’estradizione di qualunque cittadino statunitense in un Paese che potrebbe consegnarlo all’Aja. Il 31 dicembre 2000 – ultimo giorno utile – firmano lo Statuto, ma il presidente Clinton decide di non sottoporre il testo al Senato per la ratifica, e di riservarsi “la possibilità di osservare e valutare il funzionamento della Corte” prima di sottostare alla sua giurisdizione (13).
Con il cambio alla presidenza, la distanza tra Stati Uniti e CPI si fa più marcata. “La presente”, recita una lettera inviata al Segretario Generale delle Nazioni Unite il 6 maggio 2002 da John Bolton, sottosegretario del nuovo governo Bush, “per informarla che, relativamente allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale adottato il 17 luglio 1998, gli Stati Uniti non intendono aderire al trattato”. Bolton ufficializza così la posizione dell’Amministrazione, sottolineando che gli USA non hanno “obblighi legali derivanti dalla firma” dello Statuto (14). Non soltanto.
Sono i tempi della guerra in Afghanistan e dell’“esportazione della democrazia” e, di lì a poco, del conflitto in Iraq. Ad agosto 2002 Bush promulga l’American Service-members Protection Act (ASPA) (15), legge – ancora oggi in vigore – che prevede il divieto di cooperazione, di supporto finanziario e di assistenza alle indagini della CPI. Oltre ad autorizzare il presidente a usare “tutti i mezzi necessari”, inclusa la forza militare, per liberare cittadini americani o di Paesi alleati detenuti dalla Corte (definito informalmente “The Hague Invasion Act”, “Legge per l’invasione dell’Aja”), il testo fa esplicito riferimento alla stipula degli accordi bilaterali in base all’articolo 98 dello Statuto di Roma, che da quel momento iniziano a essere sottoscritti: vincola la partecipazione degli Stati Uniti alle missioni di pace dell’ONU sul territorio dei Paesi membri all’ottenimento di un’esenzione per le forze armate USA dalla giurisdizione della CPI, e impone la firma di tali trattati come precondizione necessaria per il supporto e l’addestramento militare (le misure relative alla cooperazione militare vengono poi abrogate tra il 2006 e il 2008). In piena logica utilitaristica, la legge lascia aperta la possibilità che gli Stati Uniti possano collaborare “agli sforzi internazionali” per assicurare alla giustizia “cittadini stranieri accusati di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l’umanità”. Stranieri, non statunitensi.
Ufficialmente, la linea di pensiero che accompagna l’atteggiamento degli USA verso la Corte penale internazionale considera l’intervento di un organismo sovranazionale come una violazione della propria sovranità: gli Stati Uniti, affermano, sono uno Stato di diritto, con piena giurisdizione sui propri cittadini e con la capacità giudiziaria di condurre processi imparziali nei loro confronti. Capacità che però non riconoscono ad altri Stati: oggi alla Russia, per esempio. Non si tratta infatti di sovranità o capacità ma, ben più prosaicamente, di interessi nazionali. Tralasciando il silenzio calato in Occidente sui crimini commessi nel Donbass contro i civili dall’esercito ucraino, sostenuto dagli americani, dal 2014 a oggi – con il ruolo focale svolto dalle milizie neonaziste del battaglione Azov – gli Stati Uniti hanno infatti già avuto modo di negare la loro presunta diversità.
Guerra in Afghanistan: nel 2017 il procuratore della CPI Fatou Bensouda chiede un’autorizzazione ai giudici della sezione preliminare per aprire un’indagine sui crimini commessi durante il conflitto da parte, tra gli altri, delle forze armate USA e della CIA. È la prima volta che la CPI mette sotto investigazione personale statunitense. Il procuratore sottolinea che “non sono state condotte e non sono al momento in corso indagini né azioni penali negli Stati Uniti nei confronti di persone o gruppi di persone coinvolti nei presunti comportamenti riportati in questa richiesta […] o le informazioni disponibili sono insufficienti per delineare i contorni di un qualsiasi processo di rilievo a livello nazionale” (16). Per tale ragione, la Corte dell’Aja rivendica di avere la giurisdizione sovranazionale per indagare. E ha ragione. Lo confermano anche le dichiarazioni del 2009 del presidente Obama, in occasione della pubblicazione da parte del governo di alcuni documenti che illustrano le tecniche di interrogatorio approvate ai tempi dell’amministrazione Bush: “È nostra intenzione assicurare che coloro i quali hanno assolto al proprio dovere in buona fede, affidandosi al supporto legale del Dipartimento di Giustizia, non saranno soggetti ad alcun perseguimento penale”; “abbiamo attraversato un capitolo buio e doloroso della nostra storia” ma, precisava Obama, “non otterremo nulla dal dedicare il nostro tempo e la nostra energia ad attribuire colpe per il passato” (17).
E infatti, alla richiesta di Bensouda la reazione del governo Trump è furiosa: Bolton (18) – in quel momento Consigliere per la sicurezza nazionale – e Pompeo (19) – Segretario di Stato – minacciano l’imposizione di sanzioni economiche, il divieto di accesso negli Stati Uniti e azioni penali nei confronti di giudici e procuratori della CPI, così come di qualsiasi azienda o Stato che collabori con la Corte; successivamente, un Ordine Esecutivo presidenziale (20) implementa una politica di sanzioni economiche e restrizioni dei visti d’ingresso per il personale della CPI coinvolto nelle indagini sui cittadini USA, colpendo direttamente Bensouda. Prima respinta dalla stessa Corte e poi confermata, il procuratore avvia finalmente la propria inchiesta nel 2020, ma meno di un mese dopo il governo afghano chiede e ottiene la sospensione delle indagini per poter procedere in proprio (21). Sospensione che dura poco più di un anno: a settembre 2021, infatti, il nuovo procuratore Karim Khan decide di riaprire le indagini, specificando però di volersi concentrare solamente sui crimini commessi da Talebani e Stato Islamico, tralasciando quelli relativi al personale militare e di intelligence USA “a causa delle limitate risorse a disposizione” (22). Obiettivo raggiunto per gli Stati Uniti, quindi. (23)
Va sottolineato che, di fatto, il potere reale della CPI sarebbe stato inconsistente: nel 2003 l’Afghanistan ha infatti siglato con gli USA un accordo in base all’articolo 98 (24), e nessun processo si sarebbe dunque potuto tenere in assenza degli imputati. Poteva tuttavia aprirsi un’incriminazione, e ciò che premeva agli Stati Uniti era tutelare la propria immagine internazionale – oggi è ancora più comprensibile quanto fosse fondamentale la posta in palio: è ben difficile immaginare Biden e il Congresso USA puntare il dito contro Putin, se sugli Stati Uniti pendesse un’indagine, o peggio un’incriminazione, per crimini di guerra in Afghanistan.
Con la stessa violenza gli USA si muovono a proteggere un alleato storico: Israele. Lo Stato palestinese accetta la giurisdizione della Corte nel 2015, ratificando lo Statuto, e ne chiede l’intervento per i crimini commessi sul suo territorio a partire dal giugno 2014 (25). Nel 2018 il Segretario di Stato Pompeo dichiara che gli Stati Uniti non permetteranno “alla CPI, o a qualunque altra organizzazione, di limitare il diritto di autodifesa di Israele” (26), Paese che non riconosce la Corte dell’Aja. “Se la Corte punterà noi, Israele o altri nostri alleati, non rimarremo fermi a guardare”, chiosa. A marzo 2021, il Dipartimento di Stato del governo Biden non molla la presa: sottolinea che la Palestina non si qualifica come Stato sovrano e quindi non può accedere alla giurisdizione della CPI, ed esprime “grande preoccupazione” per la decisione del procuratore di procedere alle indagini anche nei confronti di cittadini israeliani (27). A oggi, il caso è ancora aperto.
Russia e CPI
Non che con la Russia i rapporti della Corte penale internazionale siano più amichevoli. Abbiamo già visto il diritto di veto posto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu nel caso della Siria, bilateralmente le cose non funzionano meglio. Esattamente come gli Stati Uniti, la Russia ha firmato lo Statuto di Roma (nel 2003) lasciando in sospeso la sua ratifica. Successivamente, il 14 novembre 2016, il procuratore della CPI pubblica un report (28) in cui definisce l’annessione russa della Crimea post referendum una “occupazione in corso” nel contesto del conflitto tra Russia e Ucraina. In aggiunta, si sofferma sul conflitto scoppiato nel 2014 nel Donbass, specificando la necessità di accertare i crimini commessi da tutte le parti in causa e la possibilità che la Russia abbia fornito supporto ai gruppi armati delle autoproclamate Repubbliche indipendenti di Lugansk e Donetsk. Passano appena due giorni e il ministro degli Esteri Lavrov comunica la decisione russa di non voler ratificare lo Statuto della Corte, ritirando ufficialmente la firma, e definendo la CPI un’istituzione “di parte e inefficiente” (29). Nella sua dichiarazione definisce parziale anche l’indagine in corso sul conflitto tra Russia e Georgia del 2008, chiarendo di “fidarsi a fatica della CPI in un contesto del genere” (30).
Parole pesanti, ma che nel concreto non modificano la posizione russa: non avendone mai accettato la giurisdizione, la Corte dell’Aja ha la possibilità di procedere contro un cittadino russo solo nel caso in cui un ipotetico accusato si presentasse spontaneamente davanti alla CPI o si trovasse sul suolo di uno Stato membro che ha l’obbligo di cooperazione. Nel caso di Putin – che gode di immunità personale – andando oltre le dichiarazioni sensazionalistiche rilasciate a mezzo stampa, un eventuale processo sarebbe possibile solo con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che revocasse la sua immunità: decisamente improbabile, visto che la Russia ha potere di veto.
Doppio binario
A mostrare la forte limitazione imposta alla Corte dai diversi interessi geopolitici nazionali, il fatto che a vent’anni dalla sua nascita la CPI abbia incriminato soltanto cittadini africani, con 47 individui accusati e 8 condannati. Ritenendo ingiusta e discriminatoria questa univoca attenzione, nel 2017 l’Unione Africana approva una risoluzione non vincolante (31) con cui invita i Paesi del continente che hanno accettato la giurisdizione della CPI a considerare il ritiro dallo Statuto di Roma, adottando parallelamente un trattato (a oggi non ratificato) che istituisca un tribunale locale che sostituisca le funzioni della Corte garantendo, contrariamente a quest’ultima, l’immunità personale e diplomatica – punto centrale della diatriba. Da allora, tuttavia, solamente il Burundi – oggetto di indagine per crimini commessi tra il 2004 e il 2017 contro la popolazione civile (32) – ha dato seguito alle intenzioni iniziali, raggiunto nel 2019 anche dalle Filippine, Paese a suo volta sotto indagine della Corte dell’Aja (33).
Sono in tutto 17 le inchieste in corso, di cui 10 in Stati africani. A parte quelle relative al Venezuela e alla persecuzione della popolazione Rohingya in Bangladesh e Myanmar, le restanti riguardano situazioni in cui la Corte – come abbiamo visto – ha di fatto le mani legate dai veti di Stati Uniti e Russia: i conflitti in Georgia e Ucraina, e le indagini in Palestina e Afghanistan (che dal 2021 non includono più i cittadini americani).
“Gli Stati membri di questo Statuto”, recita il preambolo del trattato adottato con la Conferenza di Roma del 1998, sono determinati “a istituire una Corte penale internazionale permanente indipendente in relazione con il sistema delle Nazioni Unite”. Le intenzioni non si sono tradotte in realtà. Gli interessi geopolitici nazionali condizionano la sua azione e lo Statuto stesso della CPI permette ai Paesi di farlo. La sua indipendenza è solo sulla carta. Ne risulta un organismo di diritto internazionale che viaggia su un doppio binario: forte con i deboli e impotente con i forti; e che si presta, a seconda degli interessi in gioco, a essere utilizzata come strumento politico o a essere screditata e ostacolata.
1) https://www.state.gov/war-crimes-by-russias-forces-in-ukraine/
2) https://edition.cnn.com/2022/04/04/politics/joe-biden-bucha-russia-war-crimes/index.html
3) Senato USA, 117th Congress (2021-2022), S. Res. 546, 15 marzo 2022
6) Cfr. Ambasciata Ucraina all’Aja, documento protocollo n. 61219/35-673-384, destinatario Corte penale internazionale, 9 aprile 2014
7) https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-march-23-2022/
8) Statuto di Roma, preambolo, 17 luglio 1998
10) https://1997-2001.state.gov/www/briefings/statements/1998/ps980622b.html
11) Cfr. https://www.aba-icc.org/about-the-icc/the-us-icc-relationship/
12) Cfr. H.R. 3427, Admiral James W. Nance e Meg Donovan, Foreign Relations Authorization Act, 106th Congress (1999-2000), 17 novembre 1999
13) https://1997-2001.state.gov/global/swci/001231_clinton_icc.html
14) https://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2002/9968.htm
15) Cfr. Codice degli Stati Uniti, titolo 22, capitolo 81, sottocapitolo II
16) Cfr. Public redacted version of “Request for authorisation of an investigation pursuant to article 15”, 20 November 2017, ICC-02/17-7-Conf-Exp
17) https://www.cbsnews.com/news/aide-obama-wont-prosecute-bush-officials/
18) Cfr. https://www.lawfareblog.com/national-security-adviser-john-bolton-remarks-federalist-society
21) Cfr. Ambasciata Afghanistan all’Aja, The Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Deferral Request made by the Government of the Islamic Republic of Afghanistan pursuant to Article 18(2) of the Rome Statute, 26 marzo 2020
23) Per un approfondimento sull’indagine della Corte penale internazionale sulla guerra in Afghanistan, la correlata questione WikiLeaks e Julian Assange e lo scontro tra Stati Uniti e Corte dell’Aja, vedi Giovanna Cracco e Alessandro Rettori, Se a essere perseguito è chi denuncia. L’Afghanistan, Manning, Assange e la Corte penale internazionale, in “Dopo l’Ucraina. Crimini di guerra e giustizia internazionale”, a cura di Associazione Società Informazione Onlus, Milieu Edizioni, 2022
24) Afghanistan, International Criminal Court: Article 98, Agreement signed at Washington September 20, 2002; Entered into force August 23, 2003, Treaties and other International Acts series 03-823
25) Cfr. https://www.icc-cpi.int/palestine
26) https://www.palestinechronicle.com/international-complicity-aids-us-israel-efforts-against-the-icc/
28) Cfr. Corte penale internazionale, Ufficio del Procuratore, Report on Preliminary Examination Activities (2016), 14 novembre 2016
30) https://russia-direct.org/opinion/why-russia-withdraws-international-criminal-court
31) Cfr. https://www.ictj.org/news/au-withdrawal-icc-non-starter
32) Cfr. https://www.icc-cpi.int/burundi
33) Cfr. https://www.icc-cpi.int/philippines