Incontro-dibattito sul libro La società artificiale. Miti e derive dell’impero virtuale, di Renato Curcio (Sensibili alle foglie, 2017), presso il Csa Vittoria, Milano, 14 settembre 2017
Il lavoro di ricerca è sempre un lavoro teso su una corda, nel senso che stiamo cercando di affrontare dei processi sociali nuovi, che ci sorprendo perché, come abbiamo tentato di dire soprattutto nel primo lavoro, L’impero virtuale (1), sono processi ad altissima velocità storica e sorpassano la nostra capacità di adattamento. Il tempo, la storia, dell’Ottocento e del Novecento, per rimanere negli ultimi due secoli, aveva un passo molto più lento: il lavoratore del sud Italia che veniva a lavorare alla Pirelli a Milano o alla Fiat di Torino, poteva arrivare anche digiuno di quella che era una cultura del mondo del lavoro, sindacale, di classe ecc., e aveva poi il tempo per entrare progressivamente nei problemi che stava vivendo insieme ai diversi contesti che attraversava e che erano abbastanza omogenei: i contesti urbani dei quartieri, quelli di fabbrica, i contesti sociali più organizzati. Oggi questo non c’è più. Oggi i tempi sono talmente violenti e veloci che ci mettono di fronte a delle dinamiche che sono mondiali, e che solo dieci anni fa non esistevano.
Facebook, per esempio, che nel 2007 entra come processo sociale non più riferito a un piccolo gruppo di università, e dieci anni dopo raggiunge i due miliardi di utenti. È quindi comprensibile che le persone che vi si sono riversate lo vivano più esperenzialmente e intuitivamente che avendone contezza e gli strumenti per leggere che cos’è, come funziona, come funzionano loro stessi mentre utilizzano questo tipo di strumenti. Ne L’impero virtuale dunque abbiamo cercato di affrontare l’insorgere di questo tipo di processi sociali, legati a una tecnologia particolare, che hanno sorpreso abitudini, consuetudini, modi di leggere la realtà e di viverla in tutti i campi: nel lavoro, nel consumo, nello svago, nella vita di relazione.
Come secondo passaggio ci siamo concentrati sul terreno del mondo del lavoro, con L’egemonia digitale (2), cercando di capire come e fino a che punto gli sguardi che noi avevamo – che derivano dalla storia dell’organizzazione del lavoro che ha caratterizzato il Novecento, una discussione partita già nell’Ottocento con Marx e la forte elaborazione di quali erano le dinamiche profonde del modo di produzione capitalistico rispetto al mondo del lavoro – reggevano nella nuova situazione.
Questi due lavori ci hanno però messo in evidenza un loro limite, che possiamo considerare ovvio in qualche modo perché erano approcci nuovi, e che ritengo anche un valore: entrambi nascevano da un’esperienza prevalentemente narrativa, all’interno di cantieri sociali. Ci eravamo appoggiati alle persone che vivevano in modo diretto nei luoghi più significativi dei processi che volevamo guardare, e attraverso le loro narrazioni avevamo cercato di costruire un territorio a partire dal quale fosse poi possibile passare a un momento di analisi più profondo. Ma questo poneva il limite della dimensione fenomenologica: le persone raccontavano storie che erano emblematiche, sistemate attraverso una serie di verifiche, ed è ovvio che se lavoratrici e lavoratori raccontano, seppur con parole diverse, sempre la stessa storia, quella storia diventa oggetto di una riflessione e ci consente di passare dalla sua narrazione fenomenologica a individuarne le dinamiche più profonde.
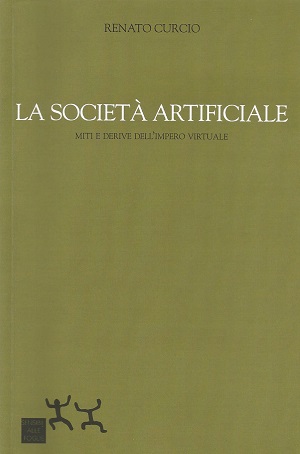
È vero però che alcuni momenti della microfisica del potere delle storie che raccontavano erano, da un punto di vista tecnologico, talmente complessi e talmente banalizzati dalle parole con cui venivano narrati, che spesso si aveva la sensazione di aver capito di cosa si stava parlando e invece, andando poi a fondo, non era così chiaro. E quindi in quest’ultimo lavoro, La società artificiale, fatto insieme a gruppi di persone che a Roma e a Milano hanno voluto accompagnare questa riflessione e con incontri svolti su territori specifici che poi vedremo, lo sforzo è stato cercare di andare a vedere le dinamiche più profonde dei processi che avevamo raccontato, esplorato e cercato di capire nei due lavori precedenti.
Per farlo abbiamo utilizzato una metodologia rigorosa, ossia abbiamo assunto un analizzatore, come si fa nel lavoro socioanalitico più tecnico, a partire dal quale poter guardare questi processi, e l’abbiamo selezionato per evidenza. Ora: le evidenze, dal punto di vista anche della ricerca scientifica, sono molto importanti, si parte da lì, bisogna poi però cercare di capire cosa sono. L’evidenza da cui siamo partiti è un’evidenza fenomenologica che tutti possiamo facilmente verificare: sempre più, in modo invasivo e pervasivo, la nostra vita di relazione in tutti i campi, quindi relazioni interpersonali, di lavoro, nel mondo del consumo, nello svago, nelle dinamiche di gruppo, viene spezzata da una intermediazione digitale, vale a dire da uno strumento che si frappone tra una persona e l’altra.
Voglio ricordare che la vita di relazione è il fondamento della sociabilità, di quel tipo di vita che noi chiamiamo società, che non è, ovviamente, un gruppo di persone che stanno insieme, ma è un insieme di legami che tengono insieme delle persone; quindi nella storia della nostra specie il fondamento vitale dello stare insieme, delle comunità, dei popoli, dei gruppi, delle dimensioni collettive, non riposa sulle caratteristiche dei singoli ma sulla qualità dei legami che essi istituiscono tra loro, senza i quali non ci sarebbe alcuna vita sociale; saremmo chissà dove ma sicuramente non nel mondo delle società umane, nel mondo che ha 3/400.000 anni, almeno 70.000 dei quali rintracciabili, e che ha una profondità storica. La storia dunque fino a oggi è storia di legami. Ebbene, l’intermediazione digitale che viviamo ora è il fondamento di un passaggio da relazioni tra umani a connessioni tra umani, vale a dire a un tipo completamente diverso del modo di stare insieme rispetto alla storia della nostra specie.
Come prima cosa prendiamo quindi atto che l’intermediazione è un evento di rottura qualitativa nella storia della specie, una rottura profonda nel modo di stabilire rapporti perché li trasforma in connessioni, e quindi modifica il piano caldo dello stare insieme. Che non è solo un modo di dire, si riferisce proprio a una temperatura corporea: se voi amate una persona, in un rapporto corpo a corpo, la temperatura del vostro corpo aumenta, c’è un’energia termica; se voi usate delle parole c’è un’energia sonora; poi c’è un’energia di spazio, di luce, c’è la vicinanza, la lontananza, la prospettiva… I legami sono materiali e sono basati su energie, per cui se io li intermedio vado a mettere un ‘paletto’ di cambiamento rispetto a un problema evolutivo che ci ha messo decine di migliaia di anni per portarci qui.
Guardando allora gli strumenti di intermediazione, lo smartphone è il feticcio globale per eccellenza di quest’epoca, uno strumento che vedremo come e perché consente di mettere in relazione persone a distanza ma anche di consultare motori di ricerca, individuare la nostra posizione all’interno di una città, pagare un acquisto, ordinare una pizza ecc. Questo strumento, che è solo uno dei dispositivi di intermediazione digitale, è diventato oggetto della nostra riflessione. Rispetto ai due lavori precedenti, questo libro quindi comincia a dare un frutto che ci potrà essere utile per approfondire ulteriormente.
Abbiamo cominciato a vedere che rispetto a tutti gli strumenti elaborati da 70.000 anni a questa parte – dico 70.000 perché mi reggo sui lavori dei paleontologici e degli archeologi che hanno consentito di disotterrare, dalle viscere della storia e della terra, gli strumenti utilizzati fino a qui in varie parti del mondo – questi strumenti digitali hanno una caratteristica qualitativamente diversa. Vi faccio un’analisi darwiniana, non quella elaborata da Marx, dai materialisti, ma dagli antropologi. La storia degli strumenti è stata quella di mediare delle abilità umane in modo da rendere progressivamente possibile una trasformazione del mondo circostante: abbiamo immaginato una selce, una pietra appuntita per tagliare la pelle di un orso, la ruota per rendere possibile dei trasporti, la scrittura per registrare dei conti ma nello stesso tempo per creare una nave, per trasferire la memoria della cultura orale sulla pietra di modo da fissare la parola, che è mutante e flessibile.
Quindi abbiamo costruito tanti strumenti che erano sempre strumenti di mediazione di un immaginario, di una capacità, di una abilità, rispetto a un ambiente o ad altri umani. Il tipo di relazioni e di legami di cui accennavo sopra sono stati progressivamente arricchiti, per cui si è passati dal nulla all’energia, dall’angoscia dell’altro e del diverso a una mediazione più complessa, che era la parola, a una più complessa ancora che era la scrittura, a una più complessa ancora che erano le macchine, che è poi stato anche il macchinismo industriale del Novecento.
Fino a questo punto siamo sempre stati di fronte allo stesso tipo di problema: lo strumento media un’abilità, una capacità, e poi sarà di proprietà di qualcuno e allora ci saranno delle lotte, ma qui non è questo il punto, mi interessa portare l’attenzione sulla sua qualità. Con gli strumenti digitali ci troviamo in un contesto completamente mutato: gli strumenti, pur continuando a svolgere questa funzione, ne svolgono anche un’altra che prima non esisteva e che li caratterizza: comunicano tra loro e con delle piattaforme remote. Vale a dire che fanno un lavoro sul lavoro, e ciò avviene all’insaputa di chi li utilizza.
Vi racconto una storia, vera, che abbiamo registrato nei nostri cantieri, per far comprendere cosa intendo. La chiameremo la storia di Amalia, un’operatrice turistica. Un bel giorno l’agenzia per la quale Amalia lavora tira fuori i risultati di una ricerca, svolta in una determinata regione, che si proponeva di capire come si muovevano i turisti in quella zona. Ebbene la ricerca era stata costruita non interpellando degli umani ma monitorando gli impulsi e i messaggi emessi dai dispositivi digitali dei turisti. In questo modo era stato possibile distinguere i dispositivi che appartenevano alle persone che vivevano in quella regione, e quindi escluderli, poi verificare quanto tempo ogni turista restava in quella zona, quali alberghi aveva scelto, quali luoghi visitato, quali consumi ecc. Un’intera ricerca, che ha definito le politiche di un grande territorio sociale, non ha dunque interpellato umani ed è stata fatta esclusivamente monitorando, all’insaputa dei loro proprietari, il movimento di smarphone, tablet, palmari. È una storia importante perché ci mette di fronte alla microfisica della nuove forme sociali, che può essere sviluppata attraverso alcuni passaggi.
Innanzitutto questi strumenti possono essere monitorati perché al loro interno hanno un dispositivo tecnologico che si chiama ‘sensore’, ed è un dispositivo particolare che consente di tradurre un suono, una luce, una pressione, una temperatura, un evento qualunque che avvenga nel mondo esterno, in una grandezza quantitativa misurabile e trasmissibile, che noi conosciamo come ‘dati’.
I dati sono grandezze fisiche materiali che nascono da una misurazione e da una traduzione operata in un linguaggio matematico, che è l’unico linguaggio che possono capire le strumentazioni digitali, fondato sul codice 1/0. Dobbiamo riflettere sul concetto di ‘dati’. Perché la retorica ufficiale è quotidiana, non passa giorno che i giornali non scrivano “i dati ci dicono…”. La parola ‘dati’, però, bisogna essere molto chiari su questo, non significa nulla. Quando parliamo di dati non sappiamo affatto di cosa stiamo parlando, per una ragione tecnologica ma soprattutto sociale: i dati sono privati, brevettati, appropriati da una serie di agenzie o di aziende che sono proprietarie dei dispositivi che noi utilizziamo.
Quando compriamo un Samsung o un Apple o un dispositivo digitale qualunque e lo mettiamo in tasca, quello strumento genera dati interni e trasformazioni continue del mondo esterno in informazioni, che vengono trasmesse a piattaforme che non sappiamo neanche dove siano nel mondo. È difficile saperlo anche perché vivono in un non luogo che viene chiamato molto famigliarmente ‘la nuvola’, in un sistema di server sparpagliati in giro per il mondo, forse per il cielo, in un sistema di satelliti, ma non ha importanza; la cosa fondamentale è che non sappiamo dove siano e quindi dove vadano a finire le produzioni che, volenti oppure no, facciamo. Utilizzandolo, quello strumento trasforma la tua voce, le immagini che inserisci, le domande che fai su Google, le mail che spedisci, i gruppi WhatsApp a cui partecipi, le applicazioni varie che utilizzi ecc. in un’infinità di dati.
Abbiamo poi gli algoritmi. Questi dati non servirebbero a nulla se non fossero analizzabili, e a questo servono gli strumenti chiamati algoritmi. Anche sugli algoritmi c’è una retorica diffusa e sembra che si sappia esattamente di che cosa si parli, e invece è un grandissimo mistero perché gli algoritmi di Google, Amazon, Facebook ecc. sono brevettati, proprietari, non sono leggibili; possiamo quindi fare un lavoro intuitivo, non di conoscenza.
Riassumendo: i sensori, che non abbiamo inserito noi nel dispositivo e che non controlliamo, trasmettono dati di tutti i tipi su ciò che facciamo, questi dati si situano in non luoghi che sono proprietari, e sono analizzati da degli algoritmi, sempre proprietari, per restituirci qualcosa direttamente sui nostri strumenti, che può essere pubblicità, induzioni, comandi e tante altre cose. Questo percorso, che qui ho appena accennato, nel libro è raccontato in modo più tecnico,
per chi è interessato a capire bene come funzionano queste cose.
Qui però mi interessa sviluppare l’implicazione sociale e politica di questi processi, e la dimensionerò su tre territori: controllo sociale, lavoro e trasformazione del sistema politico.
L’aspetto del controllo sociale è estremamente importante perché ci riguarda tutti. Lo vediamo anche attraverso alcune parole che si sono lentamente insinuate nel linguaggio corrente, man mano che il sistema politico elaborava le tecnologie per realizzarlo. Per esempio la parola ‘radicalizzazione’. Chiunque ci ragioni per cinque minuti capisce che questa parola non vuol dire assolutamente nulla, a meno che non la si voglia significare decidendo qual è, di quel processo, il punto che va bene; dopo di che dirò che il signor Rossi, rispetto a ciò che a me va bene, si sta radicalizzando, vale a dire sta assumendo degli atteggiamenti che non mi vanno bene. Radicalizzazione è quindi una parola che misura un potere unilaterale che viene dall’alto. Ecco allora che i dati diventano interessanti, quelli che, seguendo il linguaggio comune dei giornali, chiameremo Big data – un’altra espressione che non significa niente, basta ragionarci un momento: Big è una parola inglese che indica una dismisura, enorme, moltissimo, e data è una parola latina che sta per ‘fatti’.
Ora: se volessimo andare ad analizzare l’espressione da un punto di vista strettamente semantico, non solo dunque diremmo che non significa nulla ma anche che è un trucco, perché che si possa analizzare dei fatti utilizzando dei dati, che sono delle grandezze numeriche, è un’idiozia assolutamente falsa. Noi siamo all’interno di un pensiero storico, dialettico, che ci ha abituato a pensare i processi sociali come processi, appunto, non come fatti: ossia come rapporti che si misurano attraverso una lotta, una difesa, una resistenza, un’aggressione. I processi sociali sono questo, sono sempre stati il contendersi dei territori all’interno dei quali i rapporti sociali sono gerarchici.
Quindi è ovvio, per esempio, che qualcuno cerchi di imporre un ritmo di lavoro e qualcun altro cerchi di resistergli; se raccontassimo il lavoro eliminando questa contesa, cosa ci capiremmo mai? Ma adesso abbiamo insigni scienziati, che scrivono libri importanti, raccomandati in molte università, nei quali si afferma che l’analisi sociale si può fare grazie ai Big data, cioè alla quantità di dati che oggi possono essere raccolti, e può essere trasformata in una fisica sociale, vale a dire in una lettura numerica e quantitativa dei processi.
Questo passaggio è importante, perché i computer possono elaborare queste grandezze fisiche e possono quindi trasformare la lettura dei processi in una curiosa pretesa, quella di indovinare il futuro, di leggerlo: attraverso l’analisi dei Big data posso leggere i processi sulla base delle loro probabilità di avverarsi. Vale a dire: se monitorizzo attentamente Luigi, grazie a tutti i dati che produce, posso tirare le somme e dire che, rispetto ai suoi orientamenti, potrebbe essere tentato di radicalizzarsi e dunque diventare un militante di una pericolosa organizzazione politica.
L’analisi su cui lavora tutto questo mondo, da un punto di vista propriamente metodologico, è quella probabilistica, ed è un’analisi che confina il possibile nel probabile; ma il punto è che il possibile ha la caratteristica fondamentale di non essere probabile. Il processo che genera un’invenzione rompe tutte le probabilità. È un fatto nuovo, e l’ingresso nella storia dei processi sociali più radicali avviene a un certo punto, non prima e non dopo, perché una combinazione di legami, tensioni, discussioni, pratiche, reazioni e controreazioni genera in un particolare contesto una rottura delle probabilità di stabilità; fino al giorno prima tutto veniva mediato, da quel giorno qualcosa è saltato.
Quindi la rottura della probabilità è la logica dell’invenzione, della rivoluzione, del cambiamento; se fosse tutto probabile noi saremmo semplicemente dei fantocci che esprimono nel presente una realtà passata, che ha prodotto come probabilità quel comportamento, ma noi, per fortuna, possiamo smentire le probabilità. E questo è un punto molto importante perché proprio qui si gioca l’idea del cambiamento del mondo o della sua perpetuazione all’interno del modo di produzione capitalistico. Quindi il controllo sociale sulla base delle probabilità cerca di ingabbiarci e convincerci che il mondo funziona sulla base delle probabilità.
Per quanto riguarda il territorio del lavoro, grazie a questi strumenti siamo a un passaggio enorme: dal taylorismo – che è un po’ la filosofia di massima generale del capitalismo nella sua fase avanzata – a una fase post tayloristica, caratterizzata dalla sostituzione degli strumenti meccanici di mediazione del lavoro fino a qui utilizzati, con gli strumenti digitali.
Analizziamo tre fenomenologie comuni di questo cambiamento. La prima possiamo chiamarla la fenomenologia dei guinzagli elettronici. L’abbiamo evidenziata prevalentemente ne L’egemonia digitale, nel quale raccontavamo la storia del lavoratore della Leroy Merlin che un giorno si trova davanti un bracciale, e dal momento in cui lo indossa il dispositivo inizia a trasmettere qualsiasi tipo di dati: i movimenti del lavoratore nel reparto, i tempi che impiega per compiere un’operazione ecc. In tempo reale, sempre sul display del bracciale, il lavoratore riceve le informazioni su come deve correggere il suo lavoro, se lo deve accelerare, ritardare, quali parti deve svolgere, qual è il livello di produttività che in quel momento lo caratterizza e se quel livello corrisponde o meno alla produttività attesa dall’azienda: se corrisponde l’azienda gli dà un feedback positivo e dei punti, se è al di sotto gli toglie punti.
Nasce dunque questo gioco terribile del tenere in mano il lavoratore attraverso una piattaforma remota. Questa è una storia vera, e i bracciali sono in uso alla Leroy Merlin in tutta Italia ed Europa, ma sono centinaia di migliaia oggi le persone che lavorano con guinzagli elettronici di questo tipo, perché con il passare del tempo sono arrivati anche in altri territori. L’Acea, per esempio, a Roma, la Publiacqua a Firenze, aziende rispetto alle quali il governo stesso ha investito miliardi per riconvertire l’organizzazione del lavoro all’interno di una digitalizzazione spinta, con il risultato di avere moltissimi lavoratori che non riescono a svolgere i propri compiti all’interno degli schemi algoritmici costruiti da questi strumenti. Senza dimenticare l’implicazione sulla salute e quella sull’esclusione sociale.
La seconda fenomenologia ce l’hanno mostrata i lavoratori di Foodora, nel territorio che è quello della consegna a domicilio di cibo e che lavorano in un combinato che è smartphone/piattaforma. È un combinato importantissimo, intanto perché lo smartphone è il loro, e quindi lo strumento di lavoro ce lo mette il lavoratore, poi perché elimina completamente decine e decine di anni di lotte sul tempo di lavoro. Per questi lavoratori infatti il tempo di lavoro è determinato strettamente dal tempo di produttività, dal lavoro reale che essi svolgono, e che è monitorato direttamente dalla piattaforma e dal loro smartphone. Ciò significa che il tempo di attesa tra una consegna e l’altra, che è tempo necessario allo svolgimento just in time del lavoro, non viene assolutamente preso in considerazione. E abbiamo una sempre più estesa quantità di lavoratori all’interno di questo combinato smartphone/piattaforma, nel mondo dei trasporti, della logistica ecc.
La terza fenomenologia entra nel territorio della robotica, e devo ringraziare i lavoratori di Pomigliano, di Cassino, di Torino, del Lazio, che hanno lavorato con noi e ci hanno raccontato com’è il lavoro nelle linee robotizzate. Le retoriche ricorrenti sui robot sono due: una afferma che alleviano la fatica, e quindi bene che ci siano, alleggeriranno lo strazio e la sofferenza del lavoro; la seconda sostiene che se è vero che i robot eliminano un po’ di forza lavoro, tuttavia costruiscono i presupposti per nuove figure lavorative. Ebbene, sia su base diretta che di letteratura corrente qualificata, penso di poter dire che sono due retoriche entrambe false.
Innanzitutto perché nel modo del lavoro robotizzato avviene un passaggio terribile, che è quello della gestione del tempo e dello spazio del lavoro da una metrica cronometrica, basata sul tempo del lavoratore più veloce ma pur sempre cronometrata sugli umani, a una procedura algoritmica, dove sono i robot che definiscono il tempo del movimento delle linee in cui si lavora. E lo definiscono anche per gli spazi vuoti, perché la presenza di umani, non essendo eliminabile completamente dalle dimensioni di produzione, deve coprire i buchi robotici, là dove i robot non sono in grado di operare. Sia a Cassino che a Pomigliano, per esempio, i lavoratori fanno tre movimenti soltanto, concepiti all’interno del movimento dei robot, e hanno 50 secondi per farli, e in questo modo il tempo si è totalmente saturato.
Ma ciò che mi interessa mettere in evidenza sono due aspetti. Il primo è che il tempo di lavoro ha cambiato registro ed è diventato un tempo algoritmico, costruito su una progettazione di produttività complessiva all’interno della quale il movimento degli umani non è contrattabile: si può fare solo così. Il secondo è che proprio per questo, il tempo medio di vita lavorativa di un lavoratore è di tre anni. Ora: quando voi comprate un’auto, l’avete garantita per cinque anni. L’auto ha un tempo di vita garantito dall’azienda superiore al tempo di vita di chi ci lavora. E infatti la contrattualistica di tutte le aziende robotizzate prevede la possibilità di dimensionare i contratti in modo che poco prima della scadenza dei tre anni il lavoratore sparisce dalle linee.
Questo ci dice una cosa molto seria, che ora mi limito ad accennare ma spero il prossimo anno di poterla presentare: oggi vediamo che nei laboratori di ricerca militare si stanno studiando i soldati potenziati, vale a dire soldati che hanno la possibilità di operare al di sopra del tempo fisiologico. Se la nostra vista è dieci decimi, possiamo immaginare una modificazione tecno-genetica che la porti a dodici, ed è qualcosa che già esiste: ora molti soldati in campo di battaglia hanno una vista di dodici decimi, vedono di notte. Esistono già soldati Nato e dell’esercito americano che sono in grado di non dormire per quattro/cinque giorni, grazie a una modifica genetica che consente di alterare il ritmo biologico della veglia e del sonno; esistono soldati in grado di resistere a quattro/cinque/sei giorni di tortura, perché non sentono il dolore, grazie a una specie di anestetico, non chimico ma tecno-biologico.
Il problema di cui nessuno sta parlando è quello dei lavoratori aumentati, potenziati. Perché se devo portare avanti una produzione in cui lavoratori umani mi serviranno sempre, a un ritmo sempre più alto, avrò bisogno di ridurne il numero il più possibile, per pagarli meno, e quindi potenziare la loro capacità di resistenza alla fatica. Se pensate che sia un’esagerazione, chiedete ai medici del lavoro. È un aspetto che abbiamo affrontato in Mal di lavoro, che racconta come uno dei problemi oggi più terribili e poco conosciuti sia la farmacologizzazione del mondo del lavoro: abbiamo già una grandissima quantità di lavoratrici e lavoratori che per stare nelle tempistiche di queste nuove organizzazioni del lavoro si imbottiscono di psicofarmaci. Ecco quindi che il problema del lavoro robotizzato ci mette di fronte a queste realtà a e doverle raccontare, perché entro pochissimi anni più del 60% di tutte le professioni verrà robotizzato.
Come terzo territorio abbiamo la trasformazione del sistema politico in un sistema elettorale. L’Ottocento e il Novecento sono stati secoli in cui si sono aperti grandi conflitti, perché c’erano posizioni legate a interessi e forme culturali che ci portavano da qualche parte: c’era il fascista, il
comunista, il socialista, l’anarchico, c’era una fede o una cultura politica e una strategia, che faceva sì che persone che la esprimevano, la incorporavano, la rappresentavano, la vivevano quotidianamente, si presentassero anche al mondo sociale per dialettizzare la loro posizione e chiedere consensi oppure divieti. La trasformazione la si vedeva attraverso uno scontro di interessi mediati da forme culturali che assumevano una forma politica, che si poteva confrontare nel Parlamento oppure poteva esplodere in una rivoluzione.
Ebbene, questo non c’è più. I partiti esistono ancora ma sono diventati trasversali, non sono più centrati su un punto di vista di una fede e una cultura politica, che non esiste più perché non è più necessaria. Se oggi qualcuno è in grado di recuperare milioni di dati sui profili individuali di ciascuno di noi, visto che già solo con uno smartphone in tasca tutti li produciamo abbondantemente, perché mai darsi la pena di avere una fede politica? Il problema diventa semplicemente costruire un sistema di algoritmi che mi dica dov’è ognuno di noi, quindi passare da uno sguardo di gruppo a uno sguardo individuale, profilare ogni persona e poi studiare delle strategie semantiche per intervenire singolarmente sul suo dispositivo – caso mai attraverso dei robot, che si chiamano chatbot, e altre tecniche – per dargli ragione. È la tecnica più efficace. Questo è ciò che viene insegnato oggi nelle università, ma soprattutto ci sono grandi agenzie che lo implementano.
Le due recenti campagne elettorali americane, di Obama prima e di Trump successivamente, sono state costruite da pool di scienziati e da agenzie, la Cambridge Analytica in particolare – la più grossa agenzia del mondo che lavora su cento Paesi raccogliendo i dati di tutti gli elettori di ciascun Paese – che lavorano tutto l’anno sui profili politici ed emozionali, in modo da poter intervenire con ‘giochi’ – che sono gli stessi, sul piano mercantile, che applica Amazon quando comprate i prodotti – sulle convinzioni di ognuno, per dargli ragione nel nome e nel quadro di un soggetto politico.
Questa trasformazione è in atto anche in Italia, la vediamo nelle fenomenologie ma anche attraverso un curioso fenomeno, che attualmente è molto piccolo per un verso e anche molto fragile per un altro, che tuttavia è particolarmente significativo, ed è la Casaleggio Associati. Di fatto è un’azienda che, come la Cambridge Analytica, produce campagne di questo genere, basta andare sul sito e vedere cosa vende. La cosa interessante è che in Italia questa tecnologia è stata sperimentata attraverso una forma apparentemente politica, che è quella del Movimento 5 stelle. La combinazione di questi due aspetti è stata analizzata da alcuni centri di ricerca internazionali – li cito nel libro di modo che sia ben chiaro che non sto facendo un discorso politico sui 5 Stelle, non è quello che mi interessa fare, ma focalizzarmi su questo aspetto.
In Italia è stata applicata un’evidente trasformazione del sistema politico in un sistema di gestione degli elettori. La Piattaforma Rousseau è diventata oggetto di studi in molte università in Europa, sono in contatto con alcuni ricercatori che sono incuriositi dal fatto che in Italia non ci sia alcuna consapevolezza di ciò, nonostante sia evidente. Anche per stessa dichiarazione della piattaforma: se si leggono i documenti, è chiaramente scritto che Rousseau è una piattaforma di profilazione delle persone che aderiscono, o che cascano in questo tipo di cattura di quello che è un potenziale elettorato, né di destra né di sinistra. Vale a dire un elettorato gestito sulla base dei propri dati: cosa pensi, e vediamo come lo possiamo combinare rispetto a un intervento elettorale che faccia ottenere quel risultato che interessa ai partiti elettorali, cioè andare al governo.
Voglio concludere con quattro punti, che costituiscono per un verso la conclusione del lavoro che ho presentato, ma per un altro aprono un terreno che voglio enunciare, in modo che sia ben chiaro dove va a parare questo tipo di discorso; è un terreno sul quale penso di dover lavorare il prossimo anno, perché è inquietante e terribile. Lo definirei la formazione di un totalitarismo digitale, vale a dire la trasformazione del sistema politico non solo in un sistema elettorale, ma in un non sistema politico, ossia in una gestione dell’elettorato, dei cittadini, attraverso i Big data. È un processo già in corso e molto avanzato, e che configura un nuovo tipo di totalitarismo perché è senza dittatore, senza simboli, o meglio, i simboli diventano quelli dei grandi marchi, Microsoft, Apple, Google, Samsung… le grandi strutture che hanno in mano i tre sistemi operativi che gestiscono oggi 3,5 miliardi di smartphone. Possiamo dire che questa è la prospettiva per evidenze fenomenologiche molto forti.
La prima è che l’intermediazione digitale cresce, crescono i dati, cresce la concentrazione capitalista, una crescita che alcuni definiscono esponenziale, sicuramente è smisurata, e quindi la potenzialità di intervento di appropriazione dei dati sarà sempre maggiore.
La seconda è che non siamo di fronte semplicemente a una crescita di dispositivi e dati, ma anche di disuguaglianze sociali. La concentrazione capitalistica aumenta in pochissime aziende, che hanno non solo i più alti fatturati ma anche i più bassi livelli di occupazione, e anche il padroneggiamento della ricerca scientifica su questi dispositivi; hanno praticamente in mano le sorti di questo processo. Vorrei fosse ben chiara una cosa: crescita delle disuguaglianze significa polarizzazione di classi.
Quello che vediamo non è lo sparire delle classi ma il suo polarizzarsi. Come ha detto Warren Edward Buffet, uno degli uomini più ricchi del mondo, la lotta di classe esiste eccome, e l’hanno vinta sostanzialmente queste grandi strutture; ci sono riuscite perché riescono a nasconderla, a mascherarla, a presentarsi come interclassiste, come forze legate alla tecnologia, alla scienza. Naturalmente la variabilità delle figure del Novecento sta cambiando, ma vorrei solo ricordare che Marx l’ha scritto in molte opere che la variabilità del lavoro è semplicemente in funzione degli strumenti tecnologici che si mettono in atto; non è che il mondo capitalistico è quello in cui c’era la borghesia industriale e il proletariato di fabbrica, questa è una banalizzazione, un’ingiuria nei confronti dell’analisi marxista, che ha sempre sostanzialmente riconosciuto che le classi si determinano nella loro variabilità, parola di Marx, e nella loro consistenza, a seconda dell’andamento del processo del modo di produzione capitalistico.
Ora insieme alla variabilità e alla consistenza vediamo anche un aumento straordinario della produttività delle parti di lavoro vivo che restano, e soprattutto un fenomeno nuovo, inquietante, che è la produzione di una nuova categoria di esclusi sociali; non è l’equivalente del
sottoproletariato di un tempo, i diseredati, ma sono gli esclusi digitali. Oggi all’Acea i lavoratori che hanno cinquant’anni se ne vanno per disperazione; a Roma un lavoratore si è suicidato lasciando una precisa lettera in azienda, nella quale ha scritto che ha lavorato lì per quarant’anni e poi si è trovato a dover fare i conti con tablet, Gps, strumenti di tutti i tipi, che poteva anche imparare a utilizzare, ma il punto è che non solo non aggiungevano niente al suo lavoro ma gli impedivano di farlo, e spiegava le ragioni.
Le persone che non si digitalizzano vengono quindi buttate fuori dal mondo del lavoro, quasi con vergogna, come non fossero all’altezza delle nuove tecnologie, e invece si tratta di fare conti violentissimi con delle abilità lavorative che vengono annientate per un unico motivo, pagare meno o addirittura nulla il lavoro. Perché oggi, ed è un altro aspetto, noi produciamo gratuitamente lavoro gratuito, con le nostre domande a Google, quello che carichiamo su Facebook ecc., miliardi e miliardi di dati che hanno portato Zuckemberg in dieci anni dall’essere uno studente di università a uno degli uomini più ricchi del mondo. Quindi anche rispetto alla teoria marxista classica, sarebbe interessante sviluppare un aggiornamento, per vedere come al pluslavoro, che resta l’elemento centrale su cui si sviluppa lo sfruttamento capitalistico, si aggiunge un plus di dati che genera valore, e che costituirà la base della polarizzazione di classe.
Ci sono poi altri problemi che si possono intuire facilmente: se la concentrazione capitalistica si organizza intorno a un pool di aziende, a un’oligarchia digitale mondiale, nasce anche un problema relativo alle sovranità nazionali: che senso ha oggi parlare di Stati e nazioni? Aziende private producono dispositivi digitali secretati per parlamentari, ministri, potentati di varia natura; producono sistemi elettorali elettronici, come quello utilizzato nelle ultime elezioni in Kenia e che è stato elaborato da un’azienda francese. Tutto questo si va a incastonare sulla trasformazione dei sistemi politici in sistemi elettorali.
Terzo e ultimo punto, infine: questo processo è sostenuto da un fortissimo movimento culturale, che oggi attraversa le più importanti università del mondo, e si chiama transumanesimo. Ridotto all’essenziale e nella sua dimensione atroce, il transumanesimo afferma che questa intermediazione digitale non solo è inarrestabile, ma è positiva, perché sta sempre più collegando i singoli cittadini, lavoratori, consumatori, ad apparati di intelligenza transumana, che sono le macchine di intelligenza artificiale, e più ci connetteremo più avremo vantaggi. Le stiamo già utilizzando, quando poniamo una domanda a Google, nei sistemi di scrittura, per muoverci all’interno di una città che non conosciamo con un Gps ecc. Sistemi di intelligenza artificiale che sono in mano ad aziende private, e che ora sono esterni ai corpi ma già esiste un’azienda in Svezia, la Epicenter, e un’azienda americana che gli fa da controcanto, che stanno lanciando l’implementazione di dispositivi digitali incorporati sottopelle: chip con i quali i lavoratori aprono la porta dell’ufficio, senza più dover avere il badge e gestiscono i loro strumenti. Che significa, in pratica, che riducono il loro tempo di lavoro, e dunque aumentano la loro produttività.
Per questo tale processo verrà sempre più implementato e darà origine, come dicono i transumanisti, a un’inesorabile e inevitabile passaggio, dall’homo sapiens, che è la nostra specie fin qui, a un oltre uomo, digitalizzato, implementato, in relazione diretta con i sistemi di intelligenza artificiale. Certo qualcuno non si adatterà, non lo vorrà, peggio per lui perché sarà una sottoclasse. Questo è il punto su cui si affaccia oggi non una capacità di documentazione, ma una necessità di studio e di approfondimento in tutti i campi della vita sociale. Studio e approfondimento e lavoro collettivo che non hanno come obiettivo una maggiore conoscenza, ma una capacità di auto-organizzazione per invalidare il principio che il progresso sociale si identifica con l’implementazione tecnologica.
L’anno scorso avevo lasciato questo incontro dicendo che eravamo di fronte a una domanda: in che rapporto sta questa innovazione tecnologica con l’idea storica di progresso? Il passo che oggi mi sento di problematizzare è proprio questo: ora io sono assolutamente convinto che siamo di fronte a una divaricazione netta tra l’innovazione tecnologica e il progresso sociale. Oggi il progresso sociale deve riprendere in mano seriamente la questione dei legami, vale a dire la questione della capacità di vivere in modo evoluto insieme, e quindi deve accoppiare l’idea di classe all’idea di specie. Oggi lotta di classe è la possibilità di evitare a questa specie una terribile deriva, che è la deriva robotica e, come dicono alcuni, cyborg, dei cittadini e di questa nostra futura società.
1) Cfr. Renato Curcio, Colonizzazione dell’immaginario e controllo sociale, Paginauno n. 47/2016
2) Cfr. Renato Curcio, Capitalismo digitale. Controllo, mappe culturali e sapere procedurale: progresso?, Paginauno n. 50/2017


