| di Luciana Viarengo |
Recensione de Il crollo, Chinua Achebe
“La conquista della terra, che sostanzialmente consiste nello strapparla a quelli che hanno la pelle diversa dalla nostra o il naso leggermente più schiacciato, non è una cosa tanto bella da vedere, quando la si guarda troppo da vicino. Quello che la riscatta è solo l’idea. Un’idea che la sostenga, non un pretesto sentimentale, ma un’idea e una fede disinteressata, qualcosa, insomma, da esaltare, da ammirare, a cui si possano offrire sacrifici”, sosteneva il Marlow conradiano.
A confutare questa convinzione, anzi a rivelarne tutto il vizio pregiudiziale, si è levata nel 1958 la voce di Okonkwo, l’eroe tragico nato dalla penna di Chinua Achebe.
Okonkwo è un guerriero di etnia Ibo, la stessa alla quale appartenevano le vittime della guerra seguita al colpo di stato nigeriano del 1966. L’etnia di quei bambini, ventre deformato e occhi come pietre di onice affondate nel latte – fragili quanto l’indipendenza della loro terra, il Biafra – assurti a simulacro della denutrizione per carestia.
Ma Okonkwo vive centocinquant’anni prima di tutto questo e la sua terra, il villaggio di Umofia, che con altri villaggi si estende intorno all’ultimo tratto del fiume Niger, vive di agricoltura e di commercio, segue i tempi lenti delle stagioni e le armi dei guerrieri ibo sono quelle dei loro antenati, armi che uccidono un solo nemico per volta e non prescindono dal valore e dal coraggio del guerriero che le impugna.
Di valore e coraggio, Okonkwo ne ha da vendere, ne ha una tale quantità da riuscire ormai a percepire se stesso solo come guerriero, senza mai permettere al suo lato più umano di emergere: reprime i sentimenti che non siano aggressivi, oppresso dal fantasma di un padre che nulla aveva di coraggioso e di forte, un padre pigro e imprevidente che si copriva di debiti e passava il suo tempo sdraiato a suonare il flauto e a conversare. Insomma, colpevole di un’indole che Okonkwo identifica come femminile, dunque debole.
La virilità è per lui imprescindibile dal rispetto che gli viene tributato e dai ‘titoli’ che la tribù riconosce agli uomini meritevoli. Ma la sua idea di virilità spesso non coincide con quella del clan: in lui è associata solo all’aggressività. Non ha pazienza per i falliti.
Per dirla tutta, Okonkwo non ha pazienza per nessuno, né per le sue mogli sulle quali alza le mani spesso, né per i suoi figli, che pure ama. Il solo sentimento al quale permette di sgorgare a profusione è la rabbia, e per questo nel suo agire è avventato e irruente.
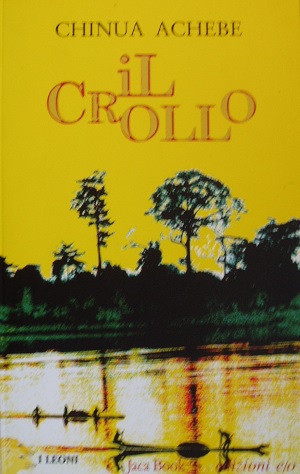
Nel clan, invece, esistono personaggi che nulla hanno di femminile e, tuttavia, dimostrano la preziosa capacità di “riflettere sulle cose”. Uno di questi è Obierika, amico del protagonista, che deciderà di non seguire gli uomini nell’uccisione rituale di Ikemefuna, figlio adottivo di Okonkwo. Quest’ultimo, invece, nonostante Ezeudu, l’anziano del villaggio, messaggero del responso funesto dell’Oracolo dei colli e delle caverne, gli consigli di restarne fuori perché “il ragazzo lo chiama padre”, non solo si unirà al viaggio sacrificale ma sarà colui che inferirà col suo machete il colpo mortale, nel timore che il clan possa ritenerlo un debole.
L’esilio, comminatogli per espiare l’uccisione involontaria di un membro del clan, potrebbe rappresentare per Okonkwo l’opportunità per entrare in contatto con la parte di sé che il fantasma del padre lo spinge a negare. Al contrario, ospite per sette lunghi anni della famiglia della madre in un altro villaggio, non perde occasione per confrontare la mancanza di bellicosità dei propri parenti con la fierezza che, nei suoi ricordi, contraddistingue gli abitanti di Umofia.
La saggezza, tratto distintivo della famiglia materna, è per lui motivo di biasimo. Non condivide il loro approccio negoziale e accondiscendente e non riesce a comprendere il loro desiderio di tenere sotto controllo l’aggressività e di evitare gli spargimenti di sangue.
Insomma, quella del protagonista de Il Crollo è, almeno in apparenza, la descrizione di una personalità che noi bianchi identificheremmo con il ‘selvaggio’. In realtà, è proprio attraverso la personalità di Okonkwo – comunque obbediente alle leggi del clan – che emerge, sullo sfondo degli inquietanti rumori notturni e dell’incessante suono dei tamburi, immenso battito del cuore della comunità, il ritratto di una società governata da regole che i bianchi hanno misconosciuto e meticolosamente annientato.
I bianchi arrivano. Come le locuste che, per la gioia degli abitanti di Umofia, si abbattono sul villaggio talmente numerose da spezzare i rami degli alberi. Ma se queste non possono far danni al raccolto, ormai messo in salvo, e una volta che la rugiada notturna ha appesantito loro le ali, possono essere catturate e fritte, trasformandosi in un cibo raro e prelibato, l’invasione da parte dei bianchi, accolta con lo stesso ingenuo e divertito fatalismo, non sarà altrettanto indolore né, tanto meno, fonte di gioia.
Anche in questa occasione, Okonkwo non smentisce la sua indole di guerriero e tenta in tutti i modi di smuovere lo spirito dei propri compagni. Per lui la soluzione è una sola e richiede le armi, ma il clan non è disposto a seguirlo nello scontro aperto.
I bianchi costruiranno la chiesa, sulla terra che Umofia ha loro concesso secondo un divertente e ingenuo piano di battaglia: agli uomini bianchi tutta la terra che desiderano, ma il suolo a loro destinato è quello della Foresta Malvagia, un luogo che per gli abitanti di Umofia è sinonimo di morte sicura. Questa decisione, per quanto strategica, si rivelerà un clamoroso autogol: i bianchi, spiati notte dopo notte, non moriranno, confermando ai più la considerevole potenza del loro dio.
In uno stillicidio di conversioni – tra le quali, la più dolorosa per Okonkwo, quella del proprio figlio – e di scontri inizialmente verbali, la missione cristiana si allarga e con lei la spaccatura fra gli indigeni e i loro fratelli convertiti. Da piccolo nucleo di conversione religiosa nel villaggio – tanto godibile nella narrazione quanto profondo nel suggerire riflessioni, il tentativo di comprendere il concetto di Santissima Trinità da parte di Okonwko, la cui rassegnata conclusione è che il missionario sia completamente pazzo – l’intervento dei bianchi si estende alle regole civili, sociali, giuridiche ed economiche.
Il suo ultimo e personale tentativo di rivolta, climax del romanzo, permetterà a Okonkwo di comprendere che sta combattendo una battaglia già persa, e che tutto ciò per il quale ha vissuto e in cui crede sta per soccombere al sopruso della colonizzazione. Da guerriero negherà la supremazia dei bianchi con l’unico gesto di libertà possibile.
Achebe ha scritto questo romanzo usando la lingua dei colonizzatori, forse perché sono loro i destinatari principali del messaggio. Ha tuttavia operato una scelta attenta nei simboli usati, come le locuste (palesemente simbolo dell’invasione dei bianchi) e il fuoco (costantemente accomunato in tutte le sue forme ai diversi moti dell’animo del protagonista), strettamente legati alla cultura nigeriana. Ma, soprattutto, ha conservato lo stile e la musicalità propri della lingua ibo, con frequenti ricorsi a metafore, proverbi, fiabe e vocaboli originali, col risultato di ottenere un ritmo e una ricchezza narrativa intimamente legati ai personaggi e al loro mondo.
Questa operazione linguistica non ha un risvolto puramente formale, è essa stessa energia tematica nel momento in cui la costruzione retorica delle conversazioni ibo si scontra con il linguaggio dei colonizzatori. Mentre questi ultimi danno valore all’immediatezza della comunicazione, gli ibo, così come alle proprie tradizioni, restano legati a un modello di dialogo considerato inefficiente dai bianchi. Nell’ultimo capitolo, il Commissario distrettuale pensa che una delle abitudini più irritanti di questi uomini sia proprio “la loro passione per le parole inutili”, a sottolineare la frattura è il fatto che la frase pronunciata dall’ ibo non è inutile affatto: come il lettore scoprirà è, invece, legata alla scelta finale di Okonkwo e nasconde in sé uno tra i valori etici più profondi della tradizione ibo.
L’intento dello scrittore è certamente quello di proporre una visione del proprio paese ben diversa da quella offerta dalla letteratura colonialista. Nelle pagine di Chinua Achebe appare una società strutturata dal punto di vista sociale ed etico, nella quale i valori ancestrali sono fortemente radicati; una società regolata dal ciclo delle stagioni e legata alla terra, con le proprie leggi e i propri codici, anche se non sempre comprensibili agli occhi di un bianco.
Quanto più questa società si delinea come organizzata, tanto più forte è la percezione dello stupro perpetrato dal colonialismo bianco.
Nonostante questo, ciò che rende valida l’opera di Achebe è la sua equidistanza dalle colpe. Non si limita a imputare ai bianchi la scomparsa di una civiltà, ma sottolinea anche la passività della propria gente e come la decisione di abbracciare una nuova fede e nuove regole abbia accelerato il crollo. Con estrema obiettività, Achebe evita che il lettore codifichi i personaggi della storia in buoni (neri) e cattivi (bianchi), ed evidenzia al tempo stesso la necessità di coesione, di difesa dei propri valori, elementi indispensabili per opporsi alla violenza culturale e fisica dell’imperialismo.
E’ lo scrittore a sostenere per bocca di Obierika: “Come pensi che possiamo combattere quando i nostri stessi fratelli si sono rivoltati contro di noi? L’uomo bianco è molto astuto. E’ venuto adagio e in pace con la sua religione. Noi ridevamo della sua follia e gli abbiamo permesso di restare. Adesso ha conquistato i nostri fratelli e il nostro clan non può più essere quello di prima. Ha messo un coltello tra le cose che ci tenevano uniti e noi siamo crollati giù”. Ed ecco che la rabbia e il desiderio di rivolta di Okonkwo acquistano luce e ragione d’essere. E il chi – ovvero il dio individuale che determina la buona o la cattiva sorte, qualcosa di molto simile al dio Fatum dei latini – spesso menzionato nell’arco della narrazione, rende Okonkwo, in tutto e per tutto, un eroe tragico, simbolo di valori cancellati dalla violenza di una cultura che si reputa superiore.
Alla frase di chiusura del romanzo Achebe affida la sua sarcastica opinione sul progetto culturale imperialista, rappresentato dal libro che il Commissario distrettuale, etnologo dilettante, sta per scrivere. Il funzionario, davanti al sacrificio di Okonkwo, pensa di dedicare all’avvenimento un capitolo, al massimo.
Ed ecco la frase, lapidaria: “Aveva già scelto il titolo dopo averci pensato a lungo: La pacificazione delle popolazioni primitive del basso Niger”. Un vero condensato di ironia, a partire da quel “dopo averci pensato a lungo”, dal quale traspare tutta l’autoreferenzialità dell’uomo bianco – concentrato più sul titolo che non sulla civiltà di cui pretende di occuparsi – per finire con una parola condiscendente come pacificazione, a sottolineare il concetto di esseri primitivi incapaci di vivere in società. Il colonialista pretende di fornire indicazioni sul modo di esportare ordine e benessere in una civiltà che egli stesso ha invece sconvolto e sovvertito.
Sebbene collocata in uno spazio e in un’epoca precisi, la vicenda appare in realtà senza luogo e senza tempo, come accade per ogni grande romanzo. Achebe ci parla, infatti, di civiltà negate, di culture dominanti e di tradizioni annientate. Temi attuali nel nostro panorama politico e sociale, che i detrattori liquidano con lo stigma del relativismo. In realtà, il problema non è quello di fittizie classifiche razziali e culturali, bensì quello di potenze imperialiste il cui fine ultimo è, da sempre e oggi più che mai, quello di imporre la supremazia del proprio modello culturale, in una simbolica e fattuale conquista della Terra.
Il Crollo, Chinua Achebe, Edizioni e/o, ristampa 2006

