La critica del capitalismo nel cinema di J.C. Chandor
Tra i registi più interessanti del panorama statunitense, Jeffrey McDonald Chandor – in arte J.C. Chandor – occupa sicuramente un posto di rilievo. Il suo è un cinema del dettaglio, che non teme di confrontarsi con gli aspetti tecnici dei mondi che si propone di analizzare nei suoi film, siano essi gli uffici di Wall Street, un’azienda legata al commercio e alla distribuzione di olii combustibili o una società privata di servizi militari. Il motivo conduttore è sempre una feroce critica al sistema capitalistico, un Leviatano di fronte a cui gli esseri umani scompaiono come individui per essere ridotti a mere funzioni. Risulta allora programmatica anche un’altra caratteristica del cinema di Chandor – ciò che in altri contesti sarebbe da considerarsi un grave errore narrativo, ma che qui si pone, al contrario, come una felice scelta stilistica in rapporto al tema – ovvero la quasi totale assenza di informazioni riguardo al passato dei personaggi. Nel momento in cui elementi di tale passato emergono, lo fanno in maniera, per così dire, casuale e frammentaria.
Se è il Capitale a regolare la vita di chiunque, se tutti siamo sussunti al Capitale in un modo o nell’altro, allora anche la storia personale di ciascuno non può che rivelarsi la storia di tale sussunzione, e il dettaglio tecnico, più che la memoria, si presenta come un elemento chiave per comprendere la psicologia di ogni personaggio. Insomma, in un mondo ormai reificato al parossismo, gli uomini cessano di essere padroni del loro destino: sono le cose a plasmare quest’ultimo. Dimodoché il Capitale sembra acquisire lo stesso ruolo che aveva il fato nella tragedia greca, con una differenza sostanziale, tuttavia, inerente alla dimensione morale. Quando gli eroi antichi venivano puniti per la loro hybris, era a un’idea di giustizia che tale punizione si rifaceva: il contatto ‘visivo’ tra la divinità e la creatura era ancora ben presente. Il Capitale, nei confronti degli uomini, sembra porsi, invece, alla maniera di Azathoth, il dio cieco e idiota che gorgoglia e bestemmia al centro dell’universo, descritto da P.H. Lovecraft nel suo Ciclo di Cthulhu. Aspetti che emergono in maniera lampante già nel primo film di Chandor, Margin Call (2011), dedicato alla crisi economica innescata dalla bolla dei mutui subprime.

Siamo a New York nel 2008. In un importante istituto finanziario di cui non viene mai fatto il nome – ma chiaramente ispirato a Lehman Brothers – è in atto una ristrutturazione aziendale che prevede numerosi tagli al personale. Tra i licenziati, c’è anche Eric Dale (Stanley Tucci), il quale, prima di andarsene, consegna al giovane Peter Sullivan (Zachary Quinto) una chiavetta USB contente un’analisi a cui stava lavorando. Analisi che si scopre ben presto consistere in una serie di scenari finanziari, che dimostrano la completa inaffidabilità del modello matematico applicato dalla banca negli ultimi anni per calcolare il rischio di investimento per la compravendita dei titoli legati ai mutui immobiliari: la maggior parte di quelli in possesso all’istituto si rivela così essere ‘tossica’. Che fare? Nel caso di un crollo del mercato – evento ormai certo – la chiamata a coprire le perdite (la margin call, appunto) porterebbe la società alla bancarotta, perché non ha la liquidità necessaria a farlo. D’altra parte, vendere tutto all’improvviso, anche a prezzi stracciati, salverebbe la società ma metterebbe in allarme i mercati, producendo un effetto a catena, con il risultato di mandare in rovina un mucchio di persone, perdendo allo stesso tempo di credibilità. Sappiamo com’è andata la storia. A noi interessa sottolineare come Margin Call, partendo dal particolare – il film è ambientato nel corso di ventiquattro ore circa a Wall Street – risalga all’universale, dimostrando la violenza e la corruzione intrinseche al sistema capitalistico preso nel suo insieme.
Emblematico, a tal proposito, il discorso tenuto da Sam Rogers (Kevin Spacey) ai dipendenti rimasti in seguito ai tagli al personale: “C’è un motivo se siete ancora qui. Molti vostri colleghi sono stati mandati via per sempre. Abbiamo passato l’ultima ora a salutarli. Erano dipendenti in gamba, efficienti, ma voi di più. Ora sono andati via e non dovete più pensarci. Questa è la vostra opportunità. In ogni settore di questo edificio e in ogni filiale da Hong Kong a Londra, succederà la stessa cosa. Quando avremo finito, tre persone su sette che si frapponevano tra voi e la poltrona del vostro capo saranno scomparse. Questa è la vostra opportunità. Io sono in questo posto da trentaquattro anni e posso dirvi che vi capiterà ancora una cosa del genere. Ma voi siete tutti sopravvissuti. Ed è questo il segreto di questa società, che in centosette anni è diventata sempre più forte. Quindi, a testa alta, rimettetevi al lavoro. Un applauso”. Insomma, una chiara manifestazione del darwinismo sociale che regola i rapporti all’interno delle società capitalistiche, a partire dal proprio ambiente di lavoro, dove il vecchio detto mors tua vita mea sembra essere inciso indelebilmente nelle coscienze di tutti gli individui. In realtà, Sam vive un forte conflitto interiore, che lo rende forse il personaggio più interessante del film, il vero e proprio protagonista – per quanto l’impianto dell’opera sia corale. Come Amleto, non smette mai di dubitare, ma proprio i suoi dubbi gli impediscono, alla fine, di agire per il meglio, accettando passivamente la decisione di vendere tutti i titoli tossici nel corso della mattina seguente da parte di John Tuld (Jeremy Irons) – il grande vecchio al vertice della società.
Prima che ci venga presentato questo personaggio, tuttavia, Chandor ci fa risalire, insieme a Peter Sullivan, all’analista junior Seth Bregman (Pen Badgley) e al loro capo Will Emerson (Paul Bettany), tutta la scala gerarchica – o perlomeno i suoi gradini essenziali – in modo da offrire allo spettatore una microfisica del potere. Eccoci allora fare la conoscenza di Jared Cohen (Simon Baker) e Sarah Robertson (Demi Moore), due dirigenti dell’istituto finanziario, i quali, una volta compresa la gravità della situazione e consapevoli che qualche testa dovrà cadere, non si risparmiano minacce e punzecchiature, a sottolineare ancora una volta la logica estremamente competitiva che permea gli ambienti del Capitale. “Non pensarci nemmeno a fottermi, questa volta,” dice Sarah a Jared. “Perché, se andremo a fondo, sai benissimo che ci andremo insieme”. Al che lui risponde: “No, non ne sarei così sicuro”. Sarah, del resto, era stata la principale responsabile del licenziamento di Eric Dale all’inizio. Ed è per una sorta di contrappasso che, verso la fine del film, i due si ritrovano a sedere fianco a fianco a parlare delle rispettive buonuscite.
Fino a quel momento, Eric era risultato irreperibile, anche perché il suo numero di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica erano stati bloccati dalla banca, come quelli di chiunque altro fosse coinvolto nei tagli al personale – ulteriore conferma della riduzione dell’essere umano a mera funzione in seno al capitalismo, scaduta la quale, viene letteralmente gettato via alla stregua di un rifiuto. Quando finalmente Will riesce a rintracciare Eric, ciò diventa occasione per un bellissimo dialogo in cui vengono messe a confronto l’economia reale e quella finanziaria, facendo riferimento al passato di Eric come ingegnere, periodo in cui, tra le altre cose, aveva progettato un ponte in grado di far risparmiare – dal 1986 al 2008 – un totale di quasi sette miliardi di miglia alla popolazione dei due centri collegati, traducibili, in termini di tempo, in 1.531 anni di vita. Qualcosa di utile, dunque. Qualcosa di concreto. Non come i profitti realizzati nell’ambito dell’economia finanziaria, ai quali non corrisponde la produzione di alcun valore d’uso in rapporto al bene comune.
E vale la pena sottolineare che anche Peter Sullivan aveva dichiarato, in una scena precedente, di avere una laurea in ingegneria, confermando così l’affinità elettiva tra i due personaggi, già anticipata, a livello simbolico, nella scena in cui Peter era stato scambiato per Eric da una responsabile delle risorse umane. Senonché Peter sarà uno dei pochissimi a essere promossi in seguito alla svendita dei titoli tossici, mentre tanti altri ancora verranno licenziati. Ma, in effetti, tutti i tipi umani che compaiono in Margin Call, anche quelli all’apparenza più sensibili, cedono, infine, alle lusinghe del Capitale – o alle sue minacce. E il motivo è sempre uno, il denaro, il quale viene richiamato più volte nel corso della storia per bocca di Seth Bregman, personaggio che sembra quasi svolgere la funzione di un coro greco in rapporto a questo tema. Egli è, infatti, ossessionato dai profitti stratosferici dei suoi capi. Profitti che, tuttavia, si rivelano estremamente volatili, come dimostra la scena in cui Will dichiara di aver speso quasi tutti i due milioni e mezzo guadagnati l’anno precedente, tra il fisco, l’acquisto di una casa, quello di un’auto, i soldi dati ai genitori e stravizi vari: il Capitale è un mostro che divora se stesso.
Il denaro è anche il motivo per cui Sam deciderà, alla fine, di restare al fianco di John Tuld all’interno della società: “Io resto, John, e non per il tuo bel discorsetto. Ma perché ho bisogno di soldi. Sembrerà strano dopo tutti questi anni, ma ho bisogno di soldi”. Il discorsetto a cui si riferisce è una specie di arringa in cui risulta percepibile in filigrana la filosofia nicciana del superuomo: “Tu dici che forse abbiamo mandato sul lastrico della gente oggi. E tutto questo inutilmente. Ma tu praticamente lo fai ogni giorno da quasi quarant’anni, Sam. E, se tutto questo è inutile, allora lo è anche quello che c’è là fuori (dalla finestra, N.d.A.). Sono solamente soldi. Nient’altro che un’invenzione. Pezzi di carta che evitano di ammazzarci a vicenda per prendere qualcosa da mangiare. Non è sbagliato. E sicuramente non è diverso oggi da come è sempre stato. […] È sempre la stessa cosa che si ripete nel tempo. Non possiamo farci niente. E io e te non possiamo controllarla o fermarla e neanche rallentarla né alterarla impercettibilmente. Noi interagiamo. Se facciamo bene, guadagniamo tanto. Se sbagliamo, finiamo in mezzo alla strada. C’è sempre stata e ci sarà sempre la stessa percentuale di vincitori e di perdenti […] a questo mondo. Sì, probabilmente oggi quelli come noi saranno un po’ di più, ma le percentuali rimangono esattamente le stesse”.
E ha ragione, soprattutto quando dice che è sempre la stessa cosa che si ripete nel tempo: sono le crisi cicliche del capitalismo, dovute alla caduta tendenziale del saggio di profitto. Il problema non sta soltanto nell’economia finanziaria, dunque, ma nella struttura stessa del Capitale: solo superandola in senso rivoluzionario sarebbe possibile porre le condizioni per uscire da una simile coazione a ripetere. Ma oggi uno scenario del genere sembra quantomai improbabile, tanto più che la sussunzione della vita da parte del Capitale, la sua creazione continua di falsi bisogni, ha fatto sì che qualsiasi sfera dell’esistenza umana sia stata ormai integrata all’intero sistema di dominio sociale, producendo così l’uomo a una dimensione, secondo l’esemplare definizione data da Marcuse nel suo saggio più famoso. Emblematico, a tal proposito, il discorso tenuto da Will a Seth: “La gente vuole vivere con le sue macchine e le sue ville di lusso che non può permettersi, quindi tu sei necessario per loro. L’unico motivo per cui tutti continuano a vivere come dei re è perché noi spostiamo l’ago della bilancia in loro favore. Ma, se non lo facciamo, beh, tutto il mondo diventa improvvisamente giusto, cazzo, ma nessuno lo vuole davvero. Dicono il contrario, ma ti assicuro che non è vero. Vogliono quello che noi abbiamo da dare loro. Ma vogliono anche fare gli ingenui e fingere di non sapere da dove venga. […] La cosa buffa è che, se domani tutta questa baracca va a puttane, ci metteranno in croce per aver azzardato troppo. Ma, se non succederà e ci rimetteremo in carreggiata, quelle stesse persone rideranno fino a pisciarsi sotto, perché sembreremo i più grandi fifoni che Dio ha messo al mondo”.
Margin Call non intende lasciare al pubblico alcuna, seppur flebile, speranza. Nella scena conclusiva, vediamo Sam intento a scavare una fossa per il suo cane morto di cancro al fegato, malattia dalla chiara valenza simbolica in cui si riverbera quell’altro male, strutturale al capitalismo, che per anni aveva divorato silenziosamente l’economia dall’interno, fino a portarla all’ennesimo – inevitabile – collasso. Un collasso che certamente era già stato previsto con largo anticipo da uomini come John Tuld, a cui Sam aveva rivolto in precedenza una frase estremamente significativa in rapporto alla decisione di sbarazzarsi di tutti i titoli tossici nel giro di poche ore: “È ovvio che tu operi con più informazioni di quelle che ho io”. Non c’è musica ad accompagnare i titoli di coda. Solo il rumore della pala sul terreno che echeggia funerea nel buio dello schermo.

Tutt’altro scenario è quello di All is lost (2013), il secondo film di Chandor, dove un uomo (Robert Redford) su un piccolo yacht a vela, disperso nell’Oceano Indiano, lotta per la sopravvivenza. Alle tempeste della Borsa si sostituiscono quelle prodotte dagli elementi, forze naturali contro cui l’essere umano si oppone in una situazione che ricorda, per certi aspetti, la vicenda descritta da Hemingway ne Il vecchio e il mare, dove vengono affrontati temi universali come la morte, la solitudine, il tempo, l’esistenza intesa come sfida al destino – senza contare gli innumerevoli altri riferimenti che potrebbero essere fatti all’Odissea di Omero e a tanti altri romanzi di autori come Melville o Conrad. Ci si potrebbe chiedere, a questo punto, cosa c’entri tutto questo con la feroce critica al capitalismo che abbiamo detto essere presente nell’intera opera di Chandor. Analizzando il film a livello metaforico, tuttavia, saltano all’occhio diverse questioni che rimandano direttamente a tale argomento.
Dopo una sorta di prologo in cui la voce fuori campo pronuncia l’unico discorso complesso presente nell’intero film – il resto delle rare parole proferite da Redford, unico personaggio della storia, si limitano a imprecazioni e grida di aiuto – scopriamo che lo scafo dello yacht è stato sfondato nottetempo dallo spigolo di un container perduto da una nave mercantile. Lo stesso che vediamo incombere nella scena di apertura alla stregua di un monolito kubrickiano, mentre ci viene comunicato quello che scopriremo poi essere il testo di un messaggio in bottiglia: “Mi dispiace, so che non significa molto ormai… Ma mi dispiace. Ci ho provato. Penso che siate tutti d’accordo che ci ho provato. A essere sincero, a essere forte, a essere gentile, ad amare, a essere onesto. Non ce l’ho fatta. E questo voi lo sapete. Ognuno per le sue esperienze. E mi dispiace. Tutto è perduto ormai. Tranne l’anima e il corpo o quello che ne rimane… E provviste per mezza giornata. Non ho scuse, lo so. Adesso lo so. Quello che non so è perché ci sia voluto tanto per ammetterlo. Ma l’ho fatto. Ci ho provato fino alla fine. Non so quanto sia servito. Ma so di averlo fatto. Avrei voluto dare di più a tutti voi. Mi mancherete”.
Sono le uniche informazioni che Chandor ci rivela a proposito del suo protagonista – le parole di un uomo che, percependo su di sé l’incalzare della morte, riflette sulla propria esistenza per trarne un bilancio finalmente sincero. E il tema esistenziale è certamente presente nell’opera, insieme agli altri a cui abbiamo accennato. Ma appunto il container ci rimanda subito al mondo delle merci di cui il Capitale è centro e motore. Sembrerebbe un collegamento azzardato, se non fosse che, dopo una tempesta che distrugge definitivamente lo yacht, costringendo il protagonista a trasferirsi su un canotto di salvataggio, l’unica speranza per quest’ultimo pare essere riposta nel raggiungimento di quella fascia di mare interessata dal transito delle navi mercantili. Il che avviene puntualmente per mezzo delle correnti che trascinano il canotto alla deriva. E sono ben due le navi che, in momenti diversi, potrebbero raccogliere il naufrago, subito pronto a sparare alcuni razzi di segnalazione nella loro direzione… Inutilmente. Perché il flusso delle merci non può fermarsi. Il Capitale è indifferente alla sorte degli uomini. E chiaro risulta a questo punto il parallelismo tra la violenza cieca degli elementi e quella – altrettanto cieca – del denaro in una realtà dominata dalla logica del profitto. Non è un caso, dunque, che la salvezza per il protagonista non giunga dalle navi mercantili, ma, quando è ormai rassegnato a morire e ha già affidato il suo messaggio in bottiglia alle onde, da un’imbarcazione al di fuori delle rotte commerciali – probabilmente un piccolo peschereccio.
A differenza di Margin Call, questo film si chiude, dunque, su una nota di speranza: la vita, rappresentata dalla mano che si tende ad afferrare quella del protagonista, invece che la morte manifestata dal rumore della pala sul terreno. Una vita che può venire, tuttavia, solo dagli ‘umili’ – alla maniera pasoliniana – ancora capaci di provare sentimenti di solidarietà verso il prossimo.
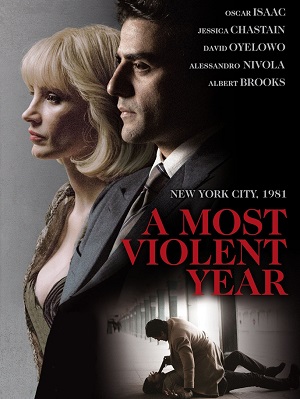
Il terzo film di Chandor ci fa, invece, tornare a New York, ma l’anno non è più il 2008, come in Margin Call, bensì il 1981 – secondo le statistiche della polizia, uno degli anni in cui è stato consumato il maggior numero di crimini violenti nella città. A most violent year (2014) è, infatti, il bellissimo titolo originale di questo lavoro, traslato in italiano con l’orribile 1981: Indagine a NewYork, ennesima conferma di come le case di distribuzione nostrane siano dominate dall’idea di doversi riferire sempre e comunque a un pubblico di lattanti.
Abel Morales (Oscar Isaac) è un imprenditore di successo, impegnato nel settore degli olii combustibili, che crede fermamente nel sogno americano e, nonostante i continui sabotaggi da parte della concorrenza, attuati per mezzo di furti ai camion che trasportano la sua merce, sembra intenzionato a mantenersi onesto. Sembra è la parola chiave di tutto questo film. La moralità di Abel è destinata infatti a rivelarsi una maschera talmente aderente alla sua pelle da confondersi con essa. Fino alla svolta conclusiva, lo spettatore è portato a domandarsi se egli sia davvero in buona fede oppure no, in quanto lo stesso Abel mostra di credere fermamente alla propria rettitudine. L’ambiguità è, dunque, la dimensione protagonista di questo film, che per ambientazione, atmosfere, tematiche deve molto al noir e al gangster movie – pur presentando elementi di indiscutibile originalità, a partire dal fatto che Abel non è certo un gangster nel senso classico del termine.
Il crimine circonda la sua impresa. La sua stessa moglie, Anna (Jessica Chastain) – sorta di Lady Macbeth, decisa ad avere un ruolo attivo nell’ascesa al potere del marito – viene da una famiglia di mafiosi, e uno dei concorrenti di Abel, seppur rispettoso nei suoi confronti e addirittura amico all’apparenza – se di amicizia si può parlare in simili contesti – è Peter Forente (Alessandro Nivola), altro personaggio colluso con il mondo della criminalità organizzata a cominciare dai suoi legami di sangue. Non mancano scene iconiche del genere, come i classici dialoghi dal barbiere, presenti, tra gli altri, in film come Gli intoccabili di Giuliano Montaldo (1969) – da non confondere con l’omonimo lavoro di Brian De Palma del 1987 – e Donnie Brasco di Mike Newell (1997). Eppure la violenza di cui vuole parlarci Chandor con A most violet year è una violenza più sottile e diffusa di quella perpetuata dai criminali ‘specializzati’ – una violenza sistemica. Per questo Abel si mostra così restio a dotare gli autisti dei suoi camion di un’arma con cui difendersi. E, quando scopre che la moglie ha acquistato una pistola illegalmente, intimorita dalle continue minacce rivolte alla loro famiglia – di cui fanno parte anche due bambine – non le risparmia insulti e grida di accusa: “Sei completamente idiota, sei peggio di quello che pensavo… Tu vuoi proteggere le bambine? Proteggerle, vero? Lo sai, Anna, che cazzo succederebbe se, per caso, ti dovessero beccare con quella in mano?”
A preoccupare Abel, tra le altre cose, c’è, infatti, un’indagine in corso sulla sua società da parte del fisco. In teoria, lui sostiene che l’azienda non ha mai rubato alcunché, ha sempre pagato le tasse con regolarità. E sembra esserne sinceramente convinto. Senonché un altro dialogo con la moglie risulta rivelatore da questo punto di vista. Quando lei ammette, infine, di aver sottratto – in qualità di contabile – somme ingenti alla ditta per farle confluire in un conto segreto da cui attingere in caso di difficoltà, il litigio che ne scaturisce porta Anna a una lampante esposizione del nocciolo tematico di A most violent year: “Tu ti vanti in giro da una vita, dicendo che tutto è nato solo dal tuo impegno, dalla tua fortuna, dal tuo charme, ti senti il signor cazzo di sogno americano, ma non è stata solo la fortuna a seguirti, perché tutto il resto tu lo devi a me. Non immagini neanche quanto ho fatto per te. […] Sei stato così bravo a nascondere al tuo ego come andassero in realtà le cose. Non svegliarlo adesso a causa mia”. Tutto il resto tu lo devi a me. Se consideriamo che Anna viene da una famiglia di mafiosi – e la storia di qualsiasi organizzazione criminale può essere letta, a un certo livello, come la storia del capitalismo nella sua fase di accumulazione primitiva – risulta chiaro il valore simbolico di questa frase in quanto espressione del rapporto diacronico e sincronico – in questo caso, un termine non esclude l’altro – tra Anna e Abel. Egli è il Capitale che, in una fase successiva alla sua accumulazione, pretende di purificarsi da ogni forma di violenza diretta, nondimeno necessaria al suo conseguimento. Ma la violenza non smette mai di pervaderlo, mentre plasma il mondo a propria immagine e somiglianza. Ed è questo il significato della tragica scena finale in cui Julian (Elyes Gabel) – un giovane che aveva lavorato per Abel come autista di camion – si suicida, sparandosi un colpo alla testa sotto lo sguardo compiacente del suo ex padrone.
Come l’Ofelia di Shakespeare, egli è una vittima delle circostanze. Traumatizzato da un un’aggressione a scopo di rapina subita all’inizio del film da parte della concorrenza, una volta tornato al lavoro, Julian decide, nonostante le direttive contrarie al riguardo, di farlo armato. Il che provoca una sparatoria in mezzo alla strada, quando immancabilmente i rapinatori si rifanno vivi per sottrargli il camion che guida. L’arrivo della polizia fa fuggire sia i rapinatori che Julian. È qui che gli eventi cominciano davvero a precipitare – per Abel, il quale, pressato su più fronti, perde il sostegno della banca su cui contava per completare l’acquisto di un deposito sul quale aveva investito tutto il suo denaro, mosso dall’idea di far crescere ulteriormente l’azienda; per Julian, diventato ormai un latitante. E vale la pena parlare ora un po’ più approfonditamente di questo personaggio, considerata la funzione essenziale che svolge all’interno della storia.
Egli prova per Abel un’ammirazione smisurata, lo ha mitizzato in virtù della sua apparenza di self made man, considerandolo alla stregua di un benefattore, un uomo forte e generoso, pronto a offrire a tutti i suoi dipendenti un’occasione per diventare come lui: non cogliere tale occasione significa, secondo lo stesso credo di Julian, scoprirsi debole, inadeguato. La sua ingenuità è l’ingenuità di chi crede alla rispondenza al vero del sogno americano. Anche Abel sembra crederci all’inizio. Ma la differenza tra i due è che Abel possiede il denaro – anche quando sembra averlo esaurito – e, dunque, una via d’uscita dai propri problemi, l’unica realistica in un mondo dominato dal Capitale, dove il campo dei possibili di ogni essere umano dipende invariabilmente dalle sue facoltà economiche. Julian, d’altra parte, non possiede alcunché, nemmeno una coscienza che gli permetterebbe di comprendere che il gioco è truccato – ed è questo il motivo per cui, invece di sparare ad Abel, alla fine, si suicida. Abel non preme mai direttamente il grilletto. Ma crea le condizioni perché altri lo facciano per lui. E quando, pochi istanti prima di sparare, Julian gli chiede di occuparsi della sua fidanzata, Abel è perfettamente consapevole di quanto sta per accadere e, annuendo, è come se firmasse la condanna a morte del ragazzo.
Non è un caso che questa scena si svolga proprio nel perimetro del deposito che Abel riesce ad acquistare, infine, anche e soprattutto in virtù del denaro attinto dal conto segreto di Anna. Trapassando da parte a parte il cranio di Julian, il proiettile perfora una cisterna alle sue spalle, dimodoché il rosso del sangue si mescola significativamente al nero dell’olio combustibile contenuto all’interno. E il primo pensiero di Abel, a questo punto, non va a Julian, bensì al fatto di tamponare la perdita con un fazzoletto: in un mondo dominato dalla logica del profitto, qualche goccia di una sostanza inorganica ha più valore di una vita umana. Basterebbe questa scena a riassumere magistralmente il messaggio di A most violent year. Ma Chandor non si accontenta di rivelarci il Caino travestito da Abele che è il suo protagonista.
Un altro personaggio, che finora sembrava essere caratterizzato da una moralità inflessibile, mosso dall’unico intento di svelare le irregolarità fiscali dell’azienda di Abel – il detective Lawrence (David Oyelowo) – dimostra, in realtà, di avere ben altri fini: “Oggi ha concluso l’affare con questo deposito, vero? Non avevo realizzato che mirasse a questo. Le darà una posizione decisamente rilevante. Cioè, forse, alla fine, prenderlo e dirigerlo avrà anche una significativa influenza politica, vero? Tutti abbiamo delle ambizioni, Abel. Ma per realizzarle, a volte, servono degli aiuti. Lei ha fatto davvero tanta strada… In pochissimo tempo”. E quando Abel gli risponde che non la vede così e Lawrence dovrebbe avere capito ormai che lui ha sempre scelto solo la strada della correttezza – perché “c’è sempre una via della correttezza, anche in questo caso” – tale discorso, unito alla replica del detective – “Lo spero” – è un capolavoro di doppi fondi, nascosti sotto la superficie delle parole, in cui si riverberano ancora i temi dell’ambiguità e della corruzione intrinseca al sistema capitalistico, degna conclusione di quello che, allo stato attuale, è probabilmente il film più potente tra i quattro realizzati dal regista statunitense, impreziosito, tra l’altro, da una colonna sonora che rimanda alle atmosfere del vecchio West, come a dire che Abel e gli individui del suo stampo sono, in fondo, i discendenti diretti di quei pistoleri che nell’Ottocento si sfidavano in un gioco al massacro per imporre al mondo la propria volontà di potenza.
Da notare, a questo proposito, i continui riferimenti, nel corso del film, alle agevolazioni fiscali che l’amministrazione Reagan intendeva apportare alle aziende già dal primo anno del proprio mandato in combinazione ad altre riforme tipiche del capitalismo giunto alla sua fase neoliberista: lasciare che il mercato si ‘regoli’ da sé, svincolato da qualsiasi forma di controllo pubblico, non significa forse ritornare – nemmeno troppo metaforicamente – a quella lotta di tutti contro tutti in un contesto non ancora toccato dal processo di normalizzazione, che caratterizzava appunto il vecchio West?
Se, dunque, A most violent year spicca come la punta di diamante di tutta l’opera di Chandor, il film seguente, Triple Frontier (2019), si pone, invece, come quello meno riuscito, seppur in un panorama, come abbiamo visto, di altissimo livello.
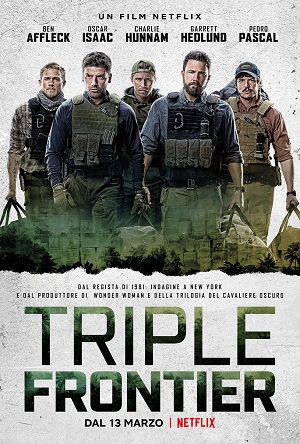
Santiago ‘Pope’ Garcia (Oscar Isaac) è un ex membro delle forze speciali statunitensi, il quale possiede ora una propria società privata di servizi militari, legata da un contratto con un’agenzia del governo colombiano per la lotta al narcotraffico. Il blitz in una cittadina tra le montagne per prendere – vivo o morto – il boss Gabriel Martin Lorea (Reynaldo Gallegos), fallisce, ma subito dopo Yovanna (Adria Arjona), l’informatrice di Santiago, dichiara a quest’ultimo di conoscere il punto esatto della giungla brasiliana in cui si nasconde il narcotrafficante – insieme ai suoi soldi. Rientrato negli Stati Uniti, Santiago mette allora insieme una piccola squadra di suoi ex commilitoni, tornati, nel frattempo, alla vita civile: Tom ‘Redfly’ Davies (Ben Affleck), riconvertitosi come agente immobiliare, padre di una figlia adolescente, un matrimonio fallito alle sue spalle; i fratelli William (Charlie Hunnam) e Ben Miller (Garreth Hedlund), molto bravo, il primo, a tenere discorsi motivazionali ai soldati freschi di addestramento per convincerli a restare nell’esercito e non cedere alle lusinghe del settore privato – salvo poi accettare, quasi senza battere ciglio, l’offerta di Santiago di cui parleremo più approfonditamente a breve – pugile dilettante, il secondo; Francisco ‘Catfish’ Morales (Pedro Pascal), ex pilota di aerei a cui è stata revocata la licenza per possesso di droga, più precisamente, cocaina, la stessa sostanza su cui Lorea ha fondato il suo impero.
La dinamica cinematografica con cui Santiago riunisce il gruppo ricorda molto da vicino quella di caper movie come Rififi (1955) di Jules Dassin o, in tempi più recenti, Ocean’s Eleven (2001) di Steven Soderbergh. In tale genere di film, ruotanti attorno a una grande rapina, c’è sempre, infatti, una fase di preparativi che riguarda innanzitutto il reclutamento degli specialisti necessari a compiere il colpo. E un vero e proprio ‘colpo’ è appunto ciò che Santiago ha in mente di perpetrare ai danni di Lorea, anche se, per il momento, si limita a parlare ai suoi ex compagni d’arme di una semplice missione di ricognizione, comunque pagata profumatamente, e certi ‘bonus’ che otterrebbero nel caso in cui decidessero di procedere a un’azione armata. Come spiega a Tom: “I diciassettemila [dollari] sono per la ricognizione. Ma […] potrebbero esserci molti più soldi. Ho fatto un accordo con l’agenzia del luogo. Ci teniamo il venticinque percento di ciò che troviamo. Secondo i miei calcoli, lui ha più di settantacinque milioni in contanti. […] Ho un’avvocatessa a St. Jones che ha aperto un conto offshore in un paradiso fiscale, è pronta a pagarci un salario e dei bonus per tutta la vita. Funzionerà come un normale stipendio. […] Non è [un’operazione] illegale. La mia società ha un contratto con un’agenzia del governo locale. Comunque, anche se fosse illegale, la maggior parte delle azioni che hai fatto tecnicamente erano contro la Convenzione di Ginevra, quindi…”
Ancora cifre e dettagli tecnici – tipici del cinema di Chandor – in rapporto, questa volta, agli enormi profitti che si generano attorno al mercato della guerra (1). Perché di guerra alla droga si parla sin dai tempi in cui l’amministrazione Nixon ha fatto di tale definizione uno dei suoi più martellanti slogan politici (2). Una guerra che, come ogni altra, lascia dietro di sé il suo strascico di vittime innocenti e violazioni ai diritti umani: da qui il riferimento alle azioni che Tom ha svolto in passato in barba alla Convenzione di Ginevra. Non è un caso che sia proprio tale personaggio – quello che all’inizio mostra più riserve in merito alla proposta di Santiago – a essere, in seguito, ‘posseduto’ in maniera tanto più pervasiva dal demone del denaro in un chiaro riferimento a Rapacità (1924) di Erich von Stroheim. Egli rappresenta, in effetti, il fulcro tematico di questo film e di tutta l’opera di Chandor: l’azione totalizzante del Capitale sulle coscienze degli individui. Dimodoché, quando Santiago e la sua squadra assaltano, infine, la villa del narcotrafficante, è appunto Tom a insistere perché venga caricata sul furgone una somma maggiore di quella che permetterebbe loro di compiere l’operazione nei tempi stabiliti, con il risultato di doversi scontrare con le guardie del corpo di Lorea di ritorno dalla funzione domenicale alla quale avevano accompagnato la famiglia del boss. A questo punto, è ormai chiaro a tutti che quella che stanno svolgendo non è un’operazione antidroga, bensì una rapina. Il piano effettivo di Santiago, esposto agli altri la notte precedente all’attacco, prevede, infatti, di non coinvolgere l’agenzia del governo locale, ma fare tutto per conto proprio in modo da tenersi l’intero bottino. E Lorea e le sue guardie del corpo non saranno i soli a morire in conseguenza di tale piano.
Quando l’elicottero con cui la squadra dovrebbe raggiungere il Pacifico, oltre il confine peruviano, precipita a causa del peso di oltre due tonnellate messo insieme dal denaro rubato – un incidente dalla chiara valenza simbolica in rapporto al ‘peso morale’ che il Capitale reca sempre con sé – Santiago e gli altri si ritrovano a fare i conti con gli abitanti di un villaggio tra le Ande, impegnati nella coltivazione delle foglie da coca – uomini e donne, vecchi e bambini, i quali rappresentano gli anelli più deboli di tutta la filiera del narcotraffico. In breve, la situazione si fa tesa, e Tom uccide uno dei contadini. Sarà questo a segnare la sua condanna a morte. Perché, se il vecchio a capo del villaggio mostra di accettare i soldi offerti da Santiago come risarcimento per tale perdita, mentre un’altra parte viene destinata all’acquisto di una cordata di muli che servirà a trasportare le borse con il denaro attraverso le montagne, un giovane, presumibilmente il figlio o il nipote della vittima, si porrà, invece, come la nemesi di Tom, eliminandolo in un’imboscata. Ma sarà appunto tale morte a far sì che i membri superstiti della squadra completino ognuno il proprio percorso di coscienza, parallelo al viaggio fisico affrontato nella giungla prima e sulle Ande poi. Un viaggio in cui vengono perse gradualmente parti sempre più ingenti della somma sottratta a Lorea, dimodoché viene a crearsi l’evidente equazione secondo cui meno sono i soldi trasportati dal gruppo, maggiore è l’umanità riconquistata da ciascuno dei suoi elementi. Senonché tale percorso di coscienza risulta poco credibile, e lo spettatore non può che sentirsi pervadere da un profondo scetticismo nel momento in cui vede Santiago animato dalla risoluzione di non sparare più a nessuno, nemmeno agli uomini del cartello di Lorea che – nel corso di un ultimo inseguimento – cercano di impedire ai ‘nostri’ di raggiungere la barca che li trarrà finalmente in salvo.
Il titolo di questo film ha, dunque, un valore chiaramente metaforico: le frontiere a cui si riferisce Chandor non sono solo i confini politici tra gli Stati o le ‘barriere’ naturali rappresentate dalla giungla, dalle montagne e dall’oceano. C’è anche una frontiera etica che Santiago e gli altri si rendono conto di avere superato e verso cui la scelta conclusiva di lasciare alla famiglia di Tom la propria parte di denaro – ridotta ormai a poco più di un milione a testa – costituisce un ‘ritorno morale’. Il fatto che dopo William porga a Santiago un biglietto con sopra scritte le coordinate di un crepaccio sulle Ande, dentro cui il gruppo era stato costretto a gettare la stragrande maggioranza del denaro in modo da proseguire nel suo viaggio, non basta a stemperare la stucchevolezza di questo finale. È come se Chandor, rendendosi conto di aver messo davvero troppi buoni sentimenti nell’epilogo del suo film, avesse voluto rimediare in extremis, suggerendo allo spettatore che il demone del denaro non è stato realmente sconfitto.
In effetti, l’impressione più forte che lascia Triple Frontier è quella di un’opera ‘schizofrenica’ – e forse non poteva essere altrimenti, considerando la travagliata storia della sua realizzazione. Il progetto esisteva, infatti, già dal 2010 e prevedeva inizialmente Kathryn Bigelow alla regia, Mark Boal alla sceneggiatura e Tom Hanks e Johnny Depp come protagonisti. Solo dopo vari slittamenti, Triple Frontier è finito nelle mani di Chandor, il quale ha modificato, in parte, la storia, che comunque, nella sua versione finale, conserva anche la firma di Boal. Due scritture molto diverse nello stile e nei contenuti, che, invece di fondersi armonicamente, sembrano impegnate in una lotta costante per prevalere l’una sull’altra. Per concludere, Triple Frontier resta un film da guardare, nonostante i suoi difetti – un’opera che avrebbe meritato un trattamento migliore, considerato il suo potenziale, ma che ha perlomeno il merito di puntare lo sguardo su un aspetto della realtà raramente affrontato nel cinema, quello delle società private di servizi militari.
1) Per approfondire il tema, rimandiamo a Giovanna Cracco, La prosperità della guerra, Paginauno n.79/2022
2) Per un approfondimento su tale argomento, rimandiamo al volume II dei Quaderni dei diritti globali. Droghe e diritti umani. Le politiche e le violazioni impunite a cura dell’Associazione Informazione Onlus, Mileu Edizioni


