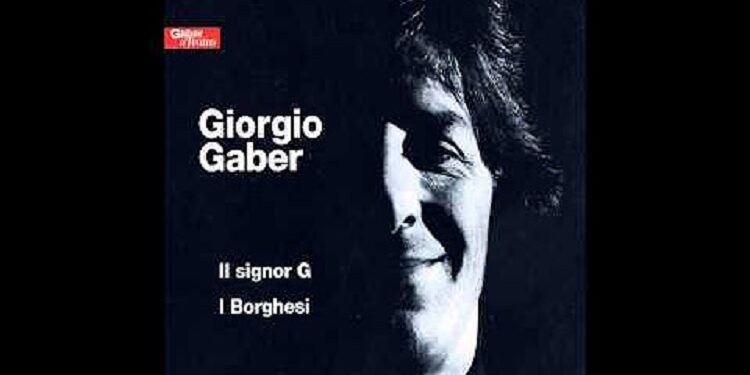Contestualizzare Giorgio Gaber, tra musica, politica e società
Nell’anno che segue la strage di Piazza Fontana – col consolidarsi delle istanze del cosiddetto “lungo Sessantotto” – la destrutturazione della canzone commerciale avviene anche attraverso la rilettura dei tic classisti dell’italiano-medio. Fuori dai denti e dentro i testi dei proto-cantautori, si revisiona cioè il modello di borghesia piccola piccola: ne Il signor G (Carosello 1970) di Giorgio Gaber l’orchestra conduce come sempre, ma l’attenzione è adesso concentrata sul messaggio. In un attacco da tragicommedia beckettiana ci sono un ricco e un povero (meglio, due bambini: il figlio di un ricco e il figlio di un povero) che conversano (?) fra loro:
Io mi chiamo G
No non hai capito sono io che mi chiamo G
No sei tu che non hai capito mi chiamo G anch’io
Ah. Il mio papà è molto importante
Il mio papà no
Il mio papà è forte sano e intelligente
Il mio papà è debole malaticcio e un po’ scemo
La mia mamma è molto bella, assomiglia a Brigitte Bardot
La mia mamma è brutta bruttissima, la mia mamma assomiglia… la mia mamma non assomiglia
Il mio papà ha tre lauree e parla perfettamente cinque lingue
Il mio papà ha fatto la terza elementare e parla in dialetto… ma poco perché tartaglia
Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con diciotto locali spaziosi
Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale… però c’ho diciotto fratelli
Siamo all’inizio di un decennio nodale – gli anni definiti dallo stesso Gaber come “affollati” –, e il romanticoide goliarda dei primi giri (45 e 33 giri) e della tv di Stato si politicizza, proponendo una forma di spettacolo rivoluzionaria, cioè senza antesignani né riferimenti coevi, caratterizzata dall’alternarsi di ballate e monologhi in prosa. A partire da Il signor G, con la neo-sodalità di Sandro Luporini per i testi, G. diverrà un compagno di viaggio ideale nell’Italia perenne delle crisi, della contestazione, quindi dello sprofondo interiore. Una sorta di alter-ego gaberiano con cui misurarsi e fare i conti, condividendone di volta in volta slanci e rassegnazioni, inciampi, bilanci, idee. Il signor G è insomma un album prodromo e già intelligente, in decisa contro-tendenza rispetto alla linea melodica edulcorata antecedente, e in parallelo a quella cantautorale ancora in parte presente.
Il tempo di ascrivere Gaber nel novero nascente dei cantautori e già lui bissa con I borghesi (Carosello, 1971), in cui il punto sulla situazione intrapsichica e sociale risulta ulteriormente espanso, e la polemica comincia ad averne per tutti: chiesa (La chiesa si rinnova), convenzioni (I borghesi), individuo (L’amico), coppia (Ora che non sono più innamorato). In un affresco disincantato di para-società che sogna la rivoluzione ma tende al reazionario. E se nella title-track, dietro il paravento della filastrocca finto-sciocchina, l’associazione borghesi-porci fa leccare barba e baffi ai contestatori in erba (“i borghesi son tutti dei porci/ più sono grassi più sono lerci”), il valzerino melodrammatico de L’amico accontenta chi è in cerca di maggiore introspezione. Surreale la trovata-pretesto de L’uomo sfera, che girovaga (rotola?) per le strade italiane-tipo, e ciò che vi rintraccia è tutt’altro che allegro. In altre parole: I borghesi attinge dall’humus di malesseri quotidiani da cui parrebbe non esserci ormai scampo. Si intravede già, in Gaber, come un desiderio di distanza, un malcelato bisogno di evasione, dai rapporti e dalle cose (Evasione). Siamo al cospetto di un primo disagio ontologico, raccontato a cavallo fra cantato e recitato, in chiave spesso ironica. Contraltare a tutto ciò, Un gesto naturale dove il peso della lotta per la vita traspare da azioni semplici, autentiche (parlare, respirare, sorridere). È il passaggio più poetico del disco, e anche quello che chiude la scaletta. Proprio ‘autenticità’ diventa, tra le righe di Gaber-Luporini, la parola totemica. La sola che possa (ri)dare spessore, conferire senso e significato alla vita. E all’amore (Ora che non son più innamorato).
Il 1972 è l’anno del Pinocchio televisivo di Luigi Comencini, del Padrino di Coppola e anche dello scandaloso Ultimo tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. In un’Italia sempre più a mano armata – quasi come nei poliziotteschi italioti con Luc Merenda e Maurizio Merli – anche i cantanti di Sanremo inscenano una manifestazione sindacale. Protestare è diventata, vivaddio, la moda del momento.
È in questo clima di rivoluzione allargata che esce Dialogo tra un impegnato e un non so (Carosello, 1972), ulteriore affresco italiano a luci e ombre targato Gaber-Luporini. Ironia (Lo shampoo) e idiosincrasia (Il signor G e l’amore). Politica e società in declinazione cronachistica (Nixon, Gli operai), e più lata (La libertà, Un’idea). Gaber e Luporini redigono le pagine ulteriori di un quaderno di lagnanze lucidissimo. Monologhi sferzanti alternati a canzoni feroci. Il Signor G è cresciuto in maniera esponenziale alla sua presa di coscienza. A partire da questo disco il mondo comincia a fargli male davvero. E G. lo dice. Lo dichiara. Lo urla. Lo denuncia. Senza falsi pudori. Né mezzi termini. Il disco è un attacco verbale al cuore della società. Al radicalismo di certa politica ottusa, miope, narcisista, presa di sé. Ma non la scampa nemmeno il cittadino comune. Politicizzato o no che sia. I dialoghi reiterati tra l’extraparlamentare-tipo e l’impiegato (l’impegnato e il non so) risultano in tal senso parabolici (la vera rivoluzione si farebbe “mangiandosi un’idea”). Come anche gli esempi di concetti e atteggiamenti reazionari disseminati nel disco. Il marito cornuto e consapevole, l’antirazzista smentito dai fatti, il militante per moda più che per convinzione (“Ho voluto andare ad una manifestazione, i compagni, la lotta di classe, tante cose belle che ho nella testa ma non ancora nella pelle”). Qualche intermezzo comico (come nel caso del già citato Shampoo) non stempera il clima angusto, di mal de vivre esistenziale prima ancora che sociale, che grava sul disco. Si ride e si mastica spesso amaro.
Nel 1973 esce Far finta di essere sani (Carosello, 1973), il disco gaberiano più maturo prodotto sin qui. Definitivo trapasso dalla fase ironica del Cerutti Gino al Teatro-Canzone. La nazione, dal canto suo, è morta di crisi nera e mancanza di slanci. Strangolata dal caro-petrolio e dalla messa al bando dei valori consolidati. Gaber accorre per primo sul luogo del delitto: l’omicidio dei sogni-ideali che avevano istradato la generazione di Dylan e Joan Baez. Nemmeno il Signor G gode di buona salute psicologica. E ancora una volta non esita ad ammetterlo. Senza infingimenti, senza risparmiarsi/risparmiarci nulla: piange, rantola, balbetta, singhiozza, soffre, in una sorta di diario collettivo/personale in cui la condizione borghese è vagliata ai raggi X dell’intelligenza critica. Tutto è detto, stigmatizzato, descritto: l’afasia di contemplare il fumo di una sigaretta, masturbarsi, sorprendersi impotente, nel fisico e nella mente. Vecchio e/o nuovo modo di vivere? Cos’è davvero la democrazia? Esistono Bene e Male?, e i buoni?, e i cattivi? Cambiano i tempi dei monologhi, il formato, la struttura delle canzoni. L’unicità di Gaber (rispetto al resto dei cantautori) risiede nella capacità di poter vestire e svestire registri diversi. Sorprendere. In Far finta di essere sani lo si scopre al contempo cabarettista, cantante, attore drammatico, intellettuale. Caustico. E libero, come pochi riescono a essere. Con l’ironia che diventa dominante, a volte aggressiva. Il filo rosso – che già trapelava negli spettacoli precedenti – è quello dell’interezza: corpo e mente – materialismo e slancio ideale – piuttosto che raccordarsi risultano divisi da un baratro inconciliabile. Un pretesto per mettere alla berlina, una volta di più, vizi e virtù dell’italiano-medio. Alle prese con crisi di coppia (Il narciso), dilemmi pubblici/privati (La comune, Chiedo scusa se parlo di Maria), alienazione esistenziale (Far finta di essere sani, Quello che perde i pezzi). Soprattutto quella.
Il successivo Anche per oggi non si vola (Carosello, 1974) ripropone una formula teatral-musicale ormai consolidata: monologhi e canzoni, secondo una scaletta in progress. Si fa strada il sospetto che qualsiasi cambiamento di rotta sia destinato allo scacco. Forti, e ad ampio raggio, le critiche: alla cultura, alla politica, e finanche all’idea di coppia così come appare strutturata ai tempi del femminismo dilagante e del maschio in crisi. Tra teoria e prassi – idea e sostanza – la crasi resta insanabile. Ne Il corpo stupido la libido è sganciata dalle affinità elettive (“Era perfetta ma non ho avuto voglia di toccarla […] Com’è corretta l’ideologia/ com’è ignorante la simpatia/ Io purtroppo non riesco a istruire il mio tatto/ non riesco a politicizzare l’olfatto/ ci ho il corpo stupido”). Gaber e Luporini liberalizzano il trionfo dei sensi: la sincerità dell’attrazione fisica contro l’artefazione del mentale. Ancora: ne L’odore il protagonista è assediato da un lezzo che non va via. Non basta lavarsi di continuo (inevitabile richiamarsi allo Shampoo e alla ‘candida’ apologia della schiuma, sciacquo e risciacquo): la puzza persiste. A ribadire la dittatura della materia greve sulla presunta superiorità delle sovrastrutture intellettualistiche, sulle formule artificiali. In Anche per oggi non si vola i temi in discussione (filosofica, politica) ci sono e sono tanti. Il doppio LP si dipana tra metafore (La realtà è un uccello) e agognate evasioni familiari (C’è solo la strada). Con i partiti che escono malconci dalle riflessioni de Le mani e I gag-man. A salvarci, forse, gli slanci utopici concentrati su un futuro non meglio identificato. Insieme con il bisogno di afferrare la realtà nel suo fieri più appassionato e vitale.
Nel 1976, in Italia, esce il primo numero de La Repubblica, scoppia lo scandalo Lockeed, l’eversione mira sempre più in alto e, in coda all’anno, la nazionale azzurra di tennis conquista la Davis. Libertà obbligatoria (Carosello, 1976), sin dall’ossimoro del titolo, non si lascia intenerire: un titolo-specchio fedele dei contenuti. L’ennesimo doppio album di Gaber che non si tira indietro e non le manda a dire e non risparmia nessuno. Il tema centrale del concept è un’analisi lucidissima della società italiana al suo livello più basso. Analisi che si estende a tutto l’Occidente malato. Non è più tempo di attacchi al solo sistema borghese. La rivoluzione ha fallito. Poco o niente è cambiato. È il momento di fare i conti con se stessi. Con alcuni dei modelli – ideali e comportamentali – della contestazione allo sbando. Raccogliere i cocci. Contarli uno a uno. Il risveglio dal sogno dell’utopia è stato brusco. La parola d’ordine adesso è si salvi chi può. Qualcuno tenta di ripiegare sul privato (I reduci). Qualcuno su se stesso (La solitudine). Ma a ben guardare non la sfanga nessuno. Né il potere politico (I partiti), né una sinistra di moda e già modaiola (La cacca dei contadini, La coscienza). In uno scenario tendente al cupo, la libertà viene a connotarsi come un’astrazione piuttosto che come un valore di fatto (L’America, Si può). Ciò che sembrava essere un inarrestabile processo rivoluzionario – sul piano delle coscienze, prima ancora che su quello storico e politico – comincia a disvelare i suoi limiti. Le sue contraddizioni. L’appiattimento dell’individuo preconizzato da Adorno e Marcuse, è adesso e qui. Si avverte un senso di impotenza. Un’incapacità di contrapporre istanze diverse al modello americano e alla sua trionfale avanzata. Si percepisce il disagio di una sconfitta collettiva non riconosciuta ancora come tale, ma in fondo si sa che è questione di tempo.
C’è il nuovo (Niente) che avanza, l’aria che tira tende all’afasico. E al temporalesco.
Nel successivo Polli d’allevamento (Carosello, 1978) il giocattolo si è rotto del tutto. L’euforia finita. I tempi volgono al peggio. Anche per Gaber che adesso si attira addosso gli anatemi di una sinistra passivo-aggressiva, guadagnandosi nomea di qualunquista. Polli di allevamento è un album scomodo-spietato. Cupissimo. Nichilista. C’è stato il Settantasette e Gaber e Luporini lo hanno bocciato senza remissione. In questo doppio 33 giri, i pochi punti fermi sopravvissuti alla crisi movimentista sono fatti a pezzi. C’è poco da stare allegri, il titolo stesso è apodittico. Chi sono i polli di allevamento? La società civile, smarrita e ideologicamente smagrita nel suo insieme: giovani, vecchi, donne, reduci e maneggioni, soprattutto i rampolli di un movimento giovanile in via di disgregazione. Inutile auto-ingannarsi, giocare agli impegnati. Per le strade e nelle piazze non si parla quasi più di vita vera. Alcuni scelgono strade prettamente politiche. Altri sparano. Altri ripiegano su posizioni di tipo misticheggiante. Ciò che in Libertà obbligatoria appariva come un sospetto di massificazione in Polli di allevamento si rivela realtà. Si trasforma in sfacelo. Da una parte il velleitarismo politico, dall’altra lo scadimento inerte degli ideali giovanili. Sempre più simili a una moda. Gli anni della tensione e della paranoia collettiva ne La pistola e La paura. L’ideologia come “dovere per il dovere” (L’ingenuo, Quando è moda è moda). L’ennesimo atto di accusa alla partitocrazia (Il palazzo, Salviamo ’sto Paese). La crisi infinita della coppia, immortalata tra desiderio e problematicità (Prima dell’amore). I grani di un rosario impietoso, pur se nella sua ironia. Un ritratto di borghesia in nero. Orchestrato da Franco Battiato e Giusto Pio che ne rivitalizzano l’assetto musicale.
Nel 1978 gli insulsi anni Ottanta sono alle porte, anzi sono già cominciati con le prime avvisaglie di un make-up sociale declinato in egotismo, disimpegno e vacuità. La mattina del 9 maggio, a Roma, viene rinvenuto il cadavere di Aldo Moro, introducendo di fatto al prevalere di retorica e a-criticismo di massa. Da allora in poi niente sarà più lo stesso. Né la storia né tanto meno il sentire civile degli italiani, divisi tra Rocky e Rambo, e approdati in massa sulle sponde di un privato-panacea di tutti i mali. Così è per la società. Così, giocoforza, per larga parte della canzone d’autore che s’avanza nel lustro delle dolci italie (Finardi, Bennato, Venditti) e dell’inessenziale tout court.
Giorgio Gaber continua a ragionare da disallineato. Il suo nuovo decennio comincia non a caso con la pubblicazione di due anomalie discografiche a stretto giro di boa. La prima anomala – invero poco riuscita –, rispetto al (suo) recente passato; la seconda in quanto furiosa fin quasi al dies irae.
Quando Gaber ritorna in sala di incisione, il 1980 è cominciato da poco. Lavora a Pressione bassa (Carosello, 1980), con l’intento di focalizzare lo smarrimento collettivo diffuso nel Paese. Svanito il tempo dei polli di allevamento e delle libertà obbligatorie, l’anamnesi gaberiana collassa ora su se stessa, rintracciando nei singulti dell’io (fermate e ripartenze) il suo campo di azione. Pure se con i limiti dovuti a una messa a fuoco ancora in fase di assestamento, Pressione bassa è per Gaber il disco germinale della cifra stilistica a venire. Un album di sole ballate (privo cioè della ‘materia prima’ e più incisiva dei monologhi) dibattute tra malesseri individuali (Pressione bassa) e disincanto (Non è più il momento). Otto tracce esplicative di un’impasse esistenziale (da un lato la mafia e il terrorismo, dall’altro il falso mito del benessere alla portata di tutti), a cui è difficile sottrarsi. Proprio per via del senso di impotenza che traspare dalle tracce, l’album incide meno dei lavori precedenti. La verve gaberiana si è come infiacchita, il disfattismo diventato quasi fine a se stesso. Due soli scatti di razza: l’apologo sentimentale de Il dilemma, e L’illogica allegria (l’euforia non può essere razionale perché non c’è nulla per cui stare allegri).
Niente insomma lasciava presagire la sontuosa impennata civile di Io se fossi Dio (F1 Team, 1980), il singolo dalla forza d’urto implosiva uscito nel novembre di quello stesso anno. Un ordigno efficientissimo, assemblato con soltanto musica e parole.
Negli anni bubble gum della Milano da bere, del craxismo incipiente e dell’Italia che andava a puttane fuori e dentro metafora, Io se fossi Dio è infatti il disco che nessuno vuole. Non lo vuole la fidata Carosello (Ricordi) che fa spallucce e se ne lava le mani. Non lo vogliono i partiti, umiliati e offesi per tardiva solidarietà col martire di Stato, Aldo Moro (nominato nel brano a una manciata di anni dal suo millantato martirio). Meno che mai lo vogliono stampa e televisioni già arruolate dal neo-sistema socialdemocratico al benpensantismo di massa e all’euforia di dovere. Insomma: nell’Italia ludens del 1980 Io se fossi Dio è il disco sbagliato nel tempo sbagliato. Livido di rabbia civile e ineducato com’è, rovina la festa continua che ha soppiantato la lotta continua. Un disco atipico nel formato (mini 33?, maxi 45?) e per durata (14 minuti): una sola traccia incisa sul lato A, la copertina nera, listata a lutto. I caratteri di stampa ‒ titolo del brano e nome dell’artista ‒ grezzi, da ciclostile politico. Il ciclostile con cui Gaber e Luporini annunciano la morte della nazione per surplus idiotistico, malaffaristico, rampantistico, politicistico, e persino euforistico a vuoto. Ai vagiti iniziali del craxismo reale, Io se fossi Dio risponde insomma come spigoloso controcanto civile, come viaggio al termine della notte italiana che non è finita mai.
… Io se fossi Dio naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente/ Nel regno dei cieli non vorrei ministri né gente di partito tra le palle/ perché la politica è schifosa e fa male alla pelle/ E tutti quelli che fanno questo gioco/ che poi è un gioco di forza ributtante e contagioso come la lebbra e il tifo/ E tutti quelli che fanno questo gioco c’hanno certe facce che a vederle fanno schifo/ Che sian untuosi democristiani o grigi compagni del PCI/ Son nati proprio brutti/ O perlomeno tutti finiscono così/ Io se fossi Dio dall’alto del mio trono vedrei che la politica è un mestiere come un altro/ E vorrei dire, mi pare Platone/ che il politico è sempre meno filosofo/ E sempre più coglione […] Ma io se fossi Dio non mi farei fregare da questo sgomento/ e nei confronti dei politicanti sarei severo come all’inizio/ perché a Dio i martiri non gli hanno fatto mai cambiar giudizio/ E se al mio Dio che ancora si accalora gli fa rabbia chi spara/ gli fa anche rabbia il fatto che un politico qualunque se gli ha sparato un brigatista diventa l’unico statista/ Io se fossi Dio/ quel Dio di cui ho bisogno come di un miraggio/ c’avrei ancora il coraggio di continuare a dire che Aldo Moro insieme a tutta la Democrazia cristiana è il responsabile maggiore di vent’anni di cancrena italiana/ Io se fossi Dio/ un Dio incosciente, enormemente saggio/ c’avrei anche il coraggio di andare dritto in galera/ Ma vorrei dire che Aldo Moro resta ancora quella faccia che era.