Maria Rita Prette*
Il punto di svolta del 1991: produzione di un conflitto permanente e non dichiarato, tecnologia militare e stato di propaganda: siamo in guerra da trent’anni
Credo sia molto importante parlare della guerra, una parola diventata un po’ tabù: nel senso che come Paese sono una trentina d’anni che facciamo guerre, anche se non le dichiariamo più e le chiamiamo con altri nomi. A ben vedere, quando ho fatto questo lavoro, anch’io ho faticato a chiamare ‘guerra’ le cose che ho incontrato, perché hanno un carattere sleale e feroce che va ben oltre il modo in cui i conflitti sono stati concepiti dall’umanità fino al 1991. Dobbiamo quindi guardare queste nuove forme delle guerre per come si esprimono, per come vengono fatte, per i dispositivi che attuano, a partire dal momento in cui hanno cominciato a essere realizzate in queste modalità, ossia: non più due eserciti che si confrontano.
Forse la seconda guerra mondiale è stato il conflitto ‘di passaggio’ verso questo nuovo modo, caratterizzato soprattutto dall’utilizzo dell’aviazione; ormai ci siamo abituati al fatto che si bombardino delle città, dei quartieri, dei Paesi, che li si rada anche al suolo. Penso che dovremo rifletterci, perché bombardare una città e raderla al suolo – come hanno fatto gli americani a Dresda nel 1945 e come abbiamo fatto noi in tutti Paesi in cui siamo stati, dalla Somalia all’Afghanistan, alla Libia, alla Siria – vuol dire colpire dei civili. Questo è il primo tabù che viene rotto dalle nuove forme della guerra: a morire sono principalmente i civili, molto meno i soldati.
Chiarisco subito che quando parlo dell’Italia, citando quello che i nostri eserciti hanno fatto nel mondo in questi trent’anni, mi riferisco allo stesso modo alla Nato e agli Stati Uniti, perché noi non siamo un’entità militare, uno Stato con un esercito dotato di sovranità: ospitiamo sul nostro suolo sette basi Nato, fondamentali per gli USA rispetto all’Europa dell’Est e all’Africa; queste sette basi sono accompagnate da altre 54 esclusivamente americane, e da un certo numero di basi miste, un po’ italiane, un po’ americane e un po’ Nato. Quindi siamo a tutti gli effetti una colonia statunitense. Dal 1945 a oggi, ciò che abbiamo fatto a livello militare dipende principalmente da questo punto. O per meglio dire, ci sono due binari attraverso i quali il nostro Stato, in nostro nome, fa delle guerre.
Il primo è la sudditanza che abbiamo appena visto. Ha origine nel 1949 con il Trattato della Nato e nel 1954 con il Trattato bilaterale Italia-Stati Uniti, che ha consentito di mantenere qui le basi militari.
Il secondo binario è quello esplicitamente definito nel 1991 in un Rapporto dal nostro Ministero della Difesa: la guerra fredda è finita, spiega il Ministero, e quindi la nostra funzione anticomunista rispetto all’Europa dell’Est; ora dobbiamo garantirci l’approvvigionamento delle materie prime e delle fonti energetiche, garantire militarmente le vie attraverso le quali queste fonti ci arrivano, e garantire anche le imprese italiane che operano nei Paesi dove sono situate le risorse – quei territori che loro definiscono ‘contesi’ e che noi abbiamo invece visto essere territori massacrati dalle guerre, e dalle seguenti ricostruzioni che sono la fortuna di tanti industriali italiani.
I due binari camminano intrecciati, e questo spiega perché tante volte dimentichiamo. Ora si dice che quella in Ucraina è la prima guerra in cui l’Europa si trova coinvolta dopo settant’anni di pace: non è chiaramente così. Nel 1999 i militari italiani sono andati a bombardare Belgrado, che è nel cuore dell’Europa, e l’hanno fatto senza minimamente concepirsi come se stessero facendo una guerra. Eppure siamo andati lì e abbiamo bombardato, e con le nostre armi potenziate con l’uranio impoverito abbiamo reso inaccessibili per i prossimi 4 miliardi e mezzo di anni intere zone della Serbia, come abbiamo fatto poi in Iraq, Libia, Afghanistan e in tutti i posti dove siamo andati – l’uranio impoverito meriterebbe una serata a parte e su questo non mi dilungo.
Io credo che il punto centrale di questa situazione sia che non vogliamo parlare di guerra perché, in realtà, con le nostre armate militari commettiamo una serie di crimini che sono veri e propri crimini contro l’umanità. Ne abbiamo commessi, del tutto impunemente, in Somalia – qualcuno di voi ricorderà che alcuni militari italiani finirono in tribunale per tortura contro dei cittadini somali, durante la ‘missione di pace’ del 1997 – in Iraq, quando durante la prima Guerra del Golfo del 1991, in quaranta giorni abbiamo buttato l’equivalente di sei bombe atomiche come quella che è stata lanciata su Hiroshima, procurando 200.000 morti tra i civili iracheni e mezzo milione di orfani. In Iraq siamo tornati nel 2003 e abbiamo bruciato Falluja con il fosforo bianco, utilizzando quel tipo di armi vietate e criminalizzate quando sono gli altri a usarle.
Secondo Jim Brown, un veterano americano, il 27 febbraio 1991 abbiamo persino sganciato una bomba atomica di cinque chilotoni al confine con l’Iran, presso Bassora (1). Su YouTube c’è un’inchiesta molto bella di Maurizio Torrealta che vi invito ad andare a vedere, con un’intervista a Jim Brown che racconta come i suoi commilitoni gli abbiano riferito di aver lanciato questa bomba; e c’è una corrispondenza dei sismografi internazionali, che riconoscono che il tipo di terremoto che hanno registrato in quel luogo e momento potrebbe corrispondere a una bomba esattamente di quella grandezza. È stata fatta anche un’inchiesta sulle conseguenze di questo ordigno atomico, in un ospedale di Bassora, dove il 500% in più di bambini sono risultati malati di cancro e leucemia; un medico dell’ospedale ha chiesto formalmente all’Italia di mettere in piedi un’inchiesta epidemiologica, e l’allora Ministro degli Affari Internazionali, Gianni Mattioli, dice a Torrealta: io ero disposto a farla, ma l’Alleanza Atlantica me l’ha proibito.
In questi trent’anni, quindi, abbiamo commesso tante e tali cose che non abbiamo oggi motivo di dire, se non per raccontarci delle menzogne, che quella in Ucraina sia la prima guerra che stiamo vivendo da decenni – peraltro ancora distante, perché non mi pare che stiano cadendo delle bombe sulle nostre teste.
Questa visione è un’idea centrale delle nuove forme dei conflitti: la guerra deve essere permanente, perché è diventata l’unica forma ancora efficiente del sistema produttivo capitalistico. Non facciamo più lavatrici, automobili, frigoriferi… e produciamo invece armi e guerre. Sottolineo che produciamo delle guerre, nel senso che c’è un processo istituzionale della guerra, in mano a imprese private, che produce dei teatri di guerra, produce dei luoghi di lavoro – imprese che ovviamente fanno profitti su questa realtà. Alcuni esempi.
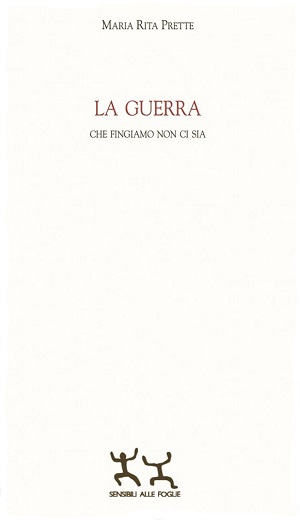
All’inizio del 1991, nella ex Jugoslavia, il governo croato ingaggia un’agenzia di marketing per promuovere l’immagine dei croati a discapito di quella dei serbi. Alla fine dello stesso anno questa società, la Ruder Finn, viene incaricata dal governo bosniaco di fare altrettanto per quel che riguarda la Bosnia, e nel 1992 lavora per i capi albanesi del Kosovo. Non è un fatto occasionale. Possiamo vedere quel che è successo negli ultimi mesi rispetto alla guerra che stiamo facendo in Ucraina contro la Russia: costruiamo un amico con i tratti migliori – chiamiamo ‘resistenti’ gli ucraini, il nostro Presidente della Repubblica ha addirittura fatto riferimento alla Resistenza italiana – e costruiamo soprattutto l’immagine del nemico. Negli ultimi trent’anni abbiamo progressivamente visto rappresentare come un novello Hitler, Saddam Hussein per l’Iraq, Assad per la Siria, di recente Putin, e quando non è possibile identificare una singola figura si costruisce l’immagine del nemico collettivo – i talebani, i miliziani dell’Isis ecc. Costruendo queste figure, si sottrae all’intelligenza sociale collettiva il diritto di discutere su questi ‘amici’ e questi ‘nemici’, perché se lo si fa, se si intende approfondire la realtà, si viene indicati come dei ‘collaboratori’ di quel nemico.
Abbiamo quindi un processo di censura, come di fatto sempre avviene nelle guerre. Lo sottolineo perché facciamo finta di non essere in guerra, ma lo siamo da trent’anni, e quindi sono trent’anni che abbiamo perso il diritto di interrogarci se erano davvero amici o nemici, chi erano gli amici e chi i nemici. Questa costruzione avviene attraverso delle vere e proprie campagne pubblicitarie, ed è alimentata e legittimata da quel processo di mass mediazione di cui si servono i nostri governi (2). Se dobbiamo credere che in tempo di guerra, com’è logico che sia, non c’è informazione ma c’è propaganda, vuol dire che da trent’anni viviamo in Paesi europei nei quali verità l’è morta, non esiste più, ed esiste invece la propaganda; di cui siamo vittime, perché nessuno ci dà le informazioni per farci un’idea di quello che effettivamente sta accadendo.
In Iraq, e in altre guerre, abbiamo avuto dei giornalisti che sono andati a seguire il conflitto. Consideriamo però che nel 1991 gli Stati Uniti hanno deciso che la presenza della stampa nei teatri di guerra dovesse essere regolata. Inizialmente si è lasciata al Dipartimento di Stato americano la scelta di un pool di giornalisti, riferiti a un certo numero di testate, che potessero andare nelle zone di conflitto come se fossero ‘arruolati’, a fianco dei soldati – non andavano in giro per conto loro a vedere quel che accadeva. Questa modalità piacque poco – ci dice Fausto Biloslavo, un giornalista embedded, in un interessante Rapporto che ha scritto per il governo italiano (quindi una documentazione di parte) – perché gli Stati Uniti si rendono conto che questa modalità li espone a critiche e accuse di censura; il Dipartimento di Stato cambia dunque approccio. Inaugura l’“informazione per inondazione”: permette a tutti i giornalisti di andare ai suoi briefing, e li inonda di notizie: vere, false, più o meno verificabili e date in continuazione, talmente tante da rendere inutile ai cronisti l’andare sul campo a vedere che cosa succede. Sono quindi trent’anni che noi non sappiamo quel che accade nei teatri di guerra.
Abbiamo poi le aziende produttrici di armi e le compagnie militari private (3). Rispetto alle guerre del Novecento, mandiamo pochissimi e specializzati soldati al fronte, e anche questa è una direttiva statunitense. Dopo il conflitto del Vietnam, gli USA dissero: mai più una guerra che riporti a casa tutte quelle bare, perché pone l’opinione pubblica contro di noi. Quindi da una parte mettiamo i nostri soldati nelle condizioni di rischiare il meno possibile, dall’altra, poiché nelle guerre ancora conta chi mette gli stivali sul terreno, come dicono i vecchi generali, allora inviamo i contractor. Sono una novità dei conflitti del nostro tempo, perché sono dei mercenari a tutti gli effetti ma non si può dire, altrimenti gli Stati non potrebbero appaltarli nel rispetto delle norme del diritto internazionale che lo vietano. C’è allora una direttiva per stabilire che il contractor è una persona che va sul teatro di guerra non per guadagno personale, ma perché guadagni la compagnia militare che lo invia; non va per partecipare al conflitto, ma per proteggere delle persone che lì si trovano, e se per caso viene coinvolto, se spara a qualcuno, lo fa per difendere quelle persone. Diviene quindi lecito che uno Stato appalti contractor per una guerra.
In Afghanistan c’erano 9.000 soldati americani e 29.000 contractor appaltati al solo Dipartimento di Stato; ce n’erano altrettanti ingaggiati dall’esercito italiano, dalla Gran Bretagna, dai vari Paesi che hanno partecipato a quel conflitto. Che cosa significa questo? Di nuovo, che le vittime designate dalle nuove guerre sono i civili. Abbiamo avuto 7.400 morti tra i militari, in tutta la coalizione e in vent’anni di conflitto: un morto è sempre di troppo, ma analizzando il dato in termini numerici, è un numero bassissimo. Abbiamo però avuto più di 178.000 persone morte.
Le guerre si fanno addirittura contro i singoli individui. Sto parlando dei droni, questi strumenti figli della tecnologia di ultima generazione, che coinvolgono la base Nato di Sigonella in Sicilia, e comportano di fatto un cambiamento antropologico: per la prima volta nella storia dell’umanità, rappresentano infatti la possibilità di uccidere una persona dall’altra parte del pianeta, stando seduti in una stanza, davanti a un computer. Sono utilizzati in due modi.
Il primo: all’interno dei teatri di guerra. Nel 2017, per esempio, in Libia – quindi in un Paese con il quale eravamo in una situazione di belligeranza nascosta, perché non abbiamo mai dichiarato guerra alla Libia – un singolo attacco ha comportato la morte di 900 persone, che ci hanno detto essere miliziani dell’Isis. Chiunque fossero, 900 persone sono morte perché dei militari americani seduti in Nevada hanno fatto alzare dei droni a Sigonella, quindi a casa nostra, li hanno portati sul terreno di guerra, hanno individuato dei bersagli e hanno lanciato dei missili. Quindi noi abbiamo permesso che quei droni – che sono in Europa perché hanno bisogno di essere sul territorio, non possono partire dal Nevada – si alzassero in volo, vedessero e bombardassero. C’è un’organizzazione britannica, di nome Reprieve – mi risulta sia l’unica al mondo ad aver fatto una ricerca su questi attacchi – che afferma che una lista che comprendeva 24 persone da uccidere ha portato alla morte di 847 persone; rileva che solo con gli attacchi sulle liste sono morte tra 3.000 e 4.000 persone in Yemen e in Pakistan, Paesi con cui non siamo mai stati in guerra.
La seconda modalità di utilizzo dei droni è quello che viene chiamato ‘attacco alla firma’: quando con un comportamento firmi la tua condanna a morte. E non esiste nemmeno una regola su quali siano i comportamenti che fanno presupporre che tu sia un terrorista. In Pakistan c’è un paesino, Datta Khel, a 2.000 metri: il 17 marzo 2011 gli anziani si riuniscono in una jirga, un’assemblea pubblica, per decidere su una contesa tra due famiglie in merito a una miniera di cromite. Si siedono all’aperto, in cerchio, nella piazza, com’è loro abitudine. In quel momento, un drone sorvola la zona, e rimanda a un soldato seduto nella sua stanza in Nevada l’immagine di un gruppo di persone che stanno discutendo qualcosa; forse un algoritmo, forse un generale, non lo sappiamo, comunica al militare che quella è una riunione di terroristi, viene dunque armato un drone e polverizzate 42 persone. Questo villaggio, tra l’altro, era filo americano, quindi aveva informato l’esercito pakistano dell’assemblea.
Qui vediamo la stretta connessione tra tecnologia e capitalismo di guerra. Lo stesso legame riguarda i soldati, e trovo anche questo antropologicamente significativo. I soldati sono da sempre trattati in qualche modo – gli si danno droghe e ansiolitici per sopportare lo stress di un teatro di guerra, per inibire il senso etico ecc. – ma quel che viene fatto oggi è molto diverso. Il Dipartimento di Stato americano ha operato su 1.000 avieri e 2.300 soldati per portare la loro vista a 15 decimi; la Darpa, un’agenzia statunitense, studia le modalità per portare le capacità del corpo del soldato a resistere meglio al freddo, al caldo, al dolore (4); abbiamo infine l’ibridazione dei soldati con gli strumenti tecnologici, per esempio il casco del caccia F-35. Tutti abbiamo sentito parlare di questo aereo di ultima generazione, che viene venduto trattenendo il codice sorgente: vuol dire che il velivolo può alzarsi in volo solo se gli Stati Uniti lo permettono. I soldati italiani che si sono addestrati a diventare piloti di F-35 raccontano, in termini entusiastici, l’ibridazione con questo casco: permette loro di vedere con gli occhi dell’F-35, ossia con le telecamere montate a 360° sul caccia, e trasmette delle stimolazioni cognitive al pilota. Siamo quindi in presenza di una manipolazione della persona, ridotta a essere una parte della macchina.
Aggiungo un’ultima cosa: considero molto preoccupante la cultura della guerra in cui siamo stati infilati senza che nessuno lo dichiarasse apertamente. Sono stati fatti dei passi all’interno della nostra società, dentro le nostre istituzioni, per produrla, innanzitutto partendo dalle scuole. Già dal 2014 sono stati stipulati degli accordi tra il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Difesa perché nelle aule andassero generali e militari a insegnare la Costituzione, e si è incentivato il portare i bambini delle elementari in visita alle basi militari – nell’anno scolastico 2015-2016, nella base navale di Augusta (dove ci sono i reattori nucleari sui sottomarini), il comando della Marina militare ha addirittura organizzato una giornata di attività motorie, ludiche e musicali destinata alle scuole primarie, durante la quale i bambini sono stati portati a visitare i sottomarini stessi. Anche nell’alternanza scuola-lavoro i ragazzi delle superiori vengono portati nelle basi militari, e da anni le università italiane hanno significativi finanziamenti da parte della Nato e degli Stati Uniti per progetti che hanno a che fare con le strategie militari. È una cultura che, in sordina, prende sempre più piede.
1) Cfr. Emilio Del Giudice, Piccole bombe nucleari crescono. La fusione fredda e le nuove mini-armi atomiche, Paginauno n. 20, dicembre 2010. Nota di redazione
2) Cfr. Giovanna Cracco, Lo spettacolo della guerra, Paginauno n. 77, aprile 2022. Nota di redazione
3) Cfr. Giovanna Cracco, La prosperità della guerra, Paginauno n. 79, ottobre 2022. Nota di redazione
4) Cfr. Giovanna Baer, DNA e campo militare. La nascita di Capitain America, Paginauno n. 67, aprile 2020. Nota di redazione
* Incontro-dibattito sul libro La guerra che fingiamo non ci sia di Maria Rita Prette (Sensibili alle foglie, 2018), presso il Leoncavallo Spazio Pubblico Autogestito, Milano, 6 novembre 2022


